Che cosa dovrebbe fare un uomo di cultura in tempi di guerra totale?
di Francesco Lamendola - 04/10/2008
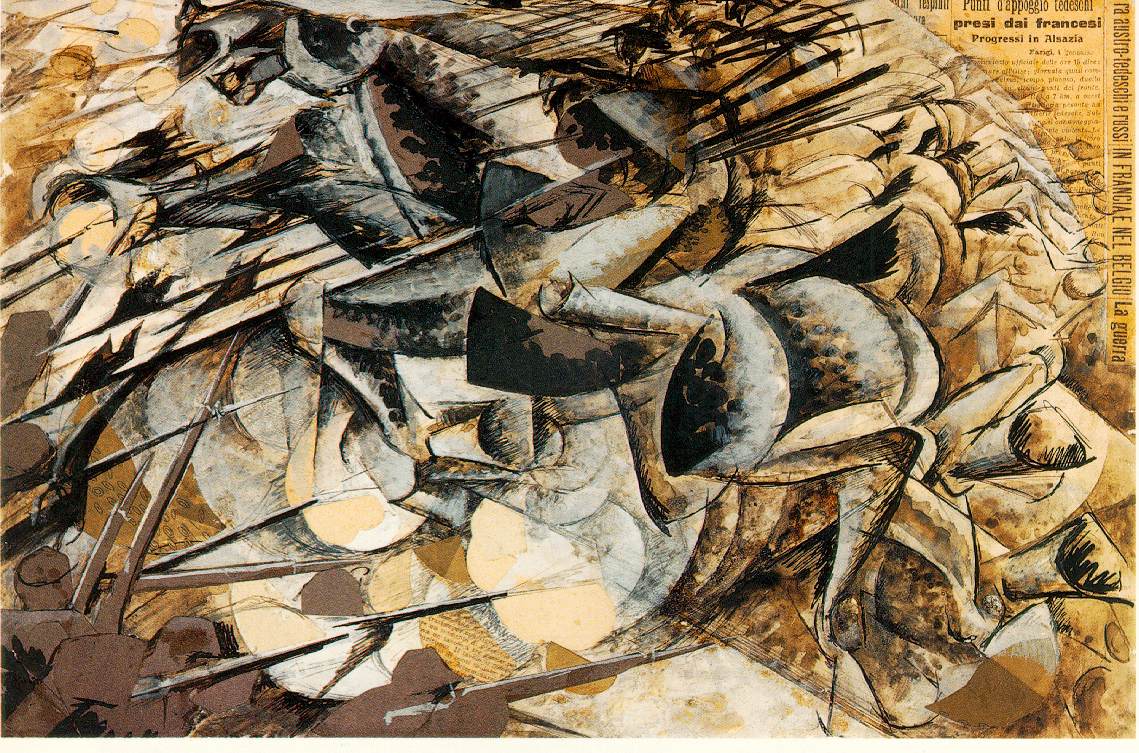
La due guerre mondiali hanno avuto carattere di guerre totali, nelle quali non solo gli eserciti, ma tutte le risorse disponibili degli Stati coinvolti - finanziarie, industriali, scientifiche, tecniche, umane, spirituali - sono state assorbite fino all'ultimo respiro, in uno sforzo senza precedenti di mobilitazione e di coinvolgimento, mirante alla vittoria totale di una delle due parti e alla resa incondizionata dell'altra.
Sì, anche delle risorse spirituali: di conseguenza, anche gli uomini di cultura vengono mobilitati, o - più spesso - si mobilitano spontaneamente, per convincere le proprie nazioni che tutta la ragione sta dalla propria parte, e tutto il torto dalla parte avversa. Non solo: che solo dalla propria parte stanno la morale, i valori, la civiltà, la religione; mentre i nemici non sono altro che una banda di criminali, capace di calpestare ogni norma etica, di commettere qualunque bestialità e bassezza, di infrangere e stravolgere anche il più elementare senso della giustizia.
Quei pochi intellettuali che tentano di fare uno sforzo di obiettività e di ricondurre il pubblico a un maggior senso di equilibrio e a un sincero sforzo verso la pace, vengono bollati come traditori; vengono insultati, calunniati, additati al pubblico disprezzo, linciati moralmente e, talvolta, processati come «disfattisti» (magari al soldo del nemico).
Prendiamo un caso altamente emblematico: quello della prima guerra mondiale.
La cosa più stupefacente è che, fino a quando risuonarono i primi tintinnii delle armi, al princioio di agosto del 1914, il clima culturale dell'Europa appariva completamente diverso. Mai come allora, nella storia moderna, si era assistito a tanto ottimismo, a tanta fiducia nel progresso e nell'avanzata irresistibile della civiltà (accompagnata da una buona dose di orgoglio razziale nei confronti dei cosiddetti «popoli di colore») ; mai come allora gli uomini di cultura, al di là degli angusti confini nazionali e delle miopi politiche imperialiste, erano sembrati affratellati da un autentico spirito cosmopolita, dal senso di appartenenza a una comune eredità spirituale. Mai gli intellettuali europei, dai tempi di Erasmo da Rotterdam, si erano sentiti così legati da stretti vincoli di comprensione e di collaborazione, nonché dalla coscienza di una missione comune da svolgere per il bene dell'umanità.
Tutto andò in fumo nel giro di pochi giorni; di colpo, gli altissimi steccati dell'odio si levarono a separare i popoli dell'Europa gli uni dagli altri, più profondamente ancora - se possibile - di quanto stavano facendo, sul piano materiale, trincee, reticolati e contrapposti schieramenti di artiglieria e di mitragliatrici.
Spicca fra le altre, per il suo coraggio civile e il suo spirito di indipendenza, la posizione dello scrittore francese Romain Rolland (che avrebbe ricevuto il Premio Nobel per la letteratura nel 1915), particolarmente con lo scritto Al di sopra della mischia, di cui riportiamo alcuni passaggi salienti (Romain Rolland, nella collana I premi Nobel per la Letteratura, Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1965, pp. 124-37, passim):
O eroica gioventù del mondo! Con quale prodiga gioia essa versa il suo sangue nell'avida terra! Quale messe di sacrificio viene falciata sotto il sole di questa splendida estate! - Voi tutti, giovani d'ogni nazione che un comune ideale contrappone gli uni altri - slavi che accorrete in aiuto della vostra razza, inglesi che combattete per l'onore e per il diritto, intrepido popolo belga che hai osato tener testa al colosso tedesco e ha i difeso contro di lui le Termopili dell'Occidente, tedeschi che lottate contro il torrente dei cavalieri cosacchi per il pensiero e la città di Kant, e, soprattutto, voi miei giovani compagni francesi che da anni mi confidavate i vostri sogni e, partendo per la linea del fuoco, mi avevate inviato il vostro sublime addio, voi che fate rifiorire la stirpe degli eroi della Rivoluzione -, quanto mi siete cari, voi che andate a morire! Come ci vendicate degli anni di scetticismo e di gaudente vigliaccheria in cui siamo cresciuti, proteggendo dai loro miasmi la nostra e la vostra fede, che con voi trionfa sui campi di battaglia! Guerra «di rivincita»,è stato detto… E, in effetti, è «di rivincita», ma non nel senso inteso da uno sciovinismo mentalmente ristretto, bensì di rivincita della fede contro tutti gli egoismi dei sensi e dello spirito, dono assoluto di sé alle idee eterne. (…)
Amici miei, che nulla turbi dunque la vostra gioia! Quale che sia il vostro destino, voi avete raggiunto le vette della vita e ad esse avete innalzato la patria. L'abnegazione, l'intrepido spirito, la fede assoluta nella vostra sacra causa, l'incrollabile certezza di difendere la libertà del mondo difendendo la vostra terra invasa, mi rendono certo della vittoria, giovani eserciti della <marna e della Mosa, il cui nome è scolpito nella storia vicino a quello dei vostri antenati della Grande Repubblica. Ma quand'anche la sventura volesse che voi, e con voi la Francia, foste sconfitti, una morte del genere sarebbe la più bella che una razza possa sognare, coronerebbe la vita del grande popolo delle crociate, sarebbe la sua suprema vittoria… Vincitori o vinti, vivi o morti, siate felici! Come ha detto uno di voi, «abbracciandomi stretto, sulla terribile soglia»:
«È bello battersi con le mani pure e il cuore innocente, e fare con la propria vita la giustizia divina» (Luois Gillet).
Voi fate il vostro dovere; ma gli altri, l'hanno fatto?
Osiamo dire la verità ai più anziani di questi giovani, alle loro guide morali, a coloro che ne influenzano l'opinione, ai loro capi religiosi o laici, alle Chiese, ai pensatori, ai tribuni socialisti.
Avevate nelle mani queste ricchezze viventi, questi tesori d'eroismo, e che cosa ne fate? Quale scopo avete offerto alla magnanima dedizione di questa gioventù avida di sacrificarsi? La strage reciproca di giovani eroi! La guerra europea, questa sacrilega mischia che offre lo spettacolo di un'Europa demente, pronta a salire sul rogo, dilaniandosi, come Ercole, con le sue stesse mani!
Così i tre più grandi popoli dell'Occidente, i custodi della civiltà, si battono per la loro stessa rovina, e chiamano alla riscossa i cosacchi, i turchi, i giapponesi, i cingalesi, i sudanesi, i senegalesi, i marocchini, gli egiziani, i sikh e i cipay, i barbari del polo e quelli dell'equatore, le anime e le pelli di tutti i colori! Si direbbe che rivivono i tempi della tetrarchia allorché, per divorare se stesso, l'impero romano fece appello alle orde di tutto l'universo!…La nostra civiltà è dunque tanto solida che non avete nessun timore a scuoterne i pilastri? Non vedete che tutto vi crollerà addosso se cadrà una sola colonna? Era dunque impossibile giungere, se non ad amarvi, a sopportarvi reciprocamente, ciascuno con le sue grandi virtù e i suoi grandi difetti? E non avreste dovuto sforzarvi di risolvere in spirito di pace (non l'avete, sicuramente, nemmeno tentato) i problemi che vi dividevano - quelli dei popoli annessi contro la loro volontà - e l'equa divisione del fecondo lavoro e delle ricchezze del mondo? Bisogna proprio che il più forte sogni eternamente di far pesare la sua ombra sugli altri, e che gli altri eternamente s'uniscano per abbatterlo? Tale gioco puerile e cruento nel quale i concorrenti hanno posizione di secolo in secolo, non avrà mai fine se non con l'estinzione totale dell'umanità?
I capi di Stato, lo so, i criminali fautori delle guerre, non osano assumersene la responsabilità: ognuno di essi si sforza di gettarne il peso sull'avversario. E i popoli si lasciano condurre, docili, e si rassegnano dicendo che tutto ciò è la volontà di una forza superiore a quella degli uomini. Una volta di più sentiamo il secolare ritornello: «Fatalità della guerra, più forte d'ogni volontà» - vecchio ritornello delle greggi, che della loro debolezza fanno una divinità e l'adorano. Gli uomini hanno inventato il destino per attribuirgli le calamità dell'universo che avrebbero avuto il dovere di governare. Niente fatalità! La fatalità è ciò che vogliamo; e ancora più spesso è ciò che non sappiamo abbastanza volere. In questo momento, ciascuno reciti il mea culpa! L'élite intellettuale, le Chiese, i partiti operai… nessuno ha voluto la guerra… e sia! Ma che cosa hanno fatto per impedirla? Che fanno per attenuarla? Alimentano l'incendio. Ciascuno porta il proprio fascio di legna.
L'aspetto più impressionante di questa mostruosa epopea, il fatto senza precedenti è, in tutti i paesi belligeranti, l'unanimità in favore della guerra.. è come un contagio di furore omicida giunto da Tokyo dieci anni orsono che, che simile a un'immensa ondata, si diffonde e infetta tutta la terra: nessuno ha resistito all'epidemia, nessuna libertà di pensiero è riuscita a preservarsi dalla rovina. Una specie d'ironia demoniaca sembra sovrastare questa mischia di popoli, da cui, quale che sia l'esito finale, l'Europa uscirà mutilata non sono soltanto le passioni razziali a spingere ciecamente gli uni contro gli altri milioni di uomini, come formicai, e di cui gli stessi pesi neutrali risentono la scossa minacciosa; la ragione, la poesia, la fede, la scienza, tutte quante le forze dello spirito, sono mobilitate, e in ogni Stato sono al servizio degli eserciti. Nell'élite di ciascun paese, tutti proclamano e sono convinti che a causa del loro popolo è la causa di Dio, della libertà e del progresso umano. E lo proclamo anch'io…
I metafisici, i poeti, gli storici si abbandonano a singolari dispute: Eucken contro Bergson, Hauptmann contro Materlinck, Rolland contro Hauptmann, Wells contro Bernard Shaw. Kipling e D'Annunzio, Dehmel e de Régner cantano inni di guerra; Barrés e Materlinck intonano peana d'odio. Mentre l'organo passa da una fuga di Bach a Deutschland über Alles, l'ottantaquattrenne filosofo Wundt incita gli studenti di Lipsia alla «guerra sacra» con voce rotta dall'emozione. E tutti reciprocamente chiamano gli altri «barbari». (…)
Ma le due potenze morali di cui questa guerra contagiosa ha maggiormente svelato la debolezza, sono il cristianesimo e il socialismo. Questi apostoli rivali dell'internazionalismo religioso o laico hanno improvvisamente dimostrato di essere i più
Ardenti nazionalisti. Hervé chiede di morire per la bandiera di Austerlitz. I puri depositari della dottrina pura, i socialisti tedeschi, votano i crediti di guerra al Reichstag, si mettono agli ordini del ministero prussiano, che utilizza i loro giornali per diffondere fin nelle caserme le sue menzogne e li spedisce come agenti segreti a tentar di corrompere il popolo italiano. (…)
Per quanto riguarda i rappresentanti del Principe della Pace, preti, pastori, vescovi., li vediamo tutti correre verso la mischia e mettere ij pratica, con il fucile in pugno, le parole divine: «Non ammazzare» e «Ama il prossimo tuo».Ogni bollettino vittorioso degli eserciti tedeschi, austriaci o russi, ringrazia il maresciallo Dio: unser alter Gott, il nostro Dio, come dicono Guglielmo II o Arthur Meyer. Ciascuno ha il suo Dio; e ogni Dio, vecchio o giovane, ha i suoi leviti che lo difendono e abbattono il Dio degli altri.
Ventimila preti francesi sono sotto le armi. I gesuiti offrono i loro servigi agli eserciti tedeschi. I cardinali lanciano pastorali bellicose I vescovi serbi dell'Ungheria spingono i fedeli a combattere contro i loro fratelli della Grande Serbia. Senza stupirsene, i giornalisti riportano la paradossale scena dei socialisti italiani che acclamano, alla stazione di Pisa, i seminaristi in partenza per raggiungere i loro reggimenti, e tutti insieme cantano la Marseillaise. Il ciclone è così forte che li travolge tutti, perché sono così deboli gli uomini in cui s'imbatte, e io non meno degli altri…
Orsù, riprendiamoci! Qualunque sia la natura e la virulenza del contagio - epidemia morale o forze cosmiche -, non è possibile resistergli? O invece ci inchineremo davanti ad essi, soddisfatti, come l'onorevole Luigi Luzzatti, nel sui famoso articolo: «Nel disastro universale, le patrie trionfano?». Ci assoceremo a lui per comprendere che «questa grande e semplice verità», l'amor di patria, è buono ed è bene che «si scateni il demone delle guerre internazionali, che stroncano migliaia di esseri?». Così, l'amor di patria potrebbe fiorire soltanto sull'odio delle altre patrie e sul massacro di coloro che le difendono? In questa affermazione c'è una feroce assurdità e un dilettantismo neroniano che mi ripugnano, che mi sconvolgono nel profondo del mio essere. No, l'amore della mia patria non esige che io nutra odio e uccida le anime pie e fedeli che amano le altre patrie, esige che io le onori e cerchi d'unirmi con loro per il bene comune. (…)
Il nemico peggiore non è al di là delle frontiere, ma all'interno di ogni nazione, e nessuna di esse ha il coraggio di combatterlo. È un mostro che si chiama imperialismo, è la volontà d'orgoglio e di dominio che vuole assorbire o sottomettere o abbattere tutto, che non tollera alcuna libera grandezza. Il più pericoloso per noi occidentali, quello che minacciava l'Europa e l'ha costretta ad unirsi in armi contro di lui, è l'imperialismo prussiano, espressione di una casta militare e feudale, rovina non solo del mondo ma della stessa Germania di cui ha sapientemente avvelenato il pensiero. È il primo che bisognerà distruggere: ma dopo toccherà allo zarismo. Più o meno, ogni popolo ha il suo imperialismo; qualunque sia la forma che assume - militare, finanziaria, feudale, repubblicana socialista, intellettuale - essa è la piovra che succhia il sangue migliore dell'Europa. (...)
Ma tutti noi, artisti e scrittori, preti e pensatori, abbiamo un altro compito: anche nel corso di una guerra, è un delitto per un'élite compromettere l'integrità del proprio pensiero. (…)
Élite europea, abbiamo due cittadelle: la nostra patria terrestre e la Città di Dio. Dell'una siamo gli ospiti, dell'altra i costruttori. Doniamo i nostri corpi e i nostri cuori fedeli alla prima; ma niente di ciò che amiamo - famiglia, amici, patria -, niente ha diritto sullo spirito. Lo spirito è la luce, e il nostro dovere è di elevarlo al di sopra delle tempeste e di scacciare le nuvole che tentano di oscurarlo. Il nostro dovere è di costruire più largo e più alto, ,tanto da dominare l'ingiustizia e gli odi tra le nazioni, il muro che cinge la città in cui devono unirsi le anime fraterne e libere del mondo interro.
Come si vede, non mancano in questo scritto alcuni aspetti che, alla luce della nostra sensibilità di cittadini del terzo millennio, stonano e stridono. Fra gli altri, l'etnocentrismo che porta l'Autore a definire «barbari» (e sia pure per istituire un parallelismo con la rovina della civiltà antica) i popoli exutraeuropei; e l'individuazione del «male assoluto» nel militarismo prussiano, ciò che ricorda l'odierna pretesa del governo degli Stati Uniti di esportare ovunque la democrazia, con le buone o con le cattive…
Nel complesso, però, è impossibile non percepire, ancora oggi e a distanza di tanti eventi storici sconvolgenti (tra i quali un secondo conflitto mondiale ancora più terribile del primo, e, attualmente, la minaccia di olocausto nucleare che incombe sull'umanità) l'evidente buona fede, l'evidente sforzo di equanimità, lucidità di giudizio e onestà di intenti in questo scrittore che, quasi unico nell'Europa del 1914, mise a repentaglio la sua reputazione per spendere una parola di pace, in un mondo letteralmente impazzito dal furore bellicista.
L'eco che destò Al di sopra della mischia fu, in effetti, enorme; e diede coraggio e speranza a quella maggioranza silenziosa che la guerra non aveva voluta; nonché una salutare sferzata in pieno viso a quella turba di intellettuali scalmanati e guerrafondai, che avevano totalmente abdicato alla loro naturale funzione di intermediari di civiltà e dialogo fra i popoli d'Europa.
Così rievoca il clima di quei giorni lo scrittore austriaco Stefan Zweig nel suo bel libro Il mondo di ieri (titolo originale: Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers, traduzione italiana di Lavinia Mazzucchetti, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1994, pp. 193-94):
Già nell'autunno del 1914, quando quasi tutti gli scrittori andavamo a gara nell'urlarsi l'un l'altro parole d'oro, egli [Rolland] aveva formulato una professione di fede, Al di sopra della mischia, in cui condannava l'odio intellettuale tra le nazioni ed esigeva dall'artista umanità ed equità anche in piena guerra, uno scritto che più d'ogni altro di quel tempo eccitava gli animi e provocò tutta una letteratura polemica.
Una differenza infatti staccava quella prima guerra mondiale dalla seconda: la parola allora aveva ancora potere. Non era stata ancora calpestata a morte dalla menzogna organizzata, dalla «propaganda»; gli uomini ascoltavano ancora la parola scritta, ancora l'attendevano. Mentre nel 1939 non vi fu manifestazione di poeta che avesse la minima efficacia né in bene né in male, mentre sino ad oggi nessun libro, nessun articolo, nessuna poesia ha toccato profondamente le masse e tanto meno ne ha influenzato il pensiero, nel 1914 una poesia come il Canto dell'odio di Lissauer [contro la Gran Bretagna], una manifestazione come quella stolta dei «novantatré intellettuali tedeschi» e d'altra parte un saggio di otto pagine come Al di sopra della mischia di Rolland, o un romanzo come Il fuoco di Barbusse divennero grandi eventi. La coscienza morale del mondo non era così stanca ed esausta come oggi, e ad ogni manifesta menzogna, ad ogni offesa del diritto delle genti e dell'umanità reagiva intensamente con tutta la forza di una convinzione scolare. Un'offesa al diritto come la violazione tedesca del Belgio neutrale , che oggi, da quando Hitler ha fatto della menzogna la norma e dell'antiumanità la legge, sarebbe appena biasimata valse allora a commuovere il mondo da un capo all'altro. La fucilazione di miss Cavel, il siluramento del Lusitania, divennero per la Germania più fatali di una battaglia perduta, grazie allo scoppio di indignazione morale di tutto il mondo. Per un poeta, per uno scrittore non era quindi affatto vano dire una sua parola, poiché le orecchie e le anime non erano ancora intontite dalle onde ininterrotte della radio verbosa; al contrario, la manifestazione spontanea di un grande poeta aveva maggiore efficacia che non i discorsi ufficiali degli uomini di Stato, che ben si sapevano compilati con tattica politica per una data ora e che non potevano contenere che una mezza verità. Anche per questo aspetto della fiducia nel poeta quale ottimo mallevadore di pura mente, quella generazione possedeva una fede molto più fervida di quella, troppo delusa, che la seguì. Ma appunto perché riconoscevano l'autorità dei poeti, i militari e le alte cariche cercavano di prendere ai loro servizi di propaganda uomini di prestigio morale e spirituale affinché spiegassero, dimostrassero, confermassero e proclamassero che tutto il male era accumulato sull'altra sponda, e tutta la verità e la giustizia appartenevano alla propria nazione. Con Rolland non vi riuscirono: egli non vide il suo dovere nel rendere ancora più afosa e irrespirabile l'atmosfera d'odio, pregna già di tutti gli eccitanti, ma al contrario nel cercare di purificarla.
Chi rilegga oggi le poche pagine di quel celebre saggio Al di sopra della mischia non riuscirà forse a comprendere l'immensità della sua efficacia, tutto quello che Rolland ivi formula come postulato, se letto con mente lucida e calma, appare come la più naturale delle verità. Ma quelle parole furono pronunciate mentre infuriava la follia di massa oggi appena ricostruibile. I superpatrioti francesi quando apparve quell'articolo diedero in ismanie ed urlarono come se avessero preso in mano senza accorgersi un ferro rovente. Da un giorno all'altro Rolland fu boicottato dai suoi più antichi amici, i librai non osavano più esporre in vetrina Gian Cristoforo; le autorità militari, che avevano bisogno d'odio come stimolante per i soldati, meditavano misure contro di lui, mentre si susseguivano le risposte basate più o meno sull'argomentazione: «Quel che durante la guerra si dà all'umanità, è rubato alla patria». Come sempre, grida e proteste dimostrarono soltanto che il colpo aveva toccato il segno. La discussione sul contegno dell'intellettuale in tempo di guerra era ormai aperta e non poteva esser fermata; il problema era inevitabilmente posto per ogni coscienza.
Il problema era stato posto: ma, a tutt'oggi, non ha trovato ancora una risposta adeguata.
Due principi sono in lotta fra loro: il bene della patria e il bene dell'umanità; due dimensioni della vita si affrontano - in tempi di guerra totale - senza possibilità di mediazione: l'etica e la politica; due sistemi di leggi, ugualmente cogenti e imperiosi: quelle della coscienza individuale e quelle della società organizzata cui si appartiene.
Il problema è immenso, e noi non pretendiamo certo di poterlo affrontare e risolvere in modo adeguato nello spazio di poche righe. Per quel che riguarda il rapporto reciproco tra la sfera dell'etica e quella della politica, ci riserviamo di riprenderne la discussione in una sede apposita; poiché la questione del ruolo dell'intellettuale in una guerra totale non è che un caso particolare della difficoltà di delimitare confini e attribuzioni reciproci alle due sfere dell'etica e della politica: problema tipicamente moderno, posto, infatti (con opposte soluzioni), dai due grandi campioni dello spirito rinascimentale: Erasmo da Rotterdam e Niccolò Machiavelli.
Qui ci limiteremo ad alcune brevissime riflessioni di ordine generale.
Innanzitutto, è impossibile decidere che cosa dovrebbe fare l'uomo di cultura in un caso così estremo e drammatico, come il trovarsi coinvolto in un conflitto totale, se non si è elaborata a priori una concezione dell'uomo in quanto tale, che sia chiara, rigorosa, coerente.
L'uomo di cultura, evidentemente, non è altro che un caso specifico del genere «uomo»: e da ciò che pensiamo dell'essere umano in sé stesso, dipende quel che possiamo o non possiamo aspettarci dall'uomo di cultura in un simile frangente; se, cioè, sia ragionevole aspettarci da lui una parola di pace, «al di sopra della mischia».
Se crediamo che l'uomo sia una scimmia evoluta a caso e diretta verso il nulla, allora è difficile immaginarsi che l'uomo di cultura possa sentirsi moralmente impegnato, anche in circostanze così estreme e drammatiche, a un dovere che travalichi l'ambito del contingente e del relativo. È difficile immaginare che possa ergersi al di sopra delle passioni del momento e possa additare il bene primario della pace universale, la composizione amichevole dei conflitti e il rasserenamento degli animi.
L'uomo di cultura, infatti, non è necessariamente un uomo superiore; inoltre, non basta aver letto quattro libri o aver scritto un paio di poesie per potersi definire «uomini di cultura». Il vero uomo di cultura è l'espressione di una aristocrazia dello spirito; però, se si vede l'uomo come un mammifero un po' meno peloso, ma ugualmente accidentale di qualsiasi altro, e lo si pensa come un viaggiatore diretto verso il nulla, è un'ipocrisia parlare dello spirito e dei suoi valori.
Se l'uomo è un animale e se tutto ciò che esiste, esiste per una sorta di scherzo del destino, allora non c'è nessuno spirito, nessuna trascendenza che possa giustificare il richiamo a qualche cosa di più alto delle necessità immediate: e, in una guerra che impegna la nazione fino all'ultimo respiro, non esiste necessità più impellente di quella di vincere.
Vincere a qualunque costo, e con qualsiasi mezzo: anche a prezzo della menzogna più spudorata. Allora aveva ragione Machiavelli, e torto Erasmo: il fine giustifica i mezzi, la morale deve cedere alle ragioni della politica.
Se, viceversa, pensiamo che l'uomo sia una persona, originata da un progetto sapiente e amorevole e destinata ad un compimento eterno, allora dobbiamo anche ammettere che ogni uomo, compreso l'intellettuale, è un soggetto dotato di libero arbitrio e di doppia cittadinanza: terrena e celeste. Egli, cioè, vive contemporaneamente su due piani o livelli di esistenza: quello del finito e del relativo, nel quale dirige le sue attività pratiche (a cominciare da quelle che gli assicurano la sopravvivenza, e che non sono necessariamente da intendersi come una «lotta»); e quella dell'assoluto e dell'eterno, che costituisce la sua nostalgia profonda e la sua meta finale.
L'uomo di cultura, caso particolare del genere «persona», potrebbe - e dovrebbe - distinguersi in questo dalla massa incolta: dal fatto di avere ben chiara la doppia natura della condizione umana e, quindi, dal non perdere mai di vista la dimensione dell'assoluto e dell'eterno, a vantaggio di quella del relativo e del contingente. Mai, e specialmente nelle circostanze «forti» della vita: quelle in cui si vede di che stoffa siamo fatti, allorché i più furiosi venti di tempesta ci investono e ci scuotono, come fossimo fragili canne.
L'uomo di cultura non è colui che ha letto o scritto un certo numero di libri, o che ha ricevuto dalla società un attestato legale della sua competenza (docenze universitarie, direzione di un giornale o di una casa editrice), bensì colui che ha saputo trasformare in linfa viva il suo sapere, ossia in un più alto grado di umanità. E possedere un più alto grado di umanità vuol dire anche, secondo quanto abbiamo detto innanzi, avere una più acuta consapevolezza della propria doppia cittadinanza, nonché sentire il dovere morale di ricordarla agli altri.
Ora, quando vi è maggior bisogno che qualcuno ricordi agli esseri umani la loro parte spirituale ed eterna, se non quando, nella brutale esaltazione della guerra, tutto cospira per ridurli alla sola dimensione del relativo e del contingente, presentando come valori universali ed eterni delle mete che sono soltanto il camuffamento dei sacri egoismi nazionali - cioè, sul piano generale dell'umanità, delle cose ben piccole e, in fondo, meschine?
Il vero uomo di cultura, pertanto, è colui che vigila, come una sentinella, quando tutti gli altri dormono; che li riscuote, quando tutti giacciono in preda ai fumi dell'ubriachezza; che addita loro la parte migliore e più nobile di sé stessi, quando si prostrano ad adorare la parte più bassa, triviale e meschina: quella delle passioni scatenate, dell'odio e del desiderio di distruzione.
Questo ci si può, e ci si deve attendere, che egli faccia; e non altro.


