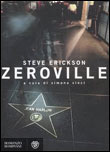Zeroville
di Igino Domanin - 05/12/2008
La nostra vita quotidiana è saturata dalle immagini. La vita percettiva, quella che si svolge anonima e impulsiva nelle pieghe della carne, è sempre più diretta e sollecitata dai dispositivi tecnologici. Guardiamo sempre più le immagini e sempre meno le cose. Lo schermo si sostituisce al paesaggio.
Il romanzo di Steve Erickson dal titolo emblematico ![]() Zeroville (Bompiani, a cura di Simona Vinci, € 19.50) ambientato in un non-luogo come Hollywood, in una California che sembra essere un gigantesco set più che un territorio geografico, può essere considerato come un esempio, in forma narrativa, che illustra e simboleggia la profondità radicale di questo mutamento antropologico dello sguardo. Potrei dire che in questo libro sia deliberatamente presente una specie di premessa epistemologica su ciò che è diventato il regime della visione contemporaneo. La presenza di una tesi di questo genere non deve disturbare il lettore più di tanto.
Zeroville (Bompiani, a cura di Simona Vinci, € 19.50) ambientato in un non-luogo come Hollywood, in una California che sembra essere un gigantesco set più che un territorio geografico, può essere considerato come un esempio, in forma narrativa, che illustra e simboleggia la profondità radicale di questo mutamento antropologico dello sguardo. Potrei dire che in questo libro sia deliberatamente presente una specie di premessa epistemologica su ciò che è diventato il regime della visione contemporaneo. La presenza di una tesi di questo genere non deve disturbare il lettore più di tanto.
L’aspetto teorico non è estraneo al questo tipo di pratica narrativa. Al contrario, lo stile di Erickson, che è un narratore avantpop allo stato puro, si caratterizza per una narrazione dove la contaminazione saggistica e il gusto iperbolico della digressione regnano sovrani.
Il protagonista di Zeroville si chiama Vikar, sul suo cranio sono tatuati i volti di Elizabeth Taylor e Montgomery Clift in una scena tratta dal film di George Stevens Un posto al sole.
Vikar porta questa citazione visiva sulla sua carne, come se diventasse egli stesso, tramite il supporto della pelle, uno schermo per mostrare agli altri una visione. Tutto il suo destino pare inscritto nell’immagine enigmatica, uno screenshot, che brilla sul suo corpo come un’escrescenza luccicante e mostruosa. L’immagine ha agito come un virus e adesso è diventata carne. Vikar non ha una personalità distinguibile dalle immagini cinematografiche che ha visto e che si sono insediate in lui. Non sappiamo niente della sua personalità se non tramite i film che ha visto.
Vikar, però, non è propriamente un cinefilo, non ha una coscienza critica. Quello che ha visto si è calato nella sua interiorità in modo subliminale e adesso fluttua liberamente nella sua anima. La sua vita interiore è definitivamente collassata nell’esteriorità della pellicola.
La sfida affascinante e suggestiva di Erickson sta proprio nella costruzione del personaggio. Tutta la sua vita psichica è dominata dalle immagini del cinema che hanno una consistenza puramente onirica. Erikson narra gli avvenimenti mescolando continuamente i fatti con le visioni. La stessa realtà storica – siamo a Hollywood sul finire degli anni Sessanta, tra flower power satanismo e guerra del Vietnam - entra in scena solo tramite evocazioni mediatiche, meri fantasmi di suoni e di apparizioni, e senza contestualizzazioni precise. Tutto accade soltanto nella proiezione suggestiva dello schermo. La trama è costruita attraverso una successione di brevi sequenze, che rinviano quindi alla possibilità del montaggio e una logica tutta cinematografica piuttosto che letteraria, e che, però, a un certo punto interrompono il loro corso lineare e invertono la loro direzione.
L’abilità di Erickson è molto alta nel dipanare le vicende labirintiche del vagabondaggio di Vikar e nel dare forma lentamente alle apparizioni decisive delle donne della sua vita, la moglie Soledad e la figlia Zazi. L’intreccio è quasi metafisico, ma complessivamente divertente, se si ha la pazienza di adattarsi al gioco psichedelico ordito dallo scrittore.
Siamo in presenza, quindi, di un romanzo costruito volutamente su un paradigma teorico. Ma l’esito della narrazione fino a che punto tollera l’introduzione di questi corpi estranei? L’operazione, a mio giudizio, funziona nella misura in cui è dettata da una molla libidinale, mentre perde d’efficacia laddove tende a sovrapporsi alla prepotenza necessaria dell’immaginario artistico. Nella letteratura avantpop troppo spesso, però, è questo secondo aspetto a presentarsi. Molta bravura, molta tecnica, molti spunti per l’evoluzione del romanzo, ma alla fine se ne esce con l’impressione che appunto si tratti di una versione edulcorata e postmoderna dello sperimentalismo avanguardistico, e che trionfi una interpretazione nichilistica della funzione della narrativa.
Il testo di Erickson è molto interessante anche per valutare le prospettive contemporanee del romanzo americano di derivazione avantpop. Anche in questo caso, l’eccessiva e programmatica intelligenza dell’autore, a tratti, diventa invasiva e rende il meccanismo narrativo troppo calcolabile. Il rischio del manierismo, pur ironico e raffinato, talvolta incombe così come accade in altri esempi di questo tipo di romanzo americano, che tutto deve alla magistrale lezione di Pynchon. Ma Zeroville, alla fine, resta un libro da leggere e, spesso, da godere. Sequenza per sequenza.