Un film al giorno: «La coda del diavolo», di Giorgio Treves (1987)
di Francesco Lamendola - 16/12/2008
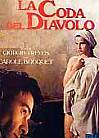 Quando uscì nelle sale cinematografiche il film dell'esordiente Giorgio Treves - era il 1987, poco più di venti anni fa - l'opinione pubblica mondiale era sotto shock per il dilagare misterioso e apparentemente inarrestabile dell'A.I.D.S. (o, per dirla alla francese, e soprattutto all'italiana, della S.I.D.A.: «sindrome da immunodeficienza acquisita»).
Quando uscì nelle sale cinematografiche il film dell'esordiente Giorgio Treves - era il 1987, poco più di venti anni fa - l'opinione pubblica mondiale era sotto shock per il dilagare misterioso e apparentemente inarrestabile dell'A.I.D.S. (o, per dirla alla francese, e soprattutto all'italiana, della S.I.D.A.: «sindrome da immunodeficienza acquisita»).
Perciò, nella storia del medico che s'innamora di una sua paziente, presunta malata di sifilide ma forse costretta ad entrare sana nel lazzaretto, non era certo difficile vedere una metafora della cosiddetta «peste del XX secolo» e, soprattutto, dei suoi effetti psicologici e sociali; e, benché l'opera prima di Treves sia una meditazione su un problema di carattere generale, quello del rapporto fra il potere repressivo e la malattia come fatto sociale, probabilmente essa venne letta un po' troppo in chiave di attualità storica.
Solo così, crediamo, si spiega la rapidità con la quale questo interessante lungometraggio di oltre un'ora e mezza (96 minuti) è stato archiviato dalla critica e dal pubblico, tanto da non essere più riproposto - a quel che ci risulta - nemmeno sulle principali reti televisive, pur così prodighe di seconde, terze e quarte visioni di tanti film assai meno interessanti e originali.
Siamo in un luogo imprecisato, un altopiano di montagna ove si parla il francese - che potrebbe essere la Savoia -, verso la fine del XV secolo.
Un giovane medico di nome Robert Briand (l'attore Robin Renucci) dirige il piccola lazzaretto di St. Clément, che ospita un gruppo di lebbrosi, con l'aiuto della svelta e intraprendente governante del luogo, Teresa, che è anche sua amante (Piera Degli Esposti).
Ma, come se non bastasse la lebbra, un nuovo flagello si annuncia all'orizzonte: la sifilide, il «mal francese», malattia che si trasmette attraverso il contatto sessuale e che, perciò, viene vista dalla cultura del tempo come il classico castigo divino nei confronti di coloro che si abbandonano alla sregolatezza e al peccato della lussuria. Le autorità e la chiesa, da cui il lazzaretto dipende, praticano una severa politica repressiva nei confronti dei questo nuovo genere di malati, in cui alla segregazione si accompagnano le frustate e i maltrattamenti, nonché la minaccia degli eterni castighi ultraterreni.
Un giorno arriva a St. Clément un gruppetto composto, appunto, da sei malati di sifilide, di entrambi i sessi. Tra essi c'è una ragazza giovanissima dalla bellezza conturbante, Marie Blanche (l'esordiente attrice francese Isabelle Pasco, classe 1966, dunque appena ventenne), che attira subito l'attenzione di Robert e che, sottoposta ad esami, sembra essere in realtà immune dal contagio. Il suo corpo, dalla bellezza statuaria, non presenta le caratteristiche piaghe della malattia venerea; le ragioni per le quali è stata avviata al lazzaretto, insieme agli altri, sembrano essere principalmente la sua condizione di orfana e la pratica del vagabondaggio e della prostituzione occasionale. In altre parole, il suo ha le caratteristiche tipiche di un caso di marginalità sociale che diviene pregiudizio contro la «diversità» e pretesto per la detenzione.
Fra gli ospiti del lazzaretto e i nuovi arrivati, intanto, si instaura un clima di tensione e di forte diffidenza: i lebbrosi temono il contagio e costringono i sifilitici a vivere isolati, curiosa forma di segregazione nella segregazione.
Robert subisce il fascino di Marie Blanche, giorno dopo giorno; e, dapprima, fa in modo di ottenerle qualche piccolo privilegio, come quello di coprirsi con un mantello e di usufruire di qualche minuto d'aria nel corso della giornata; poi, nonostante la crescente gelosia della sua amante, Teresa, finisce per gettarsi dietro le spalle il rapporto distaccato medico-paziente e per vivere in piena consapevolezza i propri sentimenti verso la bella sconosciuta, pur attanagliato da laceranti sensi di colpa.
La presenza di Marie Blanche, comunque, ha provocato un ulteriore scompiglio anche fra i ricoverati. Uno di loro ha tentato di violentarla, ma è stato ucciso dai suoi stessi compagni; mentre il ricoverato Laurent diffida tutti quanti dal ritentare un'impresa del genere.
Robert è sempre più in crisi con se stesso: sente che la situazione gli sta sfuggendo di mano e, uomo del suo tempo, giunge ad autoflagellarsi, ma inutilmente, per cercare di liberarsi dalla fatale attrazione nei confronti di Marie Blanche. Tuttavia, né questi metodi drastici di autodisciplina, né la gelosia di Teresa, né - infine - la presenza di una fascinosa nobildonna, Eleonore (Carole Bouquet), che il marito tradito ha fatto rinchiudere come malata di sifilide, riescono a liberarlo dalla sua passione «proibita».
Ci prova allora il padre del giovane medico, personaggio socialmente influente (Erland Josephson), il quale ha in progetto di far trasferire il figlio a Parigi per fargli assegnare un incarico più prestigioso, e che tenta di distoglierlo dai suoi progetti di fuga, ammonendolo sulla gravità delle conseguenze cui potrebbe andare incontro.Ma tutto è inutile.
Robert, dopo molte difficoltà, è riuscito a leggere l'incartamento giudiziario riguardante la sua amata e apprende che le disavventure di lei avevano avuto inizio da quando era stata fatta oggetto di attenzioni sessuali da parte di un personaggio che, ormai, è precipitato nella follia e sopravvive come una specie di spettro. Aiutato da un altro medico, Robert compie ulteriori sforzi per accertarsi delle reali condizioni di salute di Marie Blanche, ma di nuovo gli esiti si rivelano negativi. Secondo tutte le evidenze, ella non è affatto malata; tuttavia, non esiste alcuna speranza di farla dimettere dal lazzaretto, in quanto ormai è bollata come malata contagiosa e, quindi, pericolosa per la comunità dei «sani».
A questo punto, a Robert non rimane altra via che quella di organizzare la fuga della sua paziente e anche la propria, poiché non può immaginare di separarsi da lei e ritiene di avere una responsabilità nei suoi confronti, dato che ella non saprebbe dove andare e come sopravvivere, senza rischiare di essere nuovamente presa e, forse, di subire un trattamento ancora più duro.
Parlando con la ragazza, in un primo tempo riesce a convincerla della necessità di tentare l'evasione, ma si scontra contro il muro di gomma della sua invincibile abulia, come se, in fondo, ella non credesse più a un futuro di libertà e si fosse rassegnata al proprio destino di creatura randagia e «diversa». Prodigandosi nello sforzo di scuoterla e persuaderla ad andarsene, Robert la informa che quella notte lascerà socchiusa la porta affinché lei possa fuggire, promettendole di raggiungerla in un secondo momento; e lei sembra acconsentire.
Ma ecco che avviene l'imprevedibile. Ad approfittare della porta lasciata aperta non è Marie Blanche, ma Laurent, il quale, dopo essere stato inseguito come una bestia feroce, paga con la vita il suo breve sogno di libertà. Questo contrattempo fa fallire il piano predisposto da Robert, che è costretto ad attendere una nuova occasione.
Non ci sarà, tuttavia, una seconda occasione; perché, mentre si avvicina la Pasqua, durante la messa del Venerdì Santo la nobile Eleonore ha una crisi nervosa e si mette ad urlare contro tutti, sia i malati che i loro custodi (o, piuttosto, carcerieri), accusandoli di cieca crudeltà e di ogni genere di vizi vergognosi. Lo scandalo che ne segue è enorme: le autorità decidono di aprire un'inchiesta sulla conduzione del lebbrosario, ciò che rende la posizione di Robert ormai insostenibile.
Così, prima che sia troppo tardi, il giovane medico parte in compagnia di Marie Blanche, ma non potrà coronare il suo sogno d'amore: arrivato in città, si separa da lei, affidandola ad un medico suo amico, al quale chiede di prendersi cura della ragazza. Ora dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto e prepararsi a un destino incerto; ma allo spettatore non viene mostrata la conclusione della sua vicenda umana e professionale.
«La coda del diavolo» è un bel film e, pur non essendo un capolavoro, si impone come un'opera prima di tutto rispetto, sia per la maestria dell'ambientazione e per la perizia delle riprese, sontuose come una serie di dipinti barocchi, sia per l'efficacia della recitazione e la capacità del regista di tenere le fila di un cast di attori cosmopolita ed eterogeneo, composto sia di esordienti che di professionisti da tempo affermati.
Il protagonista, Robert Briand, è un personaggio complesso e contraddittorio, fragile e ansioso di verità come un novello Enea, nonché tormentato e nevrotico come un Torquato Tasso o un principe Amleto di Danimarca. L'attore Robin Renucci, che si era già segnalato in film come «Invito al viaggio» (Peter Del Monte, 1982), «Fort Saganne» (Alain Corneau, 1983) e «Prestami il rossetto» (Diane Kurys, 1983), è stato da qualcuno salutato come un nuovo Gérard Philipe; e, se il paragone è un po' eccessivo, egli dimostra tuttavia di sapersi calare efficacemente nella parte del giovane medico dilaniato da opposti sentimenti e in profonda crisi interiore.
E che dire della protagonista femminile, l'esordiente Isabelle Pasco, dalla avvenenza conturbante, resa ancor più malandrina dalle rozze vesti del lebbrosario che è costretta a indossare, le quali - invece di mortificarla - la esaltano, per contrasto, fino a renderla insostenibile? I suoi occhi chiari «bucano» lo schermo con una forza tale - nonostante il ruolo abulico e rassegnato che ella deve interpretare -, che lo spettatore non potrà più dimenticarli.
Per quanto riguarda il contenuto, si nota - e alcuni critici lo hanno evidenziato anche più del necessario - un certo schematismo ideologico, cui la sceneggiatura di Vincenzo Cerami (che ne avrebbe poi ricavato un romanzo) conferisce un peso forse eccessivo, rispetto alla naturalezza e alla spontaneità narrative.
La tesi del regista, tipicamente neoilluminista, è che la malattia, nelle mani di un potere repressivo, finisce per divenire capro espiatorio del sadismo e dell'ignoranza dell'intera società (si pensi al conflitto, pur dentro il lazzaretto, fra lebbrosi e sifilitici) e per assumere, quindi, il significato di un marchio d'emarginazione per le categorie più esposte: mendicanti, vagabondi, prostitute e ogni altro genere di «irregolari».
Il Medioevo, quindi (ma il regista, palesemente, tiene un occhio rivolto alla società dei nostri giorni), è presentato qui, piuttosto banalmente, non solo come un'età di profonda superstizione, ma anche come un sistema sociale talmente basato sul valore della stabilità - anche in senso fisico -, da guardare con sospetto e avversione a tutti colori i quali, per una ragione o per l'altra, non si lasciano ancorare ad un luogo, a un mestiere, a una professione, in quanto elementi potenzialmente sovversivi - e peggio ancora se di sesso femminile.
Tuttavia, anche se tale visione del Medioevo è largamente di maniera - nel solco, del resto, della tradizione inaugurata dall'assai sopravvalutato «Il nome della rosa» di Jean-Jacques Annaud, uscito nelle sale l'anno prima (e tratto dall'altrettanto sopravvalutato romanzo di Umberto Eco) -, bisogna dire che tale pregiudizio non assume, nell'opera prima di Giorgio Treves, toni pesanti e grossolani, come nel film di Annaud. E questo, dato il contesto in cui si svolge l'azione - un lazzaretto nell'epoca della «caccia alle streghe» -, non è un merito da poco. La tentazione del "grand-guignol", in un regista meno sorvegliato, sarebbe stata quasi irresistibile.
Al contrario, vi è nel film di Giorgio Treves una capacità di evocazione storica e una serietà di meditazione filosofica che riscatta tutti i difetti della sceneggiatura e dell'impianto ideologico e fa de «La coda del diavolo» un'opera che merita di essere vista; un'opera che, come dicevamo all'inizio, avrebbe meritato più attenzione da parte della critica e del pubblico.
Dopo questo esordio nella regia, Giorgio Treves, nato a New York nel 1945 e che era stato assistente alla produzione di Vittorio De Sica ne «Il giardino dei Finzi-Contini» (di cui ci siamo occupati in un recente articolo) e assistente alla regia di Luchino Visconti in «Gruppo di famiglia in un interno», ha aspettato ben tredici anni prima di tornare alla regia con un'altra co-produzione italo-francese, «Rosa e Cornelia», del 2000: interessante storia di un'amicizia fra due donne di diversa estrazione sociale nella Venezia del XVIII secolo.
Isabelle Pasco, dopo «La coda del diavolo», si è trovata la strada spianata per «sfondare» nel mondo del cinema: e, in effetti, ha interpretato una decina di film di livello medio e medio-basso. Tuttavia non è diventata una nuova Carole Bouquet, forse perché non ha avuto la fortuna di essere diretta da un regista capace di sfruttarne al massimo le doti interpretative; mentre ne ha trovato qualcuno, come Alberto Simone in «Colpo di luna», del 1995, che non ha resistito alla troppo facile tentazione di sfruttarne il bel corpo nudo quale banale espediente da cassetta.
Peccato; se avesse trovato il suo Pigmalione, crediamo che questa ragazza francese dallo sguardo indimenticabile avrebbe potuto fare davvero molta strada.
Passiamo ora brevemente in rassegna alcuni giudizi critici sul film.
Così si esprime il critico cinematografico Tullio Kezich a proposito di questo film d'esordio di Giorgio Treves (in «Il filmnovanta: cinque anni al cinema, 1986-1990», Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1990:
«Lebbra, sifilide, AIDS: le pestilenze sono malattie reali o strumenti del potere per imporre regimi di repressione?» La problematica del soggetto di Vincenzo Cerami è impaginata con rara eleganza nelle immagini di questo insolito film d'esordio, firmato da Giorgio Treves e già premiato con il David di Donatello. In un contesto socio-topografico francese (ma anche lo stile è di classica scuola parigina, ricorda "L'amore e il diavolo" di Carné) assistiamo ai tormenti di un medico assatanato (Robin Renucci) che ha accolto nel lazzaretto di Saint-Clément una giovane (Isabelle Pasco) probabilmente contagiata dalla sifilide.
Siamo nelle Fiandre alla fine del XV secolo, la malattia è nuova e pericolosa e molti pensano che si debba affrontarla con segregazioni, frustate e altre violenze sui presunti malati. Strega o innocente, la ragazza emerge dal gruppo dei prigionieri infetti con una sua ambigua quanto ineluttabile presenza. E nonostante i consigli di suo padre Erland Josephspon e le amorose minacce di Piera Degli Esposti governante rubacuori, che prevedono dure sanzioni da parte del clero offeso, il protagonista finisce per accettare la legge dell'amore fuggendo in coppia con la sua ammaliatrice contro ogni regola di prudenza sanitaria.
Considerato da alcuni il nuovo Gérard Philipe, Renucci dà adeguato rilievo a un personaggio in perpetua crisi. Ma il film, nella sua eloquente correttezza, ha qualcosa di algido che lo trasforma in un teorema senza passione.»
Molto più severo il giudizio di Paolo Mereghetti, un critico che va per la maggiore, ma col quale ci siamo trovati sovente in disaccordo per una certa sua tendenza radical-chic che demolisce con troppa facilità opere cinematografiche che hanno la sfortuna di non soddisfare interamente le sue aspettative esigenti e un po' prevenute sul piano ideologico (valga per tutte la totale incomprensione di un bel film con l'indiano «Fire», del 1996, di Deepa Metha), pur se possiedono doti di freschezza e originalità.
Peraltro, vengono da lui evidenziati i pregi della regia e della recitazione; è soprattutto la sceneggiatura ad essere messa sotto accusa, per un presunto eccesso di intellettualismo (da: "Il Mereghetti. Dizionario dei film", Milano, Baldini & Castoldi, 2003):
«Nel Quindicesimo secolo, un giovane medico (Renucci) cura i sifilitici e s'innamora di una paziente. Cercherà di farla fuggire, ma provocherà un incidente e finirà sotto inchiesta.
Parabola medioevale sul potere repressivo, l'intolleranza e la trasgressione che nasconde anche (ma non troppo) un'allegoria sull'AIDS. Treves dirige con gusto pittorico e senso compositivo, avvalendosi di un cast di attori di diversa nazionalità una volta tanto ben assortito. Ma la sceneggiatura (di Vincenzo Cerami) concede troppo al giusto della metafora e toglie forza al film.»
«Il Morandini», da parte sua, formula una valutazione nel complesso positiva, attribuendo alla pellicola di Giorgio Treves tre stelle (contro le due di Mereghetti) ma evidenziando anche il mancato successo di pubblico (Bologna, Zanichelli, 1999):
«In un lazzaretto per lebbrosi, su un altopiano alpino (la Savoia?) arriva un gruppo di malati di sifilide. Il giovane medico che lo dirige è attratto da una delle malate.
Ricco di personaggi, sostenuto da un apparato figurativo di prim'ordine, lucido nell'indicare nel motore della vicenda il potere clericale e nella sifilide il corrispondente antico dell'Aids, questa interessante opera prima che ha cadenze un po' rigide di apologo illuminista, è un film al quale si addice l'etichetta di europeo. Dalla sua sceneggiatura Vincenzo Cerami ha tratto il romanzo"La lepre" (1988). »
Concludiamo dicendo che, nel contesto di un cinema italiano sempre più asfittico e provinciale, nuovi registi come Giorgio Treves costituiscono una gradita e promettente eccezione: per merito loro, quando ci accingiamo alla visione di un film nostrano, abbiamo quasi l'impressione di essere in Europa (e non in una banale provincia levantina dell'impero americano).
Vorremmo vedere più spesso dei film come «La coda del diavolo»; che, pur non esenti da taluni difetti, costituiscono però una preziosa boccata d'aria fresca e meriterebbero dalle case produttrici il massimo incoraggiamento.
O vogliamo continuare ad importare, pagandola a peso d'oro, l'eterna, inguardabile paccottiglia di Hollywood?


