Come un fraintendimento della matematica ha messo in crisi l’idea di Verità
di Francesco Lamendola - 14/01/2010
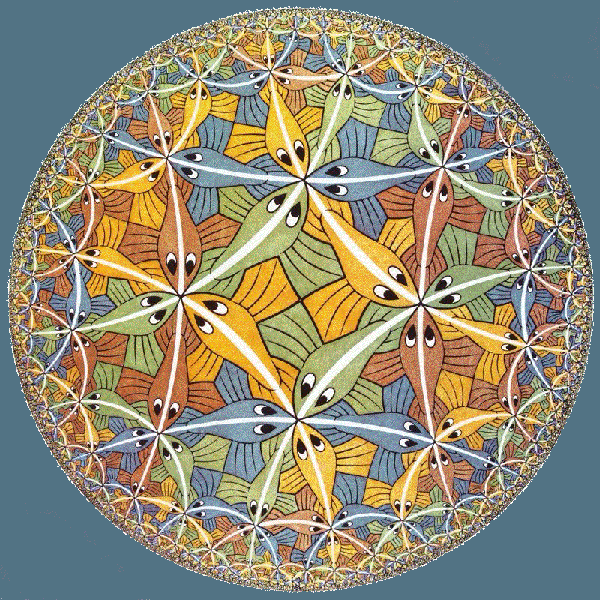
Fin verso il 1830 tutti i matematici pensavano che la geometria euclidea esprimesse non già un particolare modello di geometria, e sia pure il più classico ed armonioso, ma la geometria in quanto tale: l’unica forma possibile di geometria. Inoltre, grazie ai suoi caratteri di perfezione e di eleganza, ne deducevano che l’universo è scritto in caratteri matematici: tesi ripresa e ribadita da Galilei e dalla cosiddetta Rivoluzione scientifica del XVII secolo.
Ma poi, nel giro di pochi anni, un vero e proprio terremoto si abbatté sulle secolari, millenarie certezze dei matematici: la scoperta delle geometrie non euclidee. Un ungherese, Bolyai, un russo, Lobačevskij, e un tedesco, Riemann, scoprirono e misero a punto altre forme di geometria, basate non sullo spazio euclideo e sulla superficie piana, ma su delle superfici curve, ad esempio iperboliche; delle superfici ove la somma degli angoli di un triangolo non è più, infallibilmente, di centottanta gradi, ovvero pari ad un angolo piatto, ma di una misura maggiore o minore, a seconda dei casi.
Fino a quel momento, si era pensato che lo spazio fisico e lo spazio matematico fossero una sola ed unica cosa; ora si scopriva che non è così; che una cosa è lo spazio fisico, e un’altra cosa è lo spazio matematico. Lo spazio fisico è oggettivo, quello matematico dipende dal modello di geometria che si adotta per misurarlo. Ma non esiste un modello più giusto o più vero di un altro: tutto dipende dal punto di vista che si adotta. Si tratta di un semplice criterio di opportunità, quindi; non di verità assoluta.
Lo shock fu enorme.
La geometria di Euclide, la più perfetta costruzione del pensiero matematico, si rivelava nient’altro che un modello di geometria fra i tanti possibili; e nulla autorizzava a dedurne una realtà oggettiva, là fuori, nello spazio reale dell’universo fisico. Dunque, la geometria non è una scienza caratterizzata da criteri di verità evidenti ed assoluti, ma semplicemente da un certo grado di coerenza fra i suoi postulati ed i teoremi e i corollari che si possono dedurre da quelli. Non vi sono verità in geometria, ma solo ipotesi di lavoro più o meno coerenti.
Come ha osservato Nicola Abbagnano (in: «Storia della filosofia», Torino, Utet, 1958, vol. II, p. 565):
«Si dovette così rinunciare al concetto della verità della geometria. Nessuna geometria è vera, quindi nessuna è più vera dell’altra. Tutte hanno lo stesso tipo di validità logica dovuta alla intrinseca coerenza del linguaggio nel quale si esprimono. La scelta di una determinata geometria per gli usi della vita è pura questione di comodità. I principi da cui ogni geometria muove sono semplicemente regole sintattiche per l’uso dei vocaboli di cui essa si serve. »
Che la geometria fosse un semplice sistema di logica, le cui regole sono valide solo all’interno di esso, non era finora apparso chiaro, benché si fosse sempre saputo che, per lavorare con i suoi teoremi, bisogna prima accettarne i postulati fondamentali, vale a dire compiere un atto di fede: non diverso, direbbe Paul Feyerabend, da quello di uno stregone hopi che compie la danza della pioggia per alleviare una lunga stagione di siccità.
Wittgenstein, da parte sua, avrebbe insistito sul carattere puramente logico e formale di essa: come quando, all’affermazione di Bertrand Russell che nell’aula di lezione non vi erano dei rinoceronti, si mise a guardare sotto i banchi, quasi a voler mostrare la gratuità di tale assunto (che, di fatto, non contrasta con alcun sistema di logica e il cui grado di verità può essere solo deciso con metodi empirici).
Con la scoperta del carattere formale della geometria, la strada era aperta - dal punto di vista concettuale - per la teoria della relatività di Einstein.
Tutto era cominciato allorché alcuni matematici si erano presi la briga di tentar di dimostrare il quinto postulato di Euclide, vale a dire il postulato delle rette parallele, che recita: «Per un punto non può passare che una sola parallela a una retta data». Ma questo risultò essere vero solo nella geometria di Euclide; mentre il numero delle parallele che si possono condurre per un punto dato a una data retta è infinito nella geometria di Lobačevskij, mentre è uguale a zero in quella di Riemann. E fu Gauss ad intuire, verso il 1830, che si possono concepire delle geometrie diverse da quella di Euclide, che non abbiano in se stesse alcunché di contraddittorio.
Ha scritto Morris Kline, già prestigioso professore di matematica presso l’Università di New York, nel suo saggio «La matematica nella cultura occidentale» (titolo originale: «Mathematics in Western Culture», Oxford University Press, 1953; traduzione dall’inglese di Libero Sosio, Milano, Feltrinelli, 1976, pp.395-96):
«Dovremmo quindi considerare ogni teoria sullo spazio fisico come una costruzione puramente soggettiva e non imputarla alla realtà oggettiva. L’uomo costruisce una geometria, sia essa euclidea o non euclidea, e decide di considerare lo spazio nei termini di essa. I vantaggi che ne consegue, anche se non può esser certo che lo spazio possegga alcun carattere della struttura che egli ha costruito nella propria mente, consistono nel fatto che egli diventa in grado di meditare sullo spazio e usare la sua teoria nel lavoro scientifico. Questa concezione dello spazio e della natura in generale non implica la negazione dell’esistenza di un mondo fisico oggettivo. Essa equivale semplicemente a riconoscere che i giudizi e le conclusioni dell’uomo sullo spazio sono puramente soggettivi.
La creazione della geometria non euclidea passò come un turbine di devastazione nel regno della verità. Come la religione in società antiche, la matematica occupava una posizione riverita e indiscussa nel pensiero occidentale. Nel tempio della matematica riposava ogni verità, ed Euclide ne era il sommo pontefice. Ma il culto, il suo pontefice massimo e tutti i suoi assistenti furono spogliati della sanzione divina dall’opera di tre sacrileghi: Bollai, Lobačevsij e Riemann. È vero che, nell’intraprendere la loro ricerca, questi intelletti audaci avevano in mente solo il problema logico di investigare le conseguenze di un nuovo postulato delle parallele. Certo, in principio non si resero conto che stavano sfidando la Verità stessa. E finché la loro opera fu considerata semplicemente un ingegnoso gioco matematico, non si posero questioni serie. Nel momento in cui questi uomini si resero però conto del fatto che le geometrie non euclidee potrebbero essere descrizioni valide dello spazio fisico, si presentò loro un problema inevitabile. Come mai la matematica, che aveva sempre preteso di rivelare la verità a proposito della quantità e dello spazio, ci offre ora varie geometrie contraddittorie? Non più di una di esse potrebbe essere la verità. In realtà, fatto ancor più sgradevole, la verità è forse diversa da tutte queste geometrie. La creazione delle nuove geometrie costrinse perciò a riconoscere che tutti i postulati matematici potrebbero esser soggetti a un “se”. Se i postulati della geometria euclidea sono verità sul mondo fisico, allora lo sono anche i teoremi. Purtroppo, però, non possiamo decidere sulla base di argomenti “a priori” che i postulati di Euclide, o di qualsiasi altra geometria, sono verità.
Privando la matematica della sua condizione di insieme di verità, la creazione delle geometrie non euclidee privò l’uomo delle verità più rispettate e forse anche della speranza di raggiungere mai la certezza su qualcosa. Prima dell’Ottocento ogni epoca aveva creduto nell’esistenza di una verità assoluta; gli uomini si differenziavano solo nella scelta delle fonti. Aristotele, i Padri della Chiesa, la Bibbia, la filosofia e la scienza avevano avuto tutti il loro momento come arbitri di verità oggettive, eterne. Nel Settecento fu sostenuta la sola ragione, in virtù di ciò che è stato prodotto nella matematica e nei settori matematici della scienza. Il possesso di verità matematiche era stato confortante particolarmente per il fatto che esse tenevano viva la speranza di altro che doveva ancora venire. Ora purtroppo la speranza veniva distrutta. La fine del dominio della geometria euclidea fu la fine del dominio di ogni verità assoluta. Il filosofo può ancora insistere sulla profondità del pensiero; l’artista può sostenere la validità di un’intuizione manifestata dalla sua abilità tecnica; la persona pia può riempire la più grande cattedrale degli echi dell’ispirazione divina; e il poeta romantico può cullare il nostro intelletto in un torpore sonnolento e indurci a un’acritica accettazione della sua allettante composizione. Forse queste sono tutte fonti di verità e forse ce ne sono anche altre. Ma la persona razionale che ha afferrato la lezione della geometria non euclidea è almeno diffidente nei confronti delle insidie e, quand’anche accetti qualche verità, lo fa provvisoriamente, attendendosi in ogni momento di poter aprire gli occhi. Paradossalmente, benché le nuove geometrie impugnassero la capacità dell’uomo di conseguire verità, esse forniscono l’esempio migliore del potere della mente umana, poiché, per produrre queste nuove geometrie, la mente dovette sfidare e superare l’abitudine, l’intuizione e le percezioni sensoriali.
La perdita del suo carattere sacrale da parte della verità sembra eliminare un’antica questione concernente la natura della matematica stessa. La matematica esiste indipendentemente dall’uomo, come le montagne e i mari, oppure è una creazione interamente umana? In altri termini, il matematico nel suo lavoro riporta in luce diamanti che sono rimasti celati per secoli nelle tenebre oppure sta producendo una pietra sintetica? Ancora alla fine dell’Ottocento, avendo dinanzi a sé la storia della geometria non euclidea, l’illustre fisico Heinrich Hertz poté dire: “Non ci si può liberare dall’impressione che queste formule matematiche abbiano un’esistenza indipendente e un’intelligenza propria, che siano più sapienti di noi, più sapienti anche dei loro scopritori, e che noi ricaviamo da esse più di quanto fu posto in esse originariamente.” Nonostante quest’opinione, la matematica appare il prodotto di menti umane, fallibili, più di quanto non sia l’eterna sostanza di un mondo indipendente dall’uomo. Essa non è una struttura d’acciaio fondata sullo strato roccioso della realtà oggettiva bensì un filo di ragnatela che oscilla insieme ad altre speculazioni nelle regioni solo in parte esplorate della mente umana.»
È abbastanza curioso che Kline non si accorga di incorrere proprio nello stesso tipo di errore logico che evidenzia nei seguaci della geometria di Euclide: scambiare un dato parziale per la totalità, e assolutizzarlo indebitamente. Con l’aggravante che si tratta di un doppio errore logico, non di un errore semplice.
Il primo errore deriva da una indebita contaminazione tra l’idea di spazio matematico e quella di spazio fisico. Egli sostiene che ogni teoria sullo spazio fisico, e dunque ogni geometria, è una costruzione puramente soggettiva. Poi, però, afferma che se i postulati della geometria euclidea sono verità sul mondo fisico, allora lo sono anche i teoremi; ma che non possediamo alcun elemento che ci consenta di ricondurli a delle verità di fatto.
Kline, però, non avrebbe alcun diritto di ipotizzare che la geometria di Euclide abbia un riscontro nel mondo fisico: se lo fa, inficia tutto il suo ragionamento, la cui conclusione è che, appunto, ogni geometria è solo un modello teorico, utile come ipotesi di lavoro per risolvere determinati problemi, e null’altro.
Poi dichiara che, fino all’Ottocento, ogni epoca aveva creduto in una verità assoluta: ma, di nuovo, non distingue opportunamente fra verità logico-matematica e verità ontologica. Qualunque studente al primo anno di filosofia sa distinguere tra verità di principio e verità di fatto; ma Kline non si perita di argomentare che, da quando entrò in crisi l’idea di una validità assoluta della geometria, è stata l’idea stessa di verità ad andare in crisi.
Naturalmente, non è affatto vero: però è un dato di fatto che la sua opinione è condivisa da numerosi intellettuali, insegnanti e saggisti, col risultato che la gran massa dell’opinione pubblica ha introiettato un simile punto di vista e pensa che, con le scoperte di Lobačevsij e degli altri, a crollare sia stata l’idea stessa di verità; anzi, la verità in quanto tale: visto che, da Hegel in poi, il soggetto conoscente e la Verità conosciuta sono generalmente visti come un tutt’uno (e questo non è l’ultimo dei danni che il gran sofista dell’Idealismo tedesco ha provocato nella storia della cultura moderna).
Né Kline si rende conto che, se il Settecento aveva divinizzato la ragione (come lui stesso dice), la scoperta della relatività della geometria euclidea può costituire un trauma solo per quanti si attardano nella religione illuminista e continuano, più o meno inconsciamente, a identificare la Ragione con la Verità.
Quanto alla convinzione che il possesso di verità matematiche fosse stato confortante soprattutto per il fatto che esse tenevano viva la speranza di altro che doveva ancora venire, essa non fa che confermare la tendenza «teologica» della matematica cartesiana e galileiana; così come parlare di speranze distrutte non autorizza certo a concludere che la fine del dominio della geometria euclidea fu la fine del dominio di ogni verità assoluta.
Questa, in filosofia, è la classica conclusione più grande delle premesse: perché se la geometria è una costruzione della mente umana, si può forse ammettere che la fine di un modello geometrico unitario metta in crisi la nostra idea del sapere matematico, ma non ci consente di parlare di una fine della verità in quanto tale. Gira e rigira, si cade sempre nell’enorme peccato di presunzione di Galilei: dare cioè per scontato che l’universo sia scritto in caratteri matematici e che Dio stesso non sia altro che un grande matematico.
Qualcuno potrebbe pensare che Kline si esprima in maniera figurata e che non si dovrebbe fargliene troppo una colpa, laddove ironizza sul filosofo che ancora insiste sulla profondità del pensiero, sull’artista che sostiene la validità delle sue intuizioni, sulla persona pia che riempie le cattedrali con gli echi delle sue preghiere o sul poeta romantico (evidentemente, per lui qualunque poeta è sempre un romanticone) che culla il nostro intelletto in un torpore sonnolento che ci induce a un’acritica accettazione della sua allettante composizione.
Ahimé, che non si tratti di un modo di parlare figurato appare evidente dalla sua affermazione che la persona razionale, la quale abbia afferrato la lezione della geometria non euclidea, diventa diffidente nei confronti delle insidie (quali? quelle dei poeti e delle persone pie assorte in preghiera?; e, quand’anche si induca ad accettare qualche verità, lo fa provvisoriamente, attendendosi in ogni momento di poter aprire gli occhi.
Eccoci arrivati al punto.
Se la matematica non può essere la sola, veritiera forma di conoscenza della realtà, ebbene allora non hanno il diritto di esserlo né l’arte, né la filosofia, né la religione, né la poesia; o meglio, possono esserlo, ma solo in un ambito parziale e relativo. Muoia, dunque, Sansone con tutti i Filistei! Se il professore di matematica non è più il solo legittimo sacerdote all’Assoluto, allora non devono fregiarsi del titolo nemmeno i rappresentanti delle altre forme di sapere.
In che cosa consiste il vizio di questo ragionamento? Nel non riconoscere che la conoscenza del mondo fisico ha per oggetto le verità di fatto; mentre la conoscenza del mistico, del poeta, del filosofo e dell’artista, vanno tutte al cuore delle cose: all’essenza della realtà - che non è di natura fisica, qualunque cosa essa sia. La scienza si occupa, per definizione, delle verità di fatto; e quando la matematica pretende di farsi strumento di conoscenza di esse, esorbita dai suoi fini e dai suoi mezzi: invade un campo che non le compete. Qual meraviglia se, fallito l’obiettivo, deve poi mestamente raccogliere i cocci del proprio orgoglio, andati in frantumi?
Quanto alla conclusione di Kline circa la natura puramente speculativa della matematica - che non scaturisce da alcun ragionamento e che, di nuovo, sfocia in una conclusione maggiore delle premesse -, nulla meglio di essa potrebbe illustrare l’atteggiamento arrogante, e al tempo stesso semplicistico, con cui si accosta al problema della verità.
Per Kline e per quelli che la pensano come lui, la convinzione che la matematica sia il prodotto delle menti umane, e quindi una scienza fallibile, scaturisce non solo dal misconoscimento del valore di verità di altre forme di conoscenza del mondo (quali l’arte, la filosofia, la religione e la poesia), ma anche da una spregiudicata identificazione della verità conoscitiva (gnoseologia) con la verità in se stessa (ontologia).
In altri termini, noi non abbiamo alcun diritto di pensare che quanto è umanamente percepibile, verificabile e dimostrabile, esaurisca il campo del reale: sarebbe molto più sensato - ed anche, è proprio il caso di dirlo, molto più ragionevole - ammettere che quanto un ranocchio può osservare del mondo, dal fondo del suo stagno, non è il mondo in se stesso, ma soltanto una minuscola porzione di esso.
Per dirla con Shakespeare, e rivolgendosi particolarmente agli orgogliosi signori della verità matematica: «Vi sono molte più cose fra la terra ed il cielo, di quante ne possa sognare tutta la vostra filosofia».
Per dirne una: non si accorge, Morris Kline, che la sua alternativa secca: o la matematica esiste indipendentemente dall’uomo, come le montagne ed i mari, oppure è una creazione interamente umana, parte da una accezione arbitraria del concetto di «esistenza»? Da buon materialista, egli pensa che esistono in se stesse solo le cose che stanno al d fuori del pensiero, come le montagne ed i mari; mentre tutto il resto non sarebbe che creazione della mente umana.
Magari le cose fossero così semplici; ma non è così.
Possibile che non abbia mai sentito parlare di come Berkeley, in piena Età dei Lumi, abbia dimostrato che tutto ciò che percepiamo, lo percepiamo all’interno della nostra mente, compresi i mari e le montagne; e perciò che, se l’indipendenza dalla mente umana fosse il solo criterio di realtà oggettiva di una data cosa, allora non potremmo affermare che alcuna cosa esista realmente?


