Swift, Stella, Vanessa: un triangolo d’amore che non riuscì mai a trovar la pace
di Francesco Lamendola - 19/04/2011
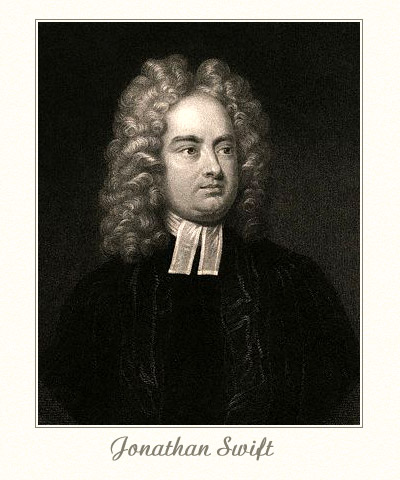
Secondo la scrittrice, saggista e traduttrice italiana Olga Ceretti, «la posizione di un uomo conteso fra due donne è sempre difficile, spesso addirittura penosa e ridicola: Jonathan Swift trova il modo di esasperarla sino al dramma».
Non sappiamo se questo giudizio sia giusto, ma è certo che nel particolare triangolo amoroso venutosi a creare, nell’Inghilterra del primo Settecento, fra il grande scrittore Jonathan Swift, autore dei «Viaggi di Gulliver», e due donne di superiore intelligenza e cultura, entrambe di nome Esther, l’inglese Esther Johnson e l’olandese Esther Vanhomrigh, nessuno dei tre fu felice; anche se è cosa estremamente ardua giudicare dall’esterno la felicità di un altro essere umano.
La Vanhomrigh, per esempio, dopo averlo seguito in Irlanda, morì ancor giovane, si disse, con il cuore spezzato per le ripulse di Swift, che non l’amava, anche se era, forse, lusingato dalla sua sconfinata dedizione: ma chi siamo noi per dire se un solo giorno, anzi, per meglio dire, se un solo istante di pura felicità, quale certamente un cuore innamorato assapora di tanto in tanto per alimentare la propria passione, non possa ricompensare mesi e anni di sofferenza e di amaro senso di fallimento?
Le relazioni d’amore sono essenzialmente basate, come quelle di amicizia, sulla dimensione qualitativa, non su quella quantitativa; ed esse vivono di luce soggettiva, né sanno che farsene di un fredda, impietosa oggettività che, dal di fuori, pretenda giudicarle ed, eventualmente, condannarle come sbagliate e distruttive.
Swift, non c’è dubbio, era un uomo difficile; come lo sono, molto spesso, nella vita privata, gli uomini di genio; a meno che essi riescano a chiudere il cerchio e a riconquistare l’armonia e la pace dell’anima, dopo che la loro speciale sensibilità, avendoli messi a faccia a faccia con le aporie della vita, sovente li ha resi, se non dei misantropi, quanto meno dei pessimisti.
Swift era un pessimista: peraltro è un gioco troppo consunto quello di sbizzarrirsi con le teorie freudiane e psicologizzare a ruota libera, facendo della sua infanzia solitaria e abbandonata la chiave per comprendere le sue future difficoltà nelle relazioni umane e particolarmente quelle con il genere femminile, dal quale lo scrittore, di temperamento profondamente virile, si sentiva fortemente attratto.
Altri esponenti del movimento illuminista inglese, come lo storico Edward Gibbon, raggiunsero ben presto quello stato di perfetto dominio di sé, che tanto favorisce la riflessine spassionata sulla condizione umana, ma solo perché nasce da vera e propria impotenza sessuale; Swift non raggiunse mai quella “pace” dei sensi, perché le donne lo attraevano, e molto, pur se egli non seppe o non poté liberarsi da una sorta di disgusto che l’intimità fisica gli ispirava, e più ancora gli ispirava il corpo in quanto tale, con i suoi umori e le sue secrezioni (aveva la mania di lavarsi continuamente), per non parlare degli aspetti sgradevolmente antiestetici della nudità e dell’atto sessuale, dalla cui ripugnanza - sembra - egli non riuscì mai a liberarsi.
Da qui a sostenere che egli fu egoista, crudele, distruttivo con le due donne della sua vita, però, ce ne corre; al contrario, le pagine che egli scrisse all’una e all’altra rivelano un carattere generoso, sensibile, addirittura tenero ed estremamente sollecito.
Uno di coloro i quali hanno accolto in pieno la versione di uno Swift ferocemente egoista e spietato con le donne è stato lo storico della letteratura Mario Praz, che, nella sua famosa «Storia della letteratura inglese» (Firenze, Sansoni, 1982, pp. 314-16), così si esprime:
«Nulla resiste alla corrosiva immaginazione di Swift: né la scienza, né la storia, né le istituzioni politiche, né il mondo dei privati sentimenti. I “Viaggi di Gulliver” sono come una gigantesca parabola, un sermone inteso a mostrare la vanità di tutte le cose umane. Era quel che avevano fatto sempre predicatori, e per colorito pessimista certo il “De Contemptu Mundi” d’Innocenzo III non la cedeva a Swift. La “commedia umana” procede in senso inverso alla “Divina Commedia”. Il capolavoro dantesco s’inizia col tetro abisso dell’Inferno e progressivamente se ne allontana pei gradi del Purgatorio, fino alla radiosa serenità del Paradiso. “E ‘n sua volontade è nostra pace”: dice Dante. Il capolavoro di Swift s’inizia con l’allegretto dei Lillipuziani, e via via si fa più fosco attraverso le esperienze grottesche e nauseabonde di Gulliver nel paese dei giganti, attraverso a quella rassegna dell’umana stoltezza e vanità che è il viaggio a Laputa e a Lagado, specie di “elogio della follia”, fino alla disperazione delle ultime parti, la visita agl’immortali e la scoperta dell’uomo primitivo ed elementare nella razza degli Yahoo. Maledetta dall’origine, condannata alla malvagità, all’impurità e alla corruzione la razza umana, per una volontà che, se è volontà di Dio, lo è di un Dio come quello descritto in una breve poesia di Swift sul Giorno del Giudizio, un Dio che dinanzi allo spettacolo della vale di Giosafatte esclama:
“The World’s mad business in o’er,
And I reent these Pranks no more,
I to such Blockheads set my Wit!
I damn such Fools! - Go, go, yo’re bit”.
(“La pazza faccenda del mondo è finite, ed io non me la prendo più per quelle mariuolerie. Io mettermi a tu per tu con questi sciocchi? Io li mando all’inferno. – Eccovi bell’e incicciati!”).
Un Dio che certamente non parla il linguaggio d’un padre, un dio nella cui volontà non è la pace, ma la disperazione degli uomini.
I “Gulliver’s Travels” sono le specchio d’un animo profondamente turbato, chiuso in una sua dura corazza d’egoismo (disposizione che venne esasperata dalla malattia labirintite - che accompagnò Swift per tutta la vita, fino allo sfacelo delle sue facoltà mentali); in tale egoismo è anche da cercare la ragione del mistero che circonda i rapporti sentimentali con le due donne che gli dedicarono la loro giovinezza, Stella (Esther Johnson) e Vanessa (Esther Vanhomrigh).
Verso queste donne egli si comportò con un misto di tenerezza e di crudeltà, un educatore e un protettore che in effetti si rivela un distruttore, un annientatore. Così il suo carattere è visto da Evelyn Hardy (“The Conjured Spirit, Swift”, Londra, The Hogarth Press, 1949): “Egli era una mescolanza di maschile e di femminile, ferocemente maschile e teneramente femminile; compassionevole eppure crudele: era forte della forza di Sansone, eppure d’un tratto, in modo sorprendente, debole, invocante la pietà delle donne che l’amavano, era sensitivo eppure aspro, pieno di delicatezza, eppure grossolano come più non si sarebbe potuto essere; orgoglioso come Lucifero, eppure spesso umile innanzi a loro, pronto a inchinarsi al loro giudizio; dotato d’un notevole buon senso eppure inesplicabilmente superstizioso; inattaccabile, eppure penosamente vulnerabile; innocente, eppure colpevole: uno che si professava religioso, eppure era fondamentalmente ateo, e di deliberato proposito stava aggrappato ala sua religione per combattere quel tetatrro pessimismo cerebrale alimentato dal suo disgusto degli uomini: pronto a buttarsi allo sbaraglio, eppure apprensivo; dotato d’intuizione, eppure perversamente cieco. Capace di persuasiva eloquenza, e insieme d’un silenzio micidiale; sano in grado eminente, eppure spaventosamente folle, come se un estro demoniaco l’assalisse di continuo: protettore dei poveri, dei deficienti, dei bisognosi, eppure in fondo al cuore odiatore della razza umana”. Questa descrizione non è una lista di qualità contrastanti quali i medievali si compiacevano d’enumerare per bizzarria, ma è il ritratto fedele d’un carattere complesso e ambiguo, l’origine della cu stranezza va ricercata nell’infanzia. Il suo timore del “sesso tirannico” probabilmente nacque dalla sua esperienza infantile con l’ignorante nutrice che lo rapì, bimbo d’un anno orfano di padre, e lo tenne con sé a Whitehaven per quasi tre anni. Questa donna del popolo gli era estremamente affezionata, ma proprio essa dovette dargli quel senso di disgusto del corpo umano che gli impedì relazioni normali con le donne; il passo rivelatore è contenuto nel secondo dei “Viaggi di Gulliver”, allorché egli parla del seno della nutrice gigantesca: “Confesso che nessun oggetto mi ha mai fatto tanto schifo quanto la vista del suo mostruoso seno, che non saprei a che paragonare per dare un’idea al curioso lettore, ecc.”. Rifuggente dal contatto carnale, ossessivamente meticoloso in fato di pulizia, egli non poteva tuttavia fare a meno delle donne, con le quali ebbe commercio soltanto intellettuale. Il Thackeray dichiarava di non conoscere “nulla di più virile, di più tenero, di più squisitamente commovente di alcune di quelle brevi missive scritte in quello che Swift chiama ‘il suo piccolo linguaggio’ nel suo diario per Stella”. Ma la tragedia di Swift e, per contraccolpo, di Vanessa, (che morì a trentasei anni) e di Stella (che morì a quarantasette), fu che egli, pur volendo vedere le due donne come busti (come disse il suo amico lord Orrery) o come teste soltanto, non seppe ignorare quel che avveniva dalla cintola in giù, e questo gli dava la nausea e la vertigine e lo rendeva, di conseguenza, crudele.»
Lasciamo, dunque, a Mario Praz e, più ancora, a Evelyn Hardy il discutibile piacere di imperversare con la psicanalisi e di vedere tutto chiaro nel labirinto del cuore umano; anche se le elucubrazioni sul rapporto fra certe pagine dei “Gulliver’s Travels” e la ripugnanza del Nostro per la dimensione fisica della sessualità ricordano la presunzione delle peggiori pagine di Freud sull’infanzia e sui sogni di Leonardo da Vinci e, più in generale, ripropongono un biografismo riduttivo e piattamente psicologistico, ove tutto è chiaro, purché si ammetta l’esistenza di un trauma infantile.
La Hardy, specialmente, ci dà dentro con le coppie di qualità opposte, sovente per il puro piacere letterario, trascinata dall’ebbrezza del suo stesso gioco: come quando definisce Swift «colpevole eppure innocente», più per amore dell’effetto drammatico che scaturisce da questa coppia di aggettivi antitetici.
Del resto, non è difficile vedere che fa capolino, dietro questa impostazione del problema, il solito vecchio schema del femminismo velleitario e al tempo stesso piagnucoloso: se le donne soffrono, è perché amano troppo, ossia perché amano uomini impossibili che esse, nella loro immensa bontà e generosità, vorrebbero salvare, redimere, proteggere: tendenza che ha conosciuto l’apice con la pubblicazione del saggio di Robin Norwood «Women who love too much», nel 1985, che subito balzò ai vertici delle classifiche dei libri più venduti negli Stati Uniti d’America e, in traduzione, negli altri maggiori Paesi del mondo intero.
Come dice l’autrice (a p. 178), «nei casi peggiori, le donne che amano troppo sono totalmente dipendenti dalla relazione, ‘drogate di un uomo’, attaccate alla sofferenza, alla paura, allo struggimento». E, per chiarire ancora meglio il concetto, l’editore italiano ha pensato bene di mettere in copertina l’immagine di due occhioni femminili dalle lunghissime ciglia che guardano in alto come quelli di una martire durante il supplizio, mentre alcune grosse lacrime scivolano brillanti lungo le guance («Larmes» di Man Ray).
Ma davvero Stella e Vanessa hanno amato troppo l’uomo sbagliato? Siamo sicuri che esse abbiamo amato troppo, o invece, più semplicemente, non potrebbe essere che non abbiamo saputo amare? Oppure che abbiano amato Swift con fervore, con devozione, con perfetta amicizia, senza pentirsi dei risvolti negativi di quella relazione impossibile, senza amareggiarsi per la loro giovinezza consumata nel sentimenti per un uomo che non poteva ricambiarle pienamente, se è vero, come sembra, che egli sposò Stella in segreto, continuando a vivere separatamente da lei (ma non aveva fatto la stessa cosa anche l’ottimo Ludovico Ariosto con la sua Alessandra Benucci, pienamente consenziente?) e che, se Vanessa si consumò d’amore, Swift non la ingannò mai, perché mai le promise quel che non poteva prometterle e, anzi, provò una autentica compassione per quella sua infelice amica, che a nessun costo riusciva a separarsi da lui?
Una tale interpretazione emerge dalla lettura della più lunga delle poesie di Swift, «Cadenus and Vanessa», da lui composta 1713 per Esther Vanhomrigh, figlia di un ricco commerciante olandese che lo scrittore aveva conosciuto a Londra nel 1707 e che di lui si era subito innamorata, tanto da volerlo seguire in Irlanda, a Dublino, lasciando ogni altra cosa per amor suo.
Rispettando il desiderio di lei, Swift attese la sua morte, avvenuta il 2 giugno del 1723, un anno dopo la definitiva rottura tra i due, per darla alle stampe; Cadenus, naturalmente, è l’Autore, celato dietro il facile anagramma di “Decanus”, in quanto, allora, Swift era stato nominato decano di San Patrizio, a Dublino.
Nella poesia, Swift fa capire che è stata Vanessa a prendere l’iniziativa della loro relazione e riconosce la propria “crudeltà”, ma solo quando le cose presero uno sviluppo che gli sembrò impossibile da gestire. In breve, pur assumendosi una parte di responsabilità, Cadeno fa capire che il suo comportamento è stato forse criticabile, ma non incoerente, né sleale: egli, infatti, non aveva mai fatto promesse a cuor leggero.
Questo è un monito per tutti quegli amanti, e soprattutto quelle amanti, che sperano di ottenere un po’ alla volta, con la perseveranza, quella corrispondenza che non ricevono subito: perché nessuno può essere costretto a ricambiare l’amore di un altro, e chi si avventura sul terreno dell’amore a senso unico deve essere ben consapevole dei rischi ai quali si espone.
L’importante è che colui che riceve una offerta d’amore incondizionato sia onesto e non simuli sentimenti che non prova: e Swift, per quel che ne sappiamo, ebbe semmai il torto di essere fin troppo esplicito su questo punto. Non giocava a fare il bel tenebroso, come farà Lord Byron (e come sogliono fare, in genere, gli uomini dall’animo effeminato); e, se la sua natura riflessiva e introversa incuriosiva e attirava un certo tipo di donne, egli non ne abusò e non ne fece uno strumento per facili conquiste.
Un discorso diverso va fatto per l’altra donna della vita di Swift, Stella.
Anche qui siamo informati , tra l’altro, da una fonte diretta dell’Autore: quel «Journal to Stella» che venne pubblicato, anch’esso postumo, da Thomas Sheridan nel 1784. Il titolo non è di Swift, il quale cominciò a chiamare Esther Johnson con il soprannome di “Stella” solo dopo che il suo epistolario a lei diretto era incominciato già da alcuni anni; inoltre abbiamo la certezza che le lettere sono state ampiamente ritoccate dai curatori, come appare dal confronto fra gli originali di alcune di esse, ritrovate al British Museum, e il testo pubblicato.
Il carattere più peculiare dell’epistolario, infatti, è il linguaggio bizzarro e bamboleggiante, il “little language” che ricorda un poco quello con cu Mozart si rivolgeva alla giovane moglie (scurrilità a parte): un misto di inventiva fantastica, di tenerezza, di sollecitudine paterna e di scherzosa bonomia, quale raramente è dato trovare in un rapporto sentimentale fra un uomo e una donna adulti, di elevata cultura e di ricchi sentimenti.
Qualcuno ha definito “misterioso” il rapporto che legava Swift a Stella (e, sia pure in un senso diverso, anche a Vanessa), proprio perché sfugge a qualsiasi catalogazione e perché, in esso, sembra sempre che qualcosa ci sfugga, che qualcosa non sia come dovrebbe essere o, più esattamente, come ci si aspetterebbe che fosse tra due innamorati. Però non bisogna dimenticare che stiamo parlando di Jonathan Swift e della donna della sua vita; di quello Swift che, in tempi di Illuminismo trionfante, faceva una amara parodia della ragione e di tutte le sue pretese di determinare l’umano progresso, e che si caratterizzava per l’eccentricità e l’imprevedibilità delle sue prese di posizione.
Swift era un Whig che criticava i Whigs fino al punto di passare, armi e bagagli, fra i Tories; che, inglese nato in Irlanda, si batteva come un leone a favore dei diritti dei disprezatissimi Irlandesi, fino al punto di proporre che l’Inghilterra concedesse l’indipendenza almeno a una parte dell’isola (mostrando una lungimiranza che anticipava la storia di oltre due secoli); che mescolava il serio, anzi il tragico, all’ironico e all’umoristico, come quando proponeva che si affrontasse il problema della miseria dando da mangiare ai poveri il corpo dei loro figlioletti e si compiaceva di indicare tutta una serie di ricette per preparare questi ultimi sotto forma di pietanze da tavola.
E non amava prendersela con bersagli facili: la sua polemica contro il duca di Marlborough, beniamino dell’opinione pubblica durante la Guerra di successione spagnola, fu altrettanto dura che coraggiosa; e se, alla fine, raggiunse il pieno successo, con l’allontanamento del prestigioso personaggio, lo si dovette unicamente alla tenacia e al vigore della penna di Swift, non certo al fatto che egli si fosse imbarcato in un’impresa dagli esiti scontati.
Può darsi che la sua malattia e il suo carattere solitario e sdegnoso, che infine lo condussero alla pazzia, abbiamo avuto la loro parte nelle stravaganze dell’uomo, oltre che dello scrittore; ma, come si vede, si tratta di una interpretazione alquanto riduttiva, come lo sarebbe quella che cerasse di risolvere il mistero della filosofia di Nietzsche dietro la banale “spiegazione” della sua malattia ereditaria, culminata anch’essa nella follia.
Sostenere, pertanto, che Swift spezzò il cuore delle due donne che gli avevano dedicato la vita e che le condusse alla tomba è palesemente una esagerazione e una semplificazione arbitraria: nei meandri misteriosi del cuore umano, chi può dire, con assoluta certezza, chi insegue chi e quali gratificazioni vi può trovare anche un amore infelice, finché si alimenta di speranze e della presenza della persona amata?
Quello che non è moralmente accettabile, in alcun caso, è il nascondimento; non accettabili sono l’ipocrisia, la falsità, l’inganno deliberato dell’altro.
Ora, a quel che ne sappiamo, Swift non ingannò le sue donne, non le lusingò con false promesse, non si abbandonò a imprudenti dichiarazioni di amore eterno e inestinguibile. Nonostante il suo carattere appassionato (era un vulcano semiaddormentato sotto una spessa coltre di ghiaccio), non perse mai la testa, non si abbandonò alla passionalità volubile e capricciosa dei poeti: amò in maniera profonda, ma al tempo stesso sorvegliata, per essere onesto fino in fondo, con gli altri e con se stesso.
Può darsi che egli non abbia saputo amare; come molti, del resto.
Ma non gli si può fare un colpa del fatto di aver lasciato che altri lo amasse.
Solo un grande filosofo avrebbe potuto possedere un grado così elevato di distacco dalle cose umane: non uno scrittore geniale e introverso, tanto sensibile e tanto pessimista.


