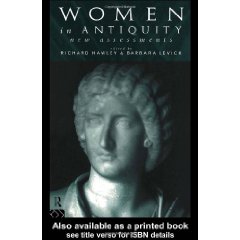Vesta: l’ascetizzazione della Dea Madre
di Lawrence Sudbury - 23/06/2011
 Altrove si è avuto modo di analizzare come tra le numerose caratteristiche della dea madre quella fondamentale risulti essere la sua capacità generativa, naturalmente legata alla sfera sessuale: sostanzialmente la dea madre trova la sua ragion d’essere e fonda la sua materia cultuale sulla sua ininterrotta generatività, simbolo, sul piano teologico, del generale potere generativo femminile.
Altrove si è avuto modo di analizzare come tra le numerose caratteristiche della dea madre quella fondamentale risulti essere la sua capacità generativa, naturalmente legata alla sfera sessuale: sostanzialmente la dea madre trova la sua ragion d’essere e fonda la sua materia cultuale sulla sua ininterrotta generatività, simbolo, sul piano teologico, del generale potere generativo femminile.
In situazioni sociali in cui tale potere femminile viene accettato senza problemi, si hanno, conseguentemente, numerosi esempi di divinità legate al femminino sacro ma i problemi insorgono laddove una società prettamente maschilista e androcentrica, fondata su virtù belliche o comunque su caratterizzazioni prettamente maschili, si senta minacciata da tale potere generativo e debba, dal punto di vista simbolico-culturale, correre ai ripari depotenziando in varie forme la valenza sacrale insita nella sessualità femminile come potenziale apportatrice di vita.
Ebbene, nella società romana, epitome praticamente fin dalla sua fondazione dei valori virili e marziali che al femminino sacro si contrappongono, tale processo di depotenziamento raggiunge una delle sue vette assolute nello sviluppo di un processo di ascetizzazione (e, conseguentemente, di asessualizzazione) della dea madre che si esplica in forma evidentissima nel culto di Vesta ma che si denota anche in numerosi culti paritetici quali quelli della “Magna Mater” e della “Bona Dea”[1], finendo, in seguito, per trasfondersi in quelle che saranno le nascenti pratiche cristiane, già abbondantemente influenzate in questo senso dall’etica giudaico-essena e dall’evidente misogenia e sessuofobia paolina.
E’ noto che Vesta fosse la dea romana della terra, discendente diretta della Hestia greca della quale assume per intero tutte le caratteristiche, connotandosi come divinità della “madre terra”, con tutto quanto da ciò può derivare in termini di generatività, “allattamento” degli esseri viventi e sostentamento umano. Insomma, sul fatto che Vesta fosse una personificazione, una delle molte “facce” della dea madre possono sussistere ben pochi dubbi e nella presenza a Roma di una divinità presente in tutto il bacino mediterraneo e praticamente in tutte le religioni del modo antico non vi è assolutamente nulla di stano, appartenendo essa ad uno degli archetipi culturali primari dell’intera umanità[2].
 Ciò che, però, risulta strano è la forma in cui tale culto si presenta già dal periodo monarchico, in particolare per quanto riguarda il servizio alla dea: il tempio di Vesta era, infatti, accudito da sei vergini che avevano il compito di mantenere vivo il fuoco sacro acceso davanti alla statua della divinità, così come prescritto, secondo la tradizione, da Numa Pompilio, “Pontifex maximus” e secondo re di Roma, già nel VII secolo a.C.. Tale pratica continuò inalterata per tutto il periodo repubblicano e imperiale e le vergini “vestali”, per altro le sole sacerdotesse “a tempo pieno” della società romana, continuarono ad essere mantenute dallo stato fino all’assunzione del Cristianesimo come religione imperiale[3].
Ciò che, però, risulta strano è la forma in cui tale culto si presenta già dal periodo monarchico, in particolare per quanto riguarda il servizio alla dea: il tempio di Vesta era, infatti, accudito da sei vergini che avevano il compito di mantenere vivo il fuoco sacro acceso davanti alla statua della divinità, così come prescritto, secondo la tradizione, da Numa Pompilio, “Pontifex maximus” e secondo re di Roma, già nel VII secolo a.C.. Tale pratica continuò inalterata per tutto il periodo repubblicano e imperiale e le vergini “vestali”, per altro le sole sacerdotesse “a tempo pieno” della società romana, continuarono ad essere mantenute dallo stato fino all’assunzione del Cristianesimo come religione imperiale[3].
Normalmente le vestali erano un piccolo gruppo elitario, scelto tra le famiglie più nobili e in vista di Roma (o estratte a sorte dal Pontifex) e sarebbe erroneo ritenere che la loro fosse una vita “monastica ” di stenti e privazioni: in realtà esse godevano di un notevole grado di libertà e, nella maggioranza dei casi, compartecipavano dei lussi e degli agi comuni alla loro estrazione aristocratica[4]. Ciò che realmente le distingueva dalle altre matrone era unicamente un voto perpetuo e intoccabile di castità e celibato. Qual è il senso di questo voto in un ambiente in cui la morale sessuale era, agli occhi della successiva società cristiana, in fondo piuttosto aperta?
Indubitabilmente il primo significato immediatamente attribuibile a questa caratteristica è quello di separazione dal normale contesto sociale femminile. Nella società romana la femminilità era definita unicamente in termini di matrimonio e riproduzione: una donna era tale solo se si sposava, divenendo così strumento di stabili alleanze, e aveva eredi a cui trasmettere le proprietà e affidare la continuità della stirpe. Per una donna essere qualsiasi cosa di differente rispetto al ruolo di moglie e madre rappresentava una anomalia[5]. In qualche modo, dunque, l’ascetismo delle vestali potrebbe spiegarsi semplicemente con la volontà di creare una cesura tra loro e il mondo circostante, rimarcando la “santità” (un concetto, in realtà, piuttosto estraneo alla mentalità romana e che dovrebbe essere inteso, più che altro, nel senso di “ieraticità”) del loro ruolo.
Resta, però, un particolare che mal si inserisce in questo quadro.
 Come corrispettivo della greca Hestia, Vesta non solo era divinità della terra ma anche delle attività domestiche, che includevano, naturalmente, i doveri coniugali e maternali[6]. Che senso poteva avere, dunque, un servizio sacerdotale virginale in netta contrapposizione con il significato ultimativo del culto divino?
Come corrispettivo della greca Hestia, Vesta non solo era divinità della terra ma anche delle attività domestiche, che includevano, naturalmente, i doveri coniugali e maternali[6]. Che senso poteva avere, dunque, un servizio sacerdotale virginale in netta contrapposizione con il significato ultimativo del culto divino?
E’ per eliminare tale contraddizione che viene sviluppata a posteriori (se ne hanno tracce solo a partire dal III secolo a.C.) una leggenda mitologica che vede in Vesta una dea eternamente vergine che rifiuta le profferte amorose sia di Nettuno che si Apollo (rispettivamente interpretabili come simboli di potere e ricchezza e di bellezza) e le cui sacerdotesse sono tenute a seguire l’esempio[7].
Un particolare, legato alle regole sacre per la scelta delle Vestali, però, palesa un significato più profondo nel vincolo virginale. Secondo tali regole le sacerdotesse (dapprima tre o quattro, poi, come detto, sei) dovevano essere scelte tra venti ragazze celibi tra i 6 e i 10 anni, naturalmente illibate e senza difetti fisici o nella parola. Condotte nell’”Atrium Vestae” dovevano giurare solennemente di servire la Dea per i trent’anni seguenti, i primi dieci dedicati all’apprendimento, i successivi dieci alle funzioni sacerdotali vere e proprie e gli ultimi dieci all’insegnamento alle consorelle più giovani[8]. Ciò significa che, in definitiva, il loro voto verginale non era perpetuo e, sebbene Plutarco[9] ci spieghi che una volta terminato il periodo prescritto pochissime di loro si sposavano (e quelle poche spesso con matrimoni infelici essendosi abituate ad una vita autonoma e non legata alla “potestas” del pater familias), sia per il dispiacere di essersi allontanate dal tempio, sia per la reverenza con cui erano considerate da uomini e donne, in realtà ciò che possiamo dedurre è che, in linea generale, la verginità vestale non era un valore in sé: se le prescelte dovevano servire la divinità dai dieci ai quarant’anni, in realtà ciò che sacrificavano era, negli anni riproduttivi, il loro potere generativo, la loro fertilità.
In sostanza, dunque, le vestali “donavano” la propria generatività alla comunità, canalizzando le loro energie psico-fisiche alla continua rigenerazione dello stato romano, rappresentato dal fuoco imperituro, simbolo della prosperità e stabilità di Roma.
 Resta da chiedersi quale fosse il senso di una rinuncia alla fertilità personale per il bene comune. Appare assolutamente ovvio che, dal punto di vista simbolico, tale utilità fosse completamente nulla e che, dunque, come naturale in ambito religioso, il vantaggio dovesse esplicarsi unicamente sul piano simbolico. Il punto è, allora, comprendere quale vantaggio derivasse a Roma da un messaggio tendente a innalzare l’infecondità a servizio a uno stato che, al contrario, si fondava sulla propria capacità di colonizzare militarmente e demograficamente aree sempre più estese.
Resta da chiedersi quale fosse il senso di una rinuncia alla fertilità personale per il bene comune. Appare assolutamente ovvio che, dal punto di vista simbolico, tale utilità fosse completamente nulla e che, dunque, come naturale in ambito religioso, il vantaggio dovesse esplicarsi unicamente sul piano simbolico. Il punto è, allora, comprendere quale vantaggio derivasse a Roma da un messaggio tendente a innalzare l’infecondità a servizio a uno stato che, al contrario, si fondava sulla propria capacità di colonizzare militarmente e demograficamente aree sempre più estese.
La risposta è implicita in quanto affermato all’inizio del presente scritto.
La fertilità, come caratteristica unicamente femminile, era, in fin dei conti, un notevole elemento di potere che si contrapponeva al potere “virile” di cui Roma si era fatta assoluta rappresentante.
La rinuncia a tale potere da parte delle vestali era, dunque, dal punto di vista della logica simbolica, un atto di sottomissione fortissimo all’imperium maschile dello stato, con la loro abdicazione al ruolo femminile e alla contrapposizione diretta tra “eros” femminino e “thanatos” maschile, che, dal punto di vista mitologico, si estendeva su piani addirittura teologici.
In cambio di tale rinuncia (e in conseguenza a tale rinuncia non essendo più necessario un controllo esterno su donne che avevano così palesemente dimostrato a loro fedeltà all’entità statale), le vestali ricevano privilegi impensabili per qualunque altra romana:
- quando usciva dal tempio ogni vestale era sempre preceduta da un littore che portava un fascio, simbolo del potere statale, così da poter essere sempre e ovunque identificabile, alla stregua dei più lati magistrati (unicamente maschi), come autorità sacralizzata;
- mentre tutte le donne di Roma rimanevano sempre e comunque, indipendentemente da rango ed età, sotto la potestà maschile, le vestali, fin dalla loro entrata nel tempio, erano sollevate da tale vincolo, tanto da poter prendere decisioni divergenti da quelle paterne, da poter condurre affari commerciali senza alcun tutoraggio parentale e da poter redigere testamenti;
- mentre ad ogni altra appartenente al sesso femminile era proibito assistere a giochi sportivi e spettacoli teatrali le vestali avevano posti riservati (in età imperiale da Augusto stesso) di fronte a quelli del pretore che sovrintendeva a tali spettacoli;
- al contrario di ogni altra romana, una vestale poteva apparire in giudizio, rendere testimonianza legale e addirittura partecipare ad ogni sorta di investigazione imperiale[10].
Semplicemente che, nel momento in cui una vestale aveva rinunciato volontariamente alla forza dirompente del proprio potere generativo, veniva inconsciamente vista non più come un rischio potenziale da tenere a bada ma come un esempio per ogni altra donna o, più propriamente, come una entità neutra (e neutralizzata), passibile di tutto il cursus honorum proprio di ogni cittadino o suddito maschile.
Naturalmente, tali onori avevano anche un rovescio della medaglia. Se le vestali erano per antonomasia figure inviolabili, le uniche colpe che potevano sovvertire questo statuto erano lo spegnimento del fuoco sacro e, soprattutto, l’acconsentire ad intrattenere relazioni sessuali durante il periodo del servizio nell’ordine, essendo queste ultime considerate alla stregua di un sacrilegio imperdonabile (“incestus”).
Qualora una vestale si rendesse colpevole di “incestus”, non poteva essere perdonata ma neppure uccisa da mani umane in quanto consacrata alla dea: veniva dunque frustata e poi vestita di abiti funebri e portata in una lettiga chiusa, come un cadavere, al “campus sceleratum”, situato presso la Porta Collina, appena dentro le mura, e lì veniva lasciata in una sepolcro chiuso ermeticamente, con una lampada e una scarsa provvista di pane, acqua, latte e olio, mentre la sua memoria veniva cancellata per sempre (“damnatio memoriae”). Il complice dell’incestus veniva, invece, fustigato a morte (la pena normalmente riservata agli schiavi) qualsiasi fosse il suo grado sociale[11].
Di fatto, almeno in periodo repubblicano, tale condanna a morte, più che una pena per l’incestus (che, in realtà, doveva accadere con una certa frequenza), pare molto più simile ad un sacrificio umano, volto, in situazioni di particolare calamità, a placare gli dèi, la qual cosa, ancora una volta, ci parla di un potere “eversivo” sotteso alla generatività femminile e, per estensione e rappresentatività simbolica, alla figura della dea madre che, finché tenuto a bada e incanalato, risulta positivo e propizio alla “cosa pubblica” ma che, allorché non compresso, deve essere distrutto proprio per la salvezza dello stato.
In parole povere, le vestali erano donne che rifiutavano il potere femminile e che smettevano, conseguentemente di essere donne, attraversando le linee di confine tra generi in un passaggio potenzialmente senza ritorno: sostanzialmente divenivano, nell’inconscio socio-culturale, maschi nel momento in cui agivano a supporto e conferma del potere maschile accettando, come afferma la studiosa Mary Beard[12], di sottomettersi ad una sorta di eunuchismo asessuato che, come provato anche dall’antropologa Deborah Sawyer[13], le rendeva “sicure” agli occhi maschili, quasi appartenessero ad una “terza categoria” e fossero prova concreta della possibilità anche teologica di controllo maschile (le regole dell’ordine vestale sono chiaramente stilate da maschi) sull’emersione del femminino.
La domanda che risulta naturale è, allora: se un femminino sacro risultava così pericoloso e destabilizzante per la società maschilista romana, perché conservarne la presenza? Non sarebbe stato più facile semplicemente cancellare il femminino sacro dall’orizzonte cultuale e mitologico?
Assolutamente no e le ragioni di tale risposta sono almeno tre.
In primo luogo, tutta la religione olimpica si caratterizzava in un rispecchiamento delle istanze umane nel sacro, parte integrante di una antropomorfizzazione di qualità astratte in divinità concrete e quindi, in sostanza, sarebbe stato totalmente inutile negare figure di potere generativo femminile nel pantheon romano quando l’emersione di tale potere era una costante propria dell’esperienza quotidiana di qualsiasi essere umano.
In secondo luogo, il culto di una “dea madre” era talmente arcaico e radicato, poggiando le proprie basi su un archetipo culturale millenario, che la stessa estromissione di una tal divinità dal panorama sacrale non avrebbe potuto configurarsi se non come una sorta di atto blasfemo passibile di ripercussioni a livello statale per le ire divine che avrebbe provocato.
Infine (e forse soprattutto), era certamente più funzionale mostrare ai fedeli un potere dirompente che si sottomette all’assetto sociale. E’ in questo senso che vanno lette alcune caratteristiche a prima vista poco comprensibili delle vestali, quali il loro vestire la stola matronale e il loro essere caratterizzate dalla pettinatura normalmente conosciuta come “sex crines” (a “sei riccioli”), tipica solo delle spose: in definitiva il loro era un matrimonio sterile in quanto ierogamico e volontariamente depotenziato, ma era pur sempre un matrimonio con l’idea stessa di virile società romana, rappresentata dal Pontifex Maximus, dal quale non solo dipendevano direttamente, ma che assumeva anche nei loro confronti una funzione paternale e maritale di controllo che nessun altro maschio avrebbe potuto arrogarsi[14].
Inutile dire che tutte queste caratteristiche verranno riprese nell’ordinazione cristiana (sia femminile che, per estensione, maschile), con la sostituzione del Dio onnipotente vetero e neo-testamentario all’onnipotente Roma, ma con la medesima volontà di sottomissione di ogni anarchico istinto generativo ad una istanza superiore.
[1] A. Carmyckel, The Vision of Women in Rome, Pendal Press 1997, pp. 62 ss.
[2] A.Staples, From Good Goddess to Vestal Virgins: Sex and Category in Roman Religion, Routledge 1998, pp. 32 ss.
[3] A. Jensen, God’s Confident Daughters, Kok Pharaos Publishing House 1996, pp.28-31
[4] Ivi
[5] G. Clarck, Women in the Ancient World, Oxford University Press 1989, pp.87 ss.
[6] A. Carmyckel, Citato, p. 83
[7] A. Staples, Citato, passim
[8] Ivi
[9] Plutarco, Vita Numae Pompilii, in M.R. Lefkovitz, M.B. Fant, Women’s Life in Greece and Rome: a Source Book in Translation, Johns Hopkins University Press 1992, pp. 288-289
[10] A. Staples, Citato, passim
[11] A. Tomlin, Roman Goddess, S. Francisco U.P. 1998, pp. 321 ss.
[12] M. Beard, Re-reading Vestal Virginity, in R. Hawley, B. Levick, Women in Antiquity: New Assessments, Routledge 1995, pp. 168 ss.
[13] D.F. Sawyer, Women and Religion in the First Christian Centuries, Routledge 1996, pp.70-71
[14] A. Staples, Citato, p.191