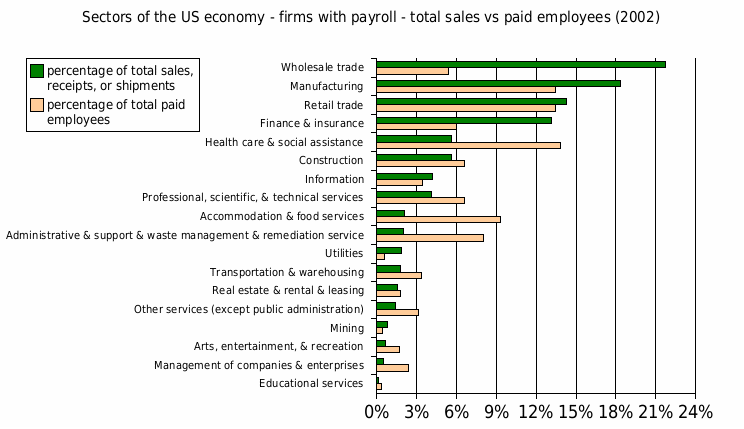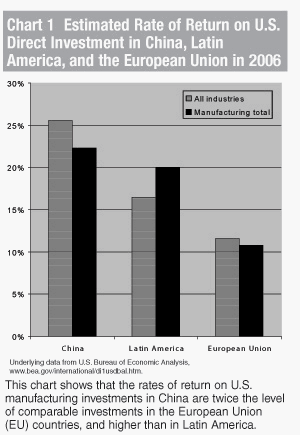Gli Stati Uniti verso il default?
di Moreno Pasquinelli - 12/07/2011
 Breve indagine sulle cause della crisi economica americana Malgrado la grave crisi che ha colpito le economie del blocco imperialistico, gli Stati Uniti rimangono saldamente la prima potenza economica mondiale — il Pil nordamericano nel 2010 è stato stimato in circa 14.700 miliardi di dollari, ossia un quarto del Pil mondiale. Restano, malgrado la crisi esplosa nel 2008, la prima nazione in campo industriale, finanziario, monetario, agricolo, scientifico, tecnologico e di gran lunga in quello militare. Sommando tutti i fattori è facile spiegare perché gli USA siano l’unica superpotenza e non abbiano alcuna intenzione di abbandonare il trono. Anche ammesso che la Cina diventi, come sostengono alcuni economisti, prima in quanto a forza economica entro il 2030 [1], non è detto che il sorpasso toglierà agli Stati Uniti, vedi tabella n.4, il rango di prima superpotenza. [2] .  tabella 1 tabella 1
Sotto ogni punto di vista gli Stati Uniti sono dunque il pilastro su cui si regge l’intero edificio del capitalismo internazionale. Dal che deriva che un eventuale crollo economico e finanziario degli Stati Uniti trascinerebbe nel baratro l’economia globale, Cina compresa ovviamente. Per questa ragione, ferma restando l’accanita competizione inter-capitalistica sul piano commerciale, nessuna potenza, Cina inclusa, ha l’interesse, dato il rischio di lasciarci le penne, a far crollare il gigante. Non è un mistero per nessuno che Pechino, se solo lo volesse — la Cina è il più grande creditore degli Stati Uniti: solo considerando i titoli di stato emessi dal Tesoro americano, il Celeste Impero ne possiede 900 miliardi —, se decidesse di portare all’incasso i suoi crediti, spingerebbe gli USA nell’abisso (vedi tabella 1). Se Pechino non lo fa, è per la doppia ragione che oltre agli interessi che vuole incassare, è solo grazie ai soldi prestati loro che gli americani possono comprare le merci e le cianfrusaglie cinesi. E’ quindi comprensibile l’apprensione cinese per l’eventualità, per nulla remota, che la Casa Bianca (magari con l’amministrazione che succederà a quella di Obama) si decida al default. Quello del debito pubblico, come vedremo, non è l’unica patologia di cui soffre il capitalismo nordamericano. Tuttavia vale la pena rinfrescarci la memoria. Esso era di 425 miliardi di dollari nel 1970, più o meno il 40% del Pil di allora. Oggi esso ammonta a 14mila miliardi. Se al debito federale aggiungiamo quelli dei singoli stati americani, delle contee delle municipalità, il debito pubblico statunitense veleggia al 130% del Pil. Una percentuale superiore al debito greco. La situazione è decisamente più grave se consideriamo i debiti delle aziende, delle famiglie, dei singoli cittadini. Sommandoli tutti, essi sfioravano nel 2009 la stratosferica cifra di 50.700 miliardi di dollari, più di 3,5 volte il Pil — tanto per fare dei confronti: 5 volte il Pil cinese e 28 volte quello italiano! [3]
Come i dati empirici dimostrano la crescita del debito pubblico e privato americano affonda le radici lontano nel tempo. Come si evince dalla tabella n.2 la curva della crescita economica USA degli ultimi trent’anni si sovrappone a quella del debito. In altre parole questa crescita è avvenuta non malgrado il debito, ma grazie ad esso. Per trent’anni gli apologeti del capitalismo hanno intonato odi sperticate alla globalizzazione, hanno parlato di seconda giovinezza del capitalismo; oggi sappiamo che questa crescita, trainata appunto dalla “locomotiva” americana, era drogata. In altre parole, dato che i consumi di massa sono dal dopoguerra la principale forza motrice, senza le iniezioni di credito ai consumi (non solo ai consumatori finali, ma alla sfera che produce i beni di consumo) non solo non avremmo avuto crescita ma, con molta probabilità, la più lunga depressione della storia del capitalismo.
Questo lungo ciclo drogato non poteva non mutare i connotati delle economie occidentali, in particolare di quella americana. L’industria manifatturiera, che negli anni ’70 contribuiva al Pil per quasi il 50%, oggi non supera la soglia del 21%, superata dal commercio all’ingrosso (24% del Pil). In termini marxisti l’economia americana (ma il fenomeno riguarda anche il grosso degli altri paesi occidentali) è oggigiorno un’economia in cui prevalgono settori improduttivi, che non creano plusvalore ma che lo consumano (vedi tabella n.3). In altre parole gli Stati Uniti, grazie alla loro supremazia finanziaria e militare, grazie al fatto che il dollaro è utilizzato come principale valuta di riserva a livello mondiale (signoraggio), captano plusvalore da ogni parte del mondo, consumano a spese del resto del mondo. Basti pensare che gli occupati nell’industria manifatturiera americana sono oggi solo il 9% della forza-lavoro totale, la metà di solo dieci anni fa.
Il risultato è che nonostante la morfina dei nuovi debiti, del quantitative easing, dei salvataggi e degli stimoli, l’attesa "robusta" ripresa dell’economia americana non c’è stata. I dati dell’ultimo trimestre del 2010 avevano fatto tirare un sospiro di sollievo al governo USA, dato che la spesa per consumi (che è oramai il principale metro di misura per stabilire se c’è ripresa o recessione) era cresciuta del 4% e il Pil aumentato del 3%. Tutti annunciavano che nel 2011 ci sarebbe stata una sostenuta crescita del Pil, un incremento della produzione, dell’occupazione e dei redditi.
Che succederà adesso? Com’è noto la Federal Reserve ha annunciato, nella speranza di prevenire una nuova crisi finanziaria o di evitare una bolla speculativa che interromperà a partire dalla fine di giugno l’acquisto di titoli di stato emessi dal governo (“quantitative easing” appunto), malgrado persisterà nella sua decisione di tenere il tasso d’interesse praticamente a zero. A questo va aggiunto che il programma di “stimoli” obamiani avviato nel 2009 sta volgendo al termine (nel 2010 il governo ha stanziato 440 miliardi di dollari di stimoli, quest’anno saranno solo 137). Va infine tenuto conto che il governo, temendo una fuga dai suoi titoli di stato, ha annunciato, già a partire da quest’anno, l’inversione di rotta, ovvero una drastica riduzione della spesa pubblica, l’aumento delle tasse, il tutto per ridurre il disavanzo di bilancio.
Se così stanno le cose, l’economia americana, dalla debolissima ripresa potrebbe ripiombare in una recessione dalle incalcolabili conseguenze, i cui effetti travalicheranno i confini degli States.
In questo contesto è francamente esilarante la cura che propongono i neo-keynesiani. Per bocca del nobel Paul Krugman essi affermano «…che la crisi che affligge l’America non è strutturale. Questa debolezza economica è determinata dalla debolezza della domanda, e per superarla è sufficiente creare più domanda». [5] La morfina non ha fatto l’effetto sperato? Iniettare dosi ancor più massicce di droga, aumentare la spesa pubblica, stampare più dollari. Non è un caso che la ricetta di Krugman corrisponda agli orientamenti e alle istanze dei pescecani della finanza speculativa «Nei mercati molti chiedono una nuova ondata di liquidità da parte della Fed. Priva di reti sociali per i disoccupati, l’America pensa quasi solo a dove trovare altra morfina». [6] La terapia suggerita cozza con un ostacolo di prima grandezza. I paesi capitalisti che detengono il debito pubblico americano, Cinesi, giapponesi ed europei anzitutto, prima o poi vorranno incassare le cedole, e quindi non solo si oppongono a nuove iniezioni di debito, ma chiedono apertamente che il governo si muova in direzione opposta: riduzione del debito e del deficit pubblici, riduzione dei debiti privati dei cittadini e delle imprese. Ove il governo non adottasse questa linea di rigore finanziario diventa plausibile una fuga dal debito USA, un movimento di vendita dei titoli di stato americani, come pure l’esodo dai titoli azionari a stelle e strisce, da quelli delle banche in primis. Nessuno vuole trovarsi carta straccia o titoli spazzatura in portafoglio. L’accorto economista Allen Sinai ha dichiarato: «Se entro la fine del 2012 il debito pubblico degli USA continuerà a crescere a questo ritmo insostenibile, può scatenarsi una nuova crisi finanziaria: ad un certo punto gli investitori smetteranno di comprare prima i titoli di Stato e poi le azioni Usa». [7] Il timore dei creditori è accentuato dall’ipotesi, cui accennavamo più sopra che, se non questa, la prossima Amministrazione (le elezioni presidenziali e del Congresso sono nel 2012) decida per un default, per una ristrutturazione del debito, ovvero un’unilaterale decisione di ridurre il valore dei crediti, e dunque degli interessi, con relativo allungamento delle scadenze di rimborso. Se dovessimo fare un pronostico la via del default — che consiste appunto nello scaricare sui creditori i costi di un lungo ciclo per cui il capitalismo americano è vissuto ben al di sopra delle sue possibilità — è quella che ha le più alte probabilità di inverarsi. Che poi una simile mossa trascini non solo le borse ma le economie dei paesi più interlacciati a quella americana (Cina e Unione europea in primis) in un vero e proprio baratro, pochi hanno dubbi. Si potrebbe obiettare che, proprio a causa di questa comunione di interessi tra grandi potenze capitalistiche, proprio per evitare un crack reciproco, cinesi, europei, giapponesi, russi, brasiliani, come pure le petro-monarchie del Golfo, cercheranno, come del resto da noi accennato sopra, di mettersi d’accordo, di trovare un compromesso. Assolutamente vero. Ma per quanto gli stati, coi loro fondi sovrani, siano attori di primissima grandezza della scena economica mondiale, esistono pur sempre potentissimi e transnazionali gruppi finanziari privati che non ubbidiscono logiche politiche ma anzitutto a quelle del massimo guadagno, masse ingenti di capitale monetario che speculano sulle valute e sui cambi, sui debiti sovrani degli stati, sul petrolio e le materie prime. Che per di più si muovono in base ad algoritmi del tutto impersonali e nel tempo reale delle linee telematiche. Nessuna autorità politica, nemmeno la Casa Bianca può pensare di tenere sotto controllo queste potenze, e ove queste sentissero puzza di bruciato, sarebbero le prime ad abbandonare la nave americana contribuendo all’inabissamento suo e dei suoi partners politici e commerciali. Che l’esito della crisi esplosa nel 2008 possa essere catastrofico è dimostrato dal fatto che la recessione innescatasi allora è la più lunga rispetto a tutte quelle che l’hanno preceduta. Riferendosi all’economia americana Sinai afferma: «Questa è la ripresa più debole, con una crescita del Pil solo del 3% nel primo anno e del 2,5% in media nel 2011: ben sotto il balzo del 6,8% tipico del primo anno in tutti i cicli precedenti quando, a partire dal sesto mese dalla fine della recessione, si creavano oltre 100mila nuovi posti di lavoro ogni 30 giorni. Tutto è cambiato con gli anni ’90. (…) Oggi siamo al 24° mese dalla fine ufficiale della recessione più grave dalla Grande Depressione e la disoccupazione è ancora al 9,1%, poco sotto il 9,5% del giugno 2009». (8) Sinai spiega quali siano secondo lui le ragioni di questa ripresa più virtuale che debole. (A) Anzitutto che il costo del lavoro negli USA è troppo alto; (B) Che sono disponibili tecnologie a costi molto bassi che sostituiscono la manodopera e deprimono i salari reali; (C) Che le imprese puntano a massimizzare il valore degli azionisti (spesso gli stessi manager) e quindi anzitutto vogliono ridurre i costi della manodopera; (D) Che il puntare al massimo profitto nel tempo più breve mal si concilia con investimenti i cui ritorni si misurano in tempi medio-lunghi; (E) Che flussi ingenti di investimenti si dirigono verso la Cina e altri paesi con costi del lavoro molto più bassi; (F) Che il modello fondato sui consumi di massa come forza propulsiva dell’economia è ormai al tramonto.
Una doppia conferma: della teoria marxiana del valore, per cui, in regime capitalistico di concorrenza, solo il lavoro produce plusvalore (da non confondere con le plusvalenze che si possono ottenere nel circuito finanziario), e che le grandi crisi capitalistiche, in ultima istanza, quali che possano essere le loro manifestazioni fenomeniche, hanno la sovrapproduzione come causa principale, ovvero che il capitale non riesce ad ottenere a valle la remunerazione (valorizzazione) ritenuta adeguata in proporzione al capitale anticipato a monte. Questo ci aiuta a spiegare la necessità di drogare il ciclo economico con gli stimoli statali, l’esodo dei capitali verso i lidi della pura speculazione, l’esportazione del capitale nei paesi a più basso costo della forza-lavoro e, alla fine, la recessione, ovvero la distruzione dei capitali in eccesso e poco profittevoli e con questo la disoccupazione di massa, la creazione di un esercito industriale di riserva per abbassare drasticamente i salari. In barba alle grandi narrazioni post-moderne e agli osanna alla globalizzazione, il capitalismo si riconferma un sistema che ha nel suo Dna la possibilità di crisi sempre più devastanti e che come terapia, vista l’inefficacia della morfina, ha sempre la medesima: distruzione generalizzata di capitali e pauperismo di massa. Moreno PasquinelliFonte: www.campoantimperialista.it/ Link: http://www.campoantimperialista.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1638:gli-stati-uniti-verso-il-default&catid=11:usa-cat&Itemid=19 11.07.2011
(1) «Immaginando che la Cina continui a crescere non del 10% annuo ma “solo” del 7,5%, e che gli Usa crescano continuativamente almeno del 2,5% il sorpasso del Pil cinese su quello americano intorno a quota 20 trilioni di dollari avverrà nel 2019. E se anche gli Usa crescessero di qui ad allora del 5%, avverrebbe comunque nel 2022». (2) Le spese per la difesa e la guerra degli Stati Uniti ammontano nel 2010 a 689 miliardi di dollari, il 20% dell’intera spesa statale e il 40% di quanto tutto il mondo spende in armamenti. La Cina nel 2009 ha speso l’equivalente di 85 miliardi di dollari, collocandosi così al secondo posto, ma a ben otto lunghezze dagli USA. (3) Si afferma, a giusto titolo, che l’esposizione finanziaria degli Stati Uniti, non va commisurata solo al Pil, ma al patrimonio netto, ovvero al valore degli asset e dei beni complessivi del paese. Quest’ultimo, alla fine del 2008, dati Federal Reserve, era stimato in 75mila miliardi di dollari, 5,2 volte il Pil. Anche da questo punto di vista lo stato di salute dell’economia americana è inquietante. (4) Martin Feldstein, Il Sole 24 Ore del 2 luglio 2011 (5) Paul Krugman, Il Sole 24 Ore del 2 luglio 2011 (6) Federico Fubini, Corriere Economia del 27 giugno 2011 (7) Allen Sinai, Intervista di M. Teresa Cometto, Corriere Economia del 27 giugno 2011 (8) Allen Sinai, Ibidem |