Stereoscopici avvicinamenti
di Luca Caddeo - 28/03/2012
«Le cose parlano con la loro forza senza nome.
Ci invade un senso di gioia, sorge il presagio
dell’ora in cui ci lasceremo alle spalle
non solo il nome, ma anche le cose».
(Ernst Jünger, La Forbice)
Nella sintetica foggia di cui ogni saggio si avvale, il presente articolo ha il fine di illustrare l’impianto metafisico che sorregge la gnoseologia jüngeriana mostrando come questa, pur mutando nel tempo a livello delle figure, resti nei fondamenti la stessa.
1.Vitali universali nella cosa
Nel bel mezzo della sua collaborazione con Mircea Eliade che si traduce nella redazione della rivista Antaios1, Ernst Jünger pubblica un lungo e complesso saggio dedicato a Martin Heidegger: An der Zeitmauer (1959). Il libro, tradotto per la prima volta in italiano nel 1961 daJulius Evola con lo pseudonimo di Carlo D’Altavilla, affronta l’argomento del tempo in chiave metastorica e astrologica e, come già era accaduto in Über die linie (1951), invita a riflettere, attraverso vari riferimenti mitologici e filosofici, sul significato del nichilismo.
In Al muro del tempo Jünger, discorrendo sull’elettricità e su come venga univocamente interpretata dal pensiero scientifico moderno, scrive:
Certamente sarebbe diverso se dell’elettricità avessimo un concetto degno di quella grande potenza terrestre che essa è […]. Lo stesso vale anche per l’immagine che abbiamo della vita delle piante e degli animali, resa meccanica in modo intollerabile. Occorre animarla, completarla con ciò che a essa manca. Così, invece, il nostro sapere resta circoscritto, al pari d’ogni rappresentazione titanica, alla visione notturna, la quale estrae dalla natura solo la parte della realtà a essa conforme2.
Sulla scorta di Goethe, Schelling e Fechner, Jünger ritiene che non vi debba essere separazione tra lo spirito o, se si vuole, la ragione e ciò che potremmo definire, generalizzando, natura. L’uomo, con i suoi strumenti intellettivi e sensibili, gli animali e il mondo materiale affiorerebbero da un medesimo ‘fondo’ vitale. La scienza odierna commetterebbe l’errore di trarre dalla natura solo la parte misurabile attraverso i ‘troppo umani’ strumenti del pensiero rappresentativo. Benché critico, Jünger è tuttavia certo che questo modo di procedere sia «indispensabile nella fase attuale, dinamica del piano». Come già rivelato in Oltre la linea, il mutamento epocale che, attraverso molteplici segnali, si appresserebbe all’orizzonte del tempo, non sarebbe giunto a destinazione perché la linea che divide la nostra epoca da quella ventura non sarebbe stata ancora interamente oltrepassata3. Che l’uomo continui ad avere una «visione notturna» di se stesso e del mondo, cioè una visione non intuitiva ed astratta, rientrerebbe così «nel paesaggio industriale e nel suo stile provvisorio» di cui Jünger ebbe occasione di tracciare i lineamenti in Der Arbeiter (1932)soprattutto col concetto di ‘Interregno’4. Ciononostante, quella parte di natura che attualmente «il pensiero astratto allontana dalla visione, non per questo è bandita dalla realtà». Essa invece continuerebbe «a co-agire», sebbene il pensiero astratto impedisca che si valuti correttamente l’elementare, il quale, come già asserito da Jünger quasi quarant’anni prima5, va reclamando ingresso:
La terra vuole essere conosciuta nella sua totalità, nucleo e guscio, vuole che la si percepisca come realtà animata. A tal fine cerca intelletti che fungano da chiave. E forse dovrà tornare a fare appello all’antica patria della rivelazione, l’Asia6.
I veri pensatori non utilizzerebbero la chiave per rappresentare l’oggetto, né rappresenterebbero l’Essere come ente per dominarlo nell’oggettivazione. Sarebbero invece loro stessi la chiave che dischiude le porte al palesamento dell’Indistinto. Partecipando alla rivelazione dell’Essere, i pensatori originari sarebbero empatici e non analitici; così, l’intelletto perverrebbe alla totalità della visione. Il tipico antiumanismo di Jünger7, di cui si sente la presenza perché il soggetto apprende proprio quando cessa di porsi come tale, affiora chiaramente anche quando, evocando il modo di conoscere dei ‘primitivi’, viene citato Martin Heidegger:
Quando parla e ascolta, l’uomo delle origini non separa ancora la causa dall’effetto, e non va alla ricerca di proprietà: coglie il contesto al modo della calamita o dell’energia elettrica […]. La considerazione di Heidegger, secondo cui ogni parlare è preceduto da un ascolto che a esso libera il cammino, centra il nostro problema8.
L’uomo delle origini attrae a sé l’ambiente all’interno del quale si appresta a conoscere; non intende la distinzione tra la causa e il suo effetto, non riduce ciò che si manifesta a misura umana e parla solo dopo aver ascoltato, cioè trasceglie i nomi dall’Indistinto dopo essersi bagnato nelle sue acque. Come si diceva, se il modo riduzionistico con cui la scienza osserva la natura è tipico della nostra èra, anche sotto la maniera scientifica di interpretare il mondo si cela una forza più profonda e inestirpabile:
[…] nelle stesse scienze della natura è nascosta una tendenza il cui obiettivo è superiore al semplice sapere e al dispiegamento di potenza che l’accompagna. Là dove s’incontra il fenomeno originario, l’intelletto si imbatte in qualcosa di più forte. Qui deve fermarsi; qui potrà essere soggetto a folgorazione, come sulla via di Damasco. Solo qui l’impulso che lo muoveva troverà vero appagamento. “Perché ogni piacere aspira all’eternità”. Ciò vale anche per la conoscenza che non riesce a saziarsi. Ecco dove ha termine il mondo faustiano9.
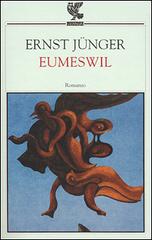 Ciò che Jünger chiama «qualcosa di più forte», su cui viene ad imbattersi l’intelletto e che non è spiegabile con la distinzione tra la causa e l’effetto10, è il ricettacolo della Forma. Quando l’intelletto incontra il fenomeno originario non può che fermarsi. Il suo impulso alla conoscenza è appagato perché è rischiarato da ‘qualcosa’ di eterno che non può essere valutato concettualmente ma che, in un senso difficilmente afferrabile, è il trascendentale di ogni misura, la sua possibilità. L’apparentemente infinito pathos della conoscenza trova così soddisfacimento, il mondo faustiano giunge a compimento. Nella jüngeriana riproposizione della visione classica del cosmo infatti l’incedere della conoscenza non può essere temporalmente illimitato perché l’energia dell’universo, destinata a ritornare trasfigurata in plurime e variegate forme, è finita. Questa prospettiva, almeno parzialmente illustrata ne L’operaio e ribadita circa trent’anni dopo in Al muro del tempo, è confermata anche nel romanzo filosofico del 1977 Eumeswil in cui, all’interno di uno scenario post-nichilista, sembra che la storia sia finita e che, in un mondo frammentato da piccole città-stato, la tecnica si sia affinata a tal punto da assumere un significato alchemico. Il protagonista del romanzo, Martin (Manuel) Venator, che di mattina è uno storico (metastorico) e di notte lavora come barista presso il tiranno di Eumeswil (il Condor), a un certo punto riassume la dottrina di uno dei suoi maestri, Bruno:
Ciò che Jünger chiama «qualcosa di più forte», su cui viene ad imbattersi l’intelletto e che non è spiegabile con la distinzione tra la causa e l’effetto10, è il ricettacolo della Forma. Quando l’intelletto incontra il fenomeno originario non può che fermarsi. Il suo impulso alla conoscenza è appagato perché è rischiarato da ‘qualcosa’ di eterno che non può essere valutato concettualmente ma che, in un senso difficilmente afferrabile, è il trascendentale di ogni misura, la sua possibilità. L’apparentemente infinito pathos della conoscenza trova così soddisfacimento, il mondo faustiano giunge a compimento. Nella jüngeriana riproposizione della visione classica del cosmo infatti l’incedere della conoscenza non può essere temporalmente illimitato perché l’energia dell’universo, destinata a ritornare trasfigurata in plurime e variegate forme, è finita. Questa prospettiva, almeno parzialmente illustrata ne L’operaio e ribadita circa trent’anni dopo in Al muro del tempo, è confermata anche nel romanzo filosofico del 1977 Eumeswil in cui, all’interno di uno scenario post-nichilista, sembra che la storia sia finita e che, in un mondo frammentato da piccole città-stato, la tecnica si sia affinata a tal punto da assumere un significato alchemico. Il protagonista del romanzo, Martin (Manuel) Venator, che di mattina è uno storico (metastorico) e di notte lavora come barista presso il tiranno di Eumeswil (il Condor), a un certo punto riassume la dottrina di uno dei suoi maestri, Bruno:
L’immagine originaria è nel contempo immagine e riflesso. Il vero e proprio punto focale della sua concezione sta nell’aver ricondotto l’idea platonica dentro il fenomeno, raggiungendo così la reviviscenza della materia castrata dal pensiero astratto. Il miracolo, egli dice, non deve sperarsi dall’alto e non dal futuro, ad esempio da uno spirito universale che si edifichi a piani sovrapposti — ma rimane in veste mutevole sempre uguale a se stesso, in ogni filo d’erba, in ogni ciottolo11.
Prendendo a prestito la voce di un personaggio fantastico, Jünger ha modo di contestare contemporaneamente il razionalismo e il platonismo (se inteso come netta divisione tra il mondo empirico e quello iperuranico). L’immagine originaria, ciò che in Al muro del tempo viene definito «fenomeno originario», è la forma in se stessa, ma anche il suo riflesso. La natura, o meglio, l’essere manifesto, è la rifrazione di un’immagine originaria. Bisogna dunque immanentizzare l’idea, immergerla nel fenomeno. Solo in questo modo la materia è colta nella sua vitalità, è «animata», come appunto Jünger sosteneva già nel saggio del ’59. Il pensiero astratto, per quanto tipico del nostro tempo, è chiaramente accusato di castrare il fenomeno della sua reviviscenza. Commentando il saggio Typus Name Gestalt (1963), Alessandra Iadicicco nota che «ponendo riparo a una troppo tracotante hybris kantiana», Jünger «riporta giù il soggetto della conoscenza e della intuizione (la Anschauung della Critica kantiana) e lo restituisce al fondo dal quale, passivamente, emerge insieme con le sue parole»12. Il soggetto conosce attraverso tale empatica immersione e risale ad una più profonda identità risorgendo nelle parole. Già ne L’Operaio, d’altronde, Jünger, illustrando la sua morfologia, scriveva che «un pensiero educato alla forma è riconoscibile poiché sa cogliere gli universalia in re»13. Si potrebbe così dedurre che se gli universalia post rem possono com-prendere una parte della realtà, soltanto gli universalia in re manifestino la Gestalt. Sotto questa luce l’essenza del mondo non può essere senza il mondo, non essendo possibile un’essenza che non sia manifestazione. Come dice Ferruccio Masini, si può parlare pertanto di una «trasparenza [...] di quell’immagine originaria (Urbild) nella quale essenza e fenomeno non sono astrattamente separati»14. Che poi, però, il necessario manifestarsi della Forma si dia, heideggerianamente, come un ritrarsi15, come assenza, non si può escludere, ma si tratta sempre dell’Essere che in quanto tale è e che, in questo o in un altro livello, si dà. Certamente, nella visione jüngeriana, i concetti universali astratti dalla cosa non sono la verità della cosa in se stessa, ma convertirebbero la realtà, complicata e ricca di inimmaginabili sfumature, in un prodotto della nostra mente e delle sue strutture (forme). Né le forme prima del fenomeno (universalia ante rem), né le forme della nostra sensibilità e del nostro intelletto (Kant), coinciderebbero con le forme di cui riferisce Jünger. Come si è accennato, con ciò non si vuole però neppure sostenere che tutto ciò che deriva dalle forme per questo debba altresì esistere nel nostro piano di realtà, ma che tutto ciò che esiste non può che procedere, anche nel modo del loro ritrarsi, dalle forme.
Venator, l’Anarca, rivela il suo modo di penetrare la realtà:
Come anarca, che non riconosce né leggi né costumi, sono obbligato di fronte a me stesso a prendere le cose alla radice. Ho allora l’abitudine di scrutarle nelle loro contraddizioni, come l’immagine e il suo riflesso. Entrambe sono imperfette – nel cercare di riunirle, come ogni mattina mi esercito a fare, ghermisco a volte un lembo di realtà16.
Prendere le cose alla radice, cioè esperirne l’essenza, significa scrutarle nelle loro contraddizioni. Secondo queste indicazioni, il pensare astratto piegherebbe ciò che valuta alla propria misura; il vedere jüngeriano lascerebbe invece intatte le contraddizioni che però sarebbero tali solo se pensate e scomparirebbero nella ‘visione’. Le apparenti contraddizioni della realtà non avrebbero inoltre una direzione che possa essere ordinata con il concetto di progresso o di scopo e non verrebbero affatto risolte da un pensare, ma, appunto, sarebbero raccolte nella loro verità da un ‘vedere’17. Certo, le forme tornano, i cicli si concludono, ne nascono altri, ma le forme archetipe, sempre coeve alla loro medesima manifestazione, sono in eterno le stesse: «Ciò che è senza tempo si ripete in modo sorprendente nel tempo»18. La realtà ricade perpetuamente su se stessa, nonostante sia possibile sostenere che le forme ritornanti siano infinite per l’uomo, ma non in sé. Riunire l’immagine e il suo riflesso diventa impresa ardua che solo occasionalmente può essere compiuta. D’altra parte, sia l’immagine presa in se stessa (qualora in sé potesse essere ‘vista’), sia il suo riflesso considerato isolatamente dall’immagine, sono imperfetti. Unire il riflesso della forma all’immagine rispettiva è il senso del vedere jüngeriano. Con ciò non si è ancora giunti alla fine del percorso perché immagine e fenomeno rimandano ad ‘altro’. Ciò che non può essere colto, che rimane ineffabile e a cui ogni altra immagine fenomenica rimanda, è l’Indistinto, se così, ex negativo, lo si vuole definire, di cui la forma che può essere vista è per l’appunto immagine o fenomeno.
2. La dottrina di Nigromontanus
 Dalla lettura dei romanzi jüngeriani si ricava un occulto sapere che pare ruotare intorno alla enigmatica figura di Nigromontanus, il quale, alla stregua del protagonista di Visita a GodenholmSchwarzenberg19, richiama alla memoria i Maestri della tradizione esoterica20. Jünger illustra la dottrina di Nigromontanus in Das abenteuerliche Herz. Aufzeichnungen bei Tag und Nacht (1929), in Auf den Marmorklippen (1939), nello stesso Eumeswil, ma anche nel romanzo filosofico Heliopolis (1949). In Il cuore avventuroso tale misterioso sapere è parzialmente rivelato attraverso la «figura metalogica dell’elusione»:
Dalla lettura dei romanzi jüngeriani si ricava un occulto sapere che pare ruotare intorno alla enigmatica figura di Nigromontanus, il quale, alla stregua del protagonista di Visita a GodenholmSchwarzenberg19, richiama alla memoria i Maestri della tradizione esoterica20. Jünger illustra la dottrina di Nigromontanus in Das abenteuerliche Herz. Aufzeichnungen bei Tag und Nacht (1929), in Auf den Marmorklippen (1939), nello stesso Eumeswil, ma anche nel romanzo filosofico Heliopolis (1949). In Il cuore avventuroso tale misterioso sapere è parzialmente rivelato attraverso la «figura metalogica dell’elusione»:
Per elusione egli (Nigromontanus) intendeva una maniera più elevata di sottrarsi a un contesto empirico. Per esempio, egli considerava il mondo come una sala con molte porte che ciascuno usa, e altre porte visibili soltanto a pochi. Come nei castelli si usa aprire, all’arrivo dei prìncipi, quei portali che di solito rimangono rigidamente sbarrati, così dinnanzi alla forza spirituale dell’uomo superiore si spalancano di colpo le porte invisibili. Nella rozza struttura del mondo quelle porte somigliano a fessure attraverso cui soltanto la più sottile abilità può transitare, e tutti coloro che le abbiano una volta varcate si riconoscono per segni segreti. Chi sa praticare così l’elusione sa anche godere, all’interno delle città gigantesche e del loro tempestoso agitarsi, di quella mirabile calma di mare che è la solitudine. Egli penetra in camere rivestite e tappezzate, in cui si è soggetti in misura minima alla forza di gravità a agli assalti del tempo. Qui si pensa con levità più aerea; in un attimo impercettibile lo spirito raccoglie frutti che altrimenti non ottiene attraverso anni di lavoro. Scompare anche la differenza tra presente, passato e futuro. Il giudizio diviene benefico come una fiamma luminosa, non turbato dagli influssi delle passioni. Qui l’uomo trova anche le giuste misure con cui deve valutare se stesso nel mettersi alla prova, quando giunge al bivio21.
Secondo Nigromontanus pertanto alcuni uomini sarebbero in grado di varcare il muro del tempo e di collocarsi intuitivamente (forse tramite una sorta di e-stasi, di elusione) in un’isola in cui il passato, il presente e il futuro non esistono. Da questa dimora essi riuscirebbero a leggere la vita attingendo ad una calma ‘innaturale’ che rende il giudizio benevolo, immune dalle emozioni contingenti legate al tempo e all’effimera permanenza dell’uomo nel fenomeno. Si afferra però anche che il mondo è ricolmo di porte, alcune delle quali (le immagini e forse i concetti più ordinari) oltrepassabili da chiunque, altre visibili e transitabili soltanto per pochi. In un mondo caleidoscopico, di immagini e di specchi, solo pochi possono percepire il prisma originario. Anche se, lo si ripete, non penso che ciò possa significare comprendere, almeno nella comune accezione del termine, il mondo dell’Indistinto nella sua essenza. Certamente, però, alcuni si avvicinano di più alla sua almeno simbolica visione22. In Heliopolis, il personaggio Phares racconta quanto appreso da Nigromontanus che, nel romanzo, è il maestro del protagonista Lucius:
Noi lo conosciamo e lo apprezziamo. Vediamo la sua intenzione nel colmare la superficie con la profondità, in modo che le cose siano simboliche e al tempo stesso reali. Così la visione si dispone come una pelle variopinta attorno alla figura imperitura23.
Alla stregua di quanto sinora sostenuto, riempire la superficie con la profondità equivale a immergersi nell’Indistinto e risalire nella costruzione di ‘cose’, pensiamo sia interiori che materiali, che siano al contempo simboliche della Forma e reali. L’apparente discrasia tra la profondità e la superficie, che sta alla base dell’insegnamento di Nigromontanus, è un tema caro a Jünger sin dal 1929, anno della prima pubblicazione de Il cuore avventuroso, opera data nuovamente alle stampe sei anni dopo L’operaio che, lo ricordiamo, è del 1932. Ciò è significativo perché è un segnale della presenza della metafisica delle forme prima de L’operaio e, allo stesso tempo, è la conferma di come Jünger creda, anche dopo Der Arbeiter, in questa metafisica: lo stesso Operaio dovrebbe dunque essere letto come un esempio, una delle tante estrinsecazioni della Forma, precisamente come Gestalt des Arbeiters.
Nel saggio Sulla cristallografia, che fa parte de Il cuore avventuroso, Jünger scrive di aver imparato nel corso degli anni «qualcosa di quella capacità propria dell’arte del linguaggio, che rischiara la parola fino alla trasparenza»24. Tale capacità è adatta a risolvere «il dissidio tra la parvenza esteriore e la profonda realtà della vita»25. Il senso della sublime parvenza della realtà costellata da segni starebbe in una «realtà profonda»26. Possiamo dunque «vivere volti all’esterno» oppure, nonostante l’immancabile presenza del dolore, «all’essenza interiore»27: «La trasparente visione che si forma è quella in cui risaltano ad un tempo, intelligibili al nostro sguardo, la profondità e la superficie»28. In altri termini, in certe circostanze, saremmo capaci di scorgere la natura cristallina del mondo nel quale la realtà apparente è a volte in grado di «esternare la propria profondità»29. L’immagine del cristallo è illustrata perfettamente da Maurizio Guerri che scrive:
Così come nella contemplazione del cristallo l’osservatore fissando la superficie scivola nella profondità e comprendendo la forza generatrice è ricondotto necessariamente all’apparenza esteriore, analogamente ogni essere umano sperimenta nel corso della propria esistenza eventi dotati di questo “carattere cristallino”30.
Alcuni di questi momenti in cui uomini e cose si illuminano e in cui la profondità del reale si renderebbe di colpo trasparente, sarebbero non solo l’esperienza della bellezza, ma anche ad esempio la morte 31 e, soprattutto, l’apparizione della Verità. Jünger si spiega con un esempio:
[...] in un colloquio di cose che ci toccano nell’intimo, le voci divengono trasparenti; noi comprendiamo il nostro interlocutore, attraverso lo schermo costruito dalle sue parole, in un altro senso, quello decisivo [...] potremmo supporre l’esistenza di punti in cui questa sorta di acuta visione non nasca da un inconsueto stato di grazia, ma sia parte essenziale di una mirabile verità perenne32.
Il linguaggio permetterebbe all’uomo di rendere attuali alcune proprietà della realtà che senza di esso sarebbero rimaste in potenza. La più importante, come si diceva, è quella secondo cui la realtà si dà nel linguaggio in tutta la sua trasparente profondità. Jünger infatti scrive:
Per quel che riguarda [...] l’uso delle parole, esso trae forza dalla natura stessa del linguaggio, che possiede a sua volta profondità e superficie. Ci accade di usare innumerevoli espressioni in cui è insito un significato ovvio e insieme un senso recondito; ciò che nel mondo visibile agli occhi è la trasparenza, qui è la segreta consonanza. Anche nelle figure dello stile, in primo luogo della similitudine, molto dipende da come si supera l’illusione di un discorso contraddittorio. Occorre, però, procedere con agilità: se si usa una lente affilata per spiare la bellezza degli animali infimi, non si abbia poi il timore d’infilare un verme all’amo, quando si voglia carpire qualcosa della mirabile vita che popola gli oscuri abissi delle acque. Ma dall’autore sempre si deve esigere che le cose non gli appaiano isolate, non alla rinfusa e non casuali: il dono della parola gli è stato concesso perché egli lo indirizzi all’Uno e al Tutto33.
Grazie a un linguaggio che, anche in questo caso, risulta essere allegorico e intuitivo, in quanto idoneo a superare, in una «imparziale visione», le contraddizioni insite nelle cose, l’uomo possiederebbe la capacità di attingere ai fondali della verità che conducono all’Unità, al Tutto, rischiarando l’antica formula delle Upanishad, citata da Jünger in Tipo Nome Forma, secondo cui «questo (cioè ogni ente della Natura e ogni uomo) sei tu»34. La formula sintetizza l’unità tra il Brahman – l’energia cosmica e impersonale – e l’atman – l’energia personale. Secondo Luisa Bonesio nel «questo sei tu» «è annullata ogni coscienza separata, l’io è trasceso in una dimensione ultraindividuale, restituito alla “propria essenza immobile e sovratemporale”»35. Tale superiore identità tra l’io e la sua immobile essenza ci riporta, in parte, a Plotino per il quale se da un lato il Principio «non è alcuna di quelle cose di cui è principio, poiché nulla si può predicare di esso, né l’ente, né la sostanza, né la vita» essendo «sopra tutte queste cose»36, dall’altro, benché non si possa afferrare il Principio «facendo astrazione dall’essere», ci si può «dirigere» a «lui» e si può «riposare» «in lui» contemplando «la sua grandezza attraverso gli esseri che sono dopo di lui»37. Le cose che sono ‘dopo’ il Principio sono irradiazione dello stesso. Non a caso, la parola Strahlungen (irradiazioni) dà il titolo ai diari di Jünger. L’autore di Der Arbeiter è difatti particolarmente affascinato da questa parola proprio perché richiama la sua concezione metafisica che lui stesso avvicina alla metafisica del neoplatonismo tanto da rivelare ad Antonio Gnoli e Franco Volpi: «“Irradiazione” è una parola quasi metafisica, come “emanazione”: indica un modo in cui l’energia si trasmette, sia in senso materiale, sia in senso spirituale»38. Più avanti, riferendosi alla metafisica de L’operaio, Jünger annota: «In realtà la mia era per così dire la visione neoplatonica di una nuova forma che imprimeva il suo carattere a tutta la realtà: la forma del Lavoratore»39. L’Operaio è dunque concretamente foggia del Principio e ambisce a mobilitare e a formare in suo nome tutta la realtà. L’Uno, il Principio a cui l’uomo può avvicinarsi con i metodi di cui stiamo discorrendo, può essere però esperito solo per mezzo della perdita dell’individualità. Questo aspetto è molto importante se, tornando a Der Arbeiter, si consideri come l’uomo, per divenire Tipo della Forma dell’Operaio, debba dissolvere, impiegando la tecnica, il proprio io, i suoi desideri soggettivi, le sue particolari aspirazioni, la sua irripetibile (e borghese) felicità40. L’Operaio come i mistici, i veggenti o come chiunque abbia una intuizione che gli permetta di varcare, tramite uno strappo (elusione) del velo dell’illusione, l’anticamera dell’Essere, conosce la forma solo sacrificando la propria identità per riscoprirla trasfigurata nella partecipazione all’epifania gestaltica. Si coglie così meglio come l’Operaio sia una forma metafisica e come Jünger, nell’arco della sua lunghissima esistenza, si rifaccia, rivedendola anche alla luce del pensiero contemporaneo, essenzialmente ad una dottrina all’interno della quale il Milite Ignoto, l’Operaio, il Ribelle, l’Anarca trovano il loro esatto senso se intese alla stregua di Figure di un unico incomputabile, indistinto Principio formale. D’altronde, che si possano leggere testi come Il cuore avventuroso (1929) e La forbice (1990), che distano l’uno dall’altro ben sessantuno anni, riscontrando rispetto ai fondamenti metafisici che sempre fanno da sfondo alle impressioni jüngeriane, una pressoché perfetta sintonia di vedute, è un altro indizio che comprova tale convinzione.
Nel saggio intitolato Il piacere stereoscopico Jünger introduce una metafora, quella dello stereoscopio (caleidoscopio), che è utile a illustrare analogicamente la gnoseologia della quale si discute. Dopo avere raccontato di quel piacere che consiste nella «sensibilità stereoscopica», la quale, alla semplice visione di un colore, ci permette simultaneamente di avere l’impressione di penetrare nella cosa, di toccarla, scrive:
Percepire in maniera stereoscopica significa acquisire contemporaneamente, nella medesima sfumatura o gradazione e mediante un unico grado di senso, due qualità sensorie. Ciò è possibile solo in quanto un senso, oltre alla sua propria facoltà, assume in più le attitudini di un altro senso41.
Un senso, ad esempio la vista, assume le facoltà di un altro senso, ad esempio il tatto, dal quale, si legge più avanti, deriverebbero «tutti gli altri sensi»42. In questo caso, Jünger sta mostrando come attraverso i sensi, in particolari occasioni e se si è dotati della sensibilità stereoscopica, si possa penetrare al di là dell’apparenza, nella profondità della realtà; per questo egli scrive che l’efficacia della stereoscopia sta:
nel fatto che le cose si afferrano con la tenaglia dal di dentro. Che ciò avvenga mediante un solo senso, il quale per così dire, si scinde, è una circostanza che accresce l’esattezza della presa. Il vero linguaggio del poeta si distingue mediante parole ed immagini afferrate proprio in questo modo, parole che, pur essendoci note da molto tempo, si dischiudono come fiori, e dalle quali sembra sgorgare un intatto splendore, una musica colorata. E’la nascosta armonia delle cose che qui si fa suono, e della cui origine dice Angelus Silesius: Nello spirito, i sensi son tutti un senso e un uso: chi vede Dio, lo gusta, lo tocca e ascolta e annusa 43.
Si nota la somiglianza con quanto asserito nel saggio del 1963 Tipo Nome Forma. La formula «questo sei tu» è infatti già presente nella dottrina della sensibilità stereoscopica. In virtù di questa sensibilità alcuni uomini hanno la capacità di ‘allargare’ le proprietà di un senso fino a penetrare in uno o negli altri sensi; tale dilatamento dei sensi, tale ‘sregolamento’, ci accompagna intuitivamente nei pressi della verità, della quale si ha una esperienza sensoriale più che meramente logica, un’esperienza prelogica. L’uomo resta, anche in questo caso, al di qua della comprensione esatta del Principio. Il Dio di Silesius è visto, gustato, ascoltato, annusato; non è pensato nella sua essenza. Si tratta di entrare dentro la cosa e, in qualche modo, di essere la cosa stessa. Ciò si arguisce dal passo che chiude il saggio:
Ogni percezione stereoscopica suscita in noi una sensazione di vertigine, e intanto assaporiamo in profondità un’impressione dei sensi che in principio ci si offriva in superficie. Tra lo stupore e il fascino si colloca, come dopo una deliziosa caduta una scossa che cela in sé una conferma- noi sentiamo che il gioco dei sensi si muove leggero, quasi misterioso velo, quasi sipario del meraviglioso. Su questa tavola imbandita non esiste cibo che non contenga un granello d’aroma d’eternità44.
Tutta questa teoria ci fa comprendere come l’unico modo reale per esperire la Forma sia essere linguaggio della forma. Così, l’Operaio non ha bisogno di pensare la forma, di contemplarla: è Operaio quando la agisce più che quando la pensa; è Operaio quando è al servizio della Forma che si appalesa totalmente proprio tramite il linguaggio, ad un tempo elementare e metafisico, della tecnica.
Per capire il rapporto tra le forme e il piano da cui provengono, torniamo all’immagine del caleidoscopio. Nel caleidoscopio vediamo un’immagine riprodotta svariate volte contemporaneamente. L’immagine originale risulta non solo moltiplicata, ma trasformata dall’interazione degli specchi che costituiscono lo strumento. Esiste dunque qualcosa di non afferrabile in se stesso (nello specchio vediamo essenzialmente la nostra immagine, non lo specchio) che ha il potere di riflettere all’interno di ogni ciclo cosmico delle immagini eterne. Se giriamo il caleidoscopio le immagini sono diverse pur restando, nella loro provenienza, le stesse. Ci sarebbero così dei mutamenti cosmici che potrebbero essere paragonati ad un capovolgimento del caleidoscopio. Se ruota il piano dell’essere, tutto ciò che in questo piano veniva in precedenza riflesso in un determinano modo, è visto in un altro, anzi in infiniti altri modi. Può allora essere possibile che i fenomeni siano infiniti e che ciò di cui sono il riflesso sia invece, oltreché eterno, compiuto, finito. In questo senso, solo se ci riferiamo al piano e al capovolgimento degli specchi, le forme possono essere infinite, dunque mortali, e, nella loro essenza, al di qua del piano degli specchi, finite e immortali. Per comprendere ancora meglio può essere utile riferirsi ad Heliopolis. Tramite il personaggio Fortunio, Jünger descrive la discesa in un misterioso cratere (situato nei pressi di una foresta di cristalli, davanti alla catena grigio-argentea del Caucaso) che ci sembra il simbolo della verità vista tramite il riflesso atavico della bellezza, il simbolo dell’ebbrezza che si prova quando si è pervasi dalla Verità sotto la forma della infinita multi-formità:
Discendere nel camino interno del cratere assomigliava al divertimento che si prova a girare un caleidoscopio i cui disegni divengono sempre più vari. E in maniera ancora più meravigliosa la meta cominciò a risplendere: era il fondo dell’occhio. Esso appariva fiorito in superficie. Come la pelle vellutata dei serpenti, come il bagliore delle madreperle che adornano le meraviglie del mare nei banchi coralliferi. […] Mi accorsi di essere penetrato in un rifugio cosmico, in una grotta dove si custodiva il tesoro dell’universo. Talvolta, in occasione delle mie peregrinazioni nella zona che si estende ai piedi dell’alta montagna, ero disceso nei mulini glaciali […] dove l’epoca glaciale si scioglie. [...] in luoghi simili i nostri sensi evocano sempre la presenza dell’assente, così come nell’officina abbandonata è proprio il maestro colui che ci sta più vicino. L’ala de


