Ottant’anni. McCarthy tra lo spirito della frontiera e la critica dell’American dream
di Giorgio Ballario - 22/07/2013
Fonte: barbadillo
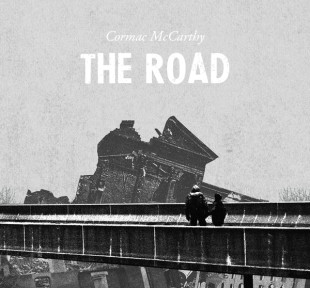 Ci dev’essere un motivo per cui, nell’ultimo secolo, i più grandi scrittori americani si sono rivelati spesso anche grandi “antiamericani”. Si pensi a Charles Bukowski, a John Fante, a Truman Capote, a Tom Wolfe. Per non parlare di Ezra Pound, fino ad arrivare ai più recenti Gore Vidal e Chuck Palahniuk. Tutta gente che nelle proprie opere ha fatto a brandelli l’American Dream e ha scientificamente demolito le solide certezze sulle quali poggia la vita dello statunitense medio: la fiducia “cieca, pronta e assoluta” nel futuro e nel progresso della patria a stelle e strisce; il mito del “Self made man”, il primato dell’economia sulla politica; la prevalenza dell’individuo sulla società; la convinzione di essere sempre e comunque dalla parte della ragione.
Ci dev’essere un motivo per cui, nell’ultimo secolo, i più grandi scrittori americani si sono rivelati spesso anche grandi “antiamericani”. Si pensi a Charles Bukowski, a John Fante, a Truman Capote, a Tom Wolfe. Per non parlare di Ezra Pound, fino ad arrivare ai più recenti Gore Vidal e Chuck Palahniuk. Tutta gente che nelle proprie opere ha fatto a brandelli l’American Dream e ha scientificamente demolito le solide certezze sulle quali poggia la vita dello statunitense medio: la fiducia “cieca, pronta e assoluta” nel futuro e nel progresso della patria a stelle e strisce; il mito del “Self made man”, il primato dell’economia sulla politica; la prevalenza dell’individuo sulla società; la convinzione di essere sempre e comunque dalla parte della ragione.
Anche Cormac McCarthy, che in questi giorni ha compiuto 80 anni (è nato a Providence, Rhode Island, il 20 luglio del 1933, ma è poi cresciuto nel Tennessee), a ben vedere rientra in questa categoria. Perché se è vero che molti dei suoi romanzi aderiscono perfettamente allo “spirito della frontiera”, che nel secolo XIX fu carburante indispensabile per l’espansione del giovane Paese; è vero pure che la sua America è quella degli sconfitti dal progresso. È l’America che avrebbe potuto essere e non è stata. O forse l’America che non sarebbe stata comunque, ma merita lo sguardo nostalgico e disincantato che lo scrittore del Tennessee riserva ai vinti dalla Storia.
Un grande uomo contro, McCarthy. Da sempre fuori dal coro e non solo per la sostanza delle sue opere. Fuori dal coro anche per i suoi bizzarri comportamenti personali: ha sempre rifiutato di partecipare ai riti della società letteraria, non ha mai dato letture pubbliche dei suoi libri, mai accettato di tenere conferenze, mai tenuto corsi di “creative writing”, mai concesso interviste se non un unico laconico incontro con un inviato del New York Times, a cui ha parlato più di serpenti e di cavalli che di se stesso. In quella famosa intervista McCarthy – che all’epoca viveva in un piccolo cottage a El Paso, al confine fra Texas e Messico – raccontava fra l’altro di tagliarsi i capelli da solo, di lavare la biancheria nelle lavanderie pubbliche e di non essere mai stato interessato a un lavoro fisso. Diceva anche di non amare il mondo letterario e di appartenere a un genere di scrittore che ha cessato di esistere.
Nato sulla costa orientale degli Usa da una famiglia di origine irlandese, a quattro anni Cormac si trasferisce con la famiglia a Knoxville, nel Tennessee. Frequenta la scuola cattolica, poi si iscrive all’università del Tennessee ma a vent’anni si arruola nell’esercito, trascorrendo quattro anni sotto le armi. Tornato a Knoxville nel ’57 riprende gli studi universitari e comincia a scrivere racconti. Nel ’61 si sposa con Lee Holleman (dalla quale ha un figlio), si trasferisce a Chicago e pochi anni dopo divorzia. Nel ’65 pubblica il suo primo romanzo, “Il guardiano del frutteto”; poi grazie a una borsa di studio s’imbarca per l’Europa, dove intende visitare l’Irlanda e l’Inghilterra. Qui conosce la sua seconda moglie, Anne De Lisle, con la quale vivrà fino al ’76. Tra il 1968 e il 1973 pubblica altri due romanzi, “Il buio fuori” e “Figlio di Dio”, che registrano una buona accoglienza da parte della critica ma vendite modeste.
Il 1976 per Cormac McCarthy è l’anno della svolta. Umana e professionale, perché si separa dalla seconda moglie e si trasferisce a El Paso, alla frontiera con il Messico. È qui che compone i due romanzi che gli faranno fare il salto di qualità: “Suttree” nel ’79 (ma in Italia verrà pubblicato solo vent’anni dopo) e “Meridiano di sangue” nell’85. Due storie aspre, la prima ambientata nel Tennessee degli Anni 50 e la seconda nel West di metà Ottocento, in cui prende forma il “marchio di fabbrica” di McCarthy: lo stile scabro ed essenziale, la descrizione di una natura contraddistinta da grandi spazi e grandi silenzi, personaggi solitari e laconici che diventano pedine di una tragedia quasi classica, in cui il Fato e le leggi di Natura prevalgono quasi sempre sulla volontà umana.
Tematiche che vengono ulteriormente sviluppate e ampliate nella cosiddetta “Trilogia della frontiera”, scritta tra il 1992 e il 1998 e composta dai romanzi “Cavalli selvaggi”, “Oltre il confine” e “Città della pianura”, in cui l’ambientazione di moderno western (siamo negli Anni 40 del XX secolo) e i valori tradizionali della frontiera (libertà, coraggio, senso dell’amicizia, vita in simbiosi con la natura) sono ormai quasi soffocati dalle logiche capitaliste della predazione e della ricerca del profitto. «C’è un pericolo in agguato – ha scritto Livia Manera su La Stampa – , il cliché della Marlboro Country, il cavaliere solitario e la “dura terra” del West, uno dei miti più resistenti della modernità americana, che non a caso Sam Peckinpah ridimensionava con un’ironia spavalda. McCarthy invece lo affronta facendo in modo che i personaggi e le loro azioni parlino un linguaggio poetico». Poetico e credibile, ci sarebbe da aggiungere.
Così come è credibile la figura, tutt’altro che eroica ma virilmente legata ai valori tradizionali, ormai in via di sparizione, dell’anziano sceriffo Bell di “Non è un paese per vecchi” (2005) , la cui trasposizione cinematografica dei fratelli Coen (con uno straordinario Javier Bardem) ha reso McCarthy celebre in tutto il mondo.
Cambiano i tempi (siamo nel futuro) e cambia l’ambientazione (un’America irriconoscibile e per nulla circostanziata), ma nella sua ultima fatica, “La strada”, uscita in Italia nel 2007, riaffiorano prepotentemente i temi più cari a McCarthy. Le utopie americane si sono realizzate alla rovescia e i miraggi del progresso hanno condotto alla barbarie. Un mondo di terremoti, incendi e tempeste, di metropoli rase al suolo. Di sterminate lande di cenere, senza più animali o piante verdi, cadaveri umani disseminati ovunque. Un mondo post-nucleare, probabilmente.
Ma se McCarthy presenta la fine del mondo non è per denunciare con piglio ambientalista future catastrofi ecologiche. A lui interessa l’uomo e così come la sua scrittura procede per sottrazione, sempre più scarna ed essenziale; lo stesso accade per l’ambientazione del romanzo, in cui lo sfondo è ormai cancellato e rimangono solo gli esseri umani. Le loro relazioni reggeranno all’urto del nuovo mondo? Fino a che punto l’uomo è ancora tale? E cos’è, in fondo, un essere umano? Domande alle quali l’autore americano non risponde in modo esplicito, anche se dà al lettore una traccia morale prima ancora che filosofica raccontando il lungo viaggio verso il mare di un padre e un figlio ragazzino.
Come ha scritto Claudio Asciuti su Rinascita, “La strada” è una sorta di Anabasi moderna: i due protagonisti affrontano «una serie di prove che segnano il passaggio dalla vita “protetta” del figlio a quella “sulla strada”, ma senza la perdita dell’innocenza che rimane il suo carattere distintivo, al di là del cinismo del padre: una sorta di tradizionale “rito di passaggio” all’età adulta, segnato da una sorta di epica greca: quando il padre dà al figlio la consegna “noi portiamo il fuoco”, è facile intravvedere in queste parole l’idea dell’eroe civilizzatore, del Prometeo che ruba il fuoco agli Dèi donandolo agli uomini e inizia la civiltà». Anche “La strada” è diventato un film, ma dato il tema molto poco hollywoodiano non ha ripetuto il successo planetario di “Non è un paese per vecchi”. Siamo certi che il vecchio Cormac, nella sua nuova casa di Santa Fe, in New Mexico, dove è andato a vivere con la terza moglie e una figlia piccola, se ne sarà fatto una ragione.


