L’amore svedese, l’autogenerazione e altre storie dal tono apocalittico
di Simone Sauza - 24/09/2016
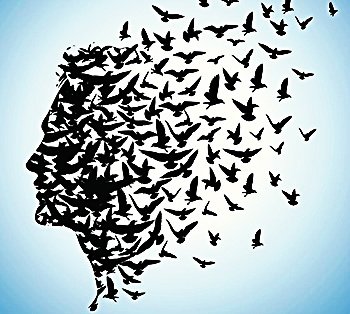
Fonte: linkiesta
Uccidere i propri padri. Una ben strana ingiunzione, che gioca sul limite tra l’interdetto e la legge, tra la proibizione e l’imposizione, è scolpita nel cuore freudiano dell’Occidente. Eppure anche il giovane Kafka, nella sua celebre resa dei conti epistolare, per affondare il coltello verso il terribile padre-padrone non può fare a meno di amarlo in maniera inconfessabile. Non può fare a meno di condannarlo con senso di colpa. Perché, infine, non può fare a meno di riconoscerne la filiazione, che non è solamente biologica.
Il rapporto padre-figlio, fino a modernità inoltrata, ha significato la trasmissione di un insieme di regole non scritte, un orizzonte di senso, una serie di “codici” per mappare il mondo. Questo a qualsiasi latitudine culturale: anche ad un livello culturale basso esiste un orizzonte di senso da trasmettere. Un filo che costituiva una connessione inter-generazionale nel tessuto storico-sociale dell’uomo. Poco importa che questo potesse avvenire attraverso tensioni o lacerazioni. Il momento del distacco stesso si nutre della filiazione: l’uscita dalla condizione di dipendenza dai genitori, il superamento dei modelli non può che avvenire attraverso la rielaborazione di codici pre-esistenti. Insomma: anche il figlio più ribelle è condannato ad essere un bravo figlio. Forse oggi qualcosa sta cambiando. Quel trattino, che distingue ma non separa, viene sempre meno. Non più padre-figlio, ma padre “e” figlio. Due entità distinte e, se possibile, radicalmente indipendenti.
Dagli anni 70’ ad oggi, l’imperativo culturale è stato: relativizzare! Una tendenza alla decostruzione radicale di qualsiasi istituzione (da intendere nel senso più ampio possibile). Come se qualsiasi cosa di positivo (positum, qualcosa di posto), già solo per essere potenzialmente un qualcosa che resiste al divenire, che fornisce dei nuclei di senso forte (con un po’ di coraggio si potrebbe azzardare il termine “valori”), fosse automaticamente “cattiva metafisica” da distruggere. Ma un’epoca che scorre incessante senza riconoscere dei fili che la percorrono, non conosce sedimentazioni di senso che producono “Storia”. Ecco il paradosso. Se accettiamo una rudimentale definizione della Storia come Tempo + Senso, allora la postmodernità è un tempo che annuncia la fine del tempo. Il padre non ha allora nulla da tramandare, nessunatraditio che possa avere influenza nell’oggi. Per un motivo semplice: tradizioni, pratiche e usi condivisi sono oggetti storici; mentre, secondo quanto detto, la postmodernità è un tempo a-storico. Il Seymour Levov di Pastorale Americana ha dovuto impararlo a sue spese. Parliamo forse di un’epoca che non segue più né l’andamento lineare del tempo cristiano, né quello circolare del pensiero greco, ma scorre secondo un andamento a spirale: avvitata su se stessa.
La modernità tarda è un’epoca che vive un’accelerazione senza precedenti: tanto in ambito tecnologico che in ambito sociale. È propriamente l’epoca dell’accelerazione.Dai mutamenti in ambito lavorativo, alle abitudini di vita, non c’è aspetto che non si sia esponenzialmente velocizzato o che non subisca cambiamenti estremamente repentini in un arco ristretto di tempo. Il mondo sociale non rimane stabile nemmeno nel corso della singola vita adulta di un individuo. Le entità “padre” e “figlio” faticano a riconoscersi reciprocamente, come se la distanza generazionale fosse decuplicata rispetto ai gap di epoche precedenti. Così il rapporto padre-figlio diventa un rapporto uno a uno, due individualità che tra loro intrattengono una relazione di tipo biologico, affettivo, ma non più storico-culturale. Da questo punto di vista essi non sono molto più che estranei, e questo fin dalle prime età della vita del figlio, ben prima della fase del distacco.
Non facciamo altro che scontare il fantasma dell’auto-generazione, cioè l’idea che ognuno possa bastare a se stesso e creare la sua vita dal niente. E a questo fantasma diamo nome indipendenza o libertà. I legami (con la storia, con le istituzioni, con gli altri), per questo individuo nuovo, funzionerebbero, in termini psicoanalitici, comememento del “limite” al godimento e alla volontà soggettiva. Di conseguenza diventano catene da distruggere. Ma questa rottura è anche l’accesso a una dimensione di pura possibilità che paralizza e che costruisce un tempio dell’angoscia: è la rottura di qualsiasi mappatura del mondo che ereditiamo. È come voler far rinascere il mondo di generazione in generazione, di volta in volta, una sorta di eterno ritorno della creatio ex nihilo. Hegel aveva posto il buon funzionamento di una comunità politica nell’incontro tra libertà soggettiva (che potremmo ritradurre come quello spazio individuale che la modernità ha meritoriamente fatto emergere) con la libertà oggettiva (i doveri derivanti dal contesto comunitario dei costumi e delle prassi condivise). Una posizione che potremmo rendere, usando un linguaggio contemporaneo, come il fatto che si vive sempre all’interno di frame determinati:all’interno, cioè, di cornici che implicano limiti all'azione, regole non scritte e codici comportamentali. Frame nei quali possono rientrare le cose più disparate, come la genitorialità. Chi vive in una dimensione tendenzialmente di pura possibilità è l’adolescente. Perché egli è l’individuo che, soprattutto nelle società moderne e occidentali, non riveste ancora nessun ruolo sociale. La sua identità sociale è in fase di costruzione. Di conseguenza tende a muoversi nello spazio pubblico al di fuori di frame di riferimento (se sia possibile essere completamente fuori da questi frame è un problema a parte): in pratica, non ha fonti da cui attingere quei doveri oggettivi di cui sopra. Cosa accade se questo paradigma adolescenziale diventa la condizione alla base dell’intera società? Accade la Svezia.
O almeno, la Svezia rappresentata dal regista Erik Gandini che, dopo Videocracy, esce (oggi) in Italia con La teoria svedese dell’amore. Famiglie monogenitoriali, inseminazione artificiale, indipendenza, indipendenza, indipendenza. È il mantra su cui si basa una intera visione antropologica che ha permeato la società svedese. Il tassello finale di una società europea che era già tra le più avanzate in termini di progresso, benessere, assistenza sociale, ma che, dopo gli anni 70, ha sentito il bisogno di rivoluzionare la propria concezione delle relazioni umane. Liberare le donne dagli uomini, gli anziani dai figli, gli adolescenti dai genitori. Eppure, come mostra Gandini non senza una certa ironica partigianeria, non è andata così. Perché la Svezia mostrata nel docu-film –non lontana dalla Finlandia del cinema di Aki Kaurismaki - è quella infelice della solitudine e delle pareti silenziose entro le quali si muore nell’anonimia più totale; dove agenzie ad hoc hanno l’incarico di ricercare l’identità di un cadavere trovato dopo settimane dentro un condominio in periferia, dimenticato da figli e parenti che hanno smesso di rivestire da tempo la condizione simbolica di figli e parenti. Chi era, chi ha amato, da chi era amato, sono domande di difficile risposte là dove il massimo dell’emancipazione coincide con il massimo dell’isolamento. Allora viene il sospetto che qualcosa non quadra. Che ci deve essere una confusione a livello semantico. Che forse si sta scambiando per moderno qualcosa che non lo è affatto. Si potrebbe obiettare, tanto per dirne una, che non c’è nulla di pacifico nell’usare in maniera interscambiabile due concetti ingannevolmente simili come “Indipendenza” e “Autonomia”. Quest’ultima è l’essenza stessa della modernità. Un compito che preludeva ad una società ideale in cui i progetti di vita non sarebbero stati ostacolati, o lo sarebbero stati in maniera via via minore, dalle condizioni di nascita e dalle morali eteronome. Il senso della vita, utopia o ipocrisia che fosse, per la prima volta nella storia dell’umanità non sarebbe stato predeterminato. Nella “teoria svedese” (semplifichiamo e condensiamo in questa dicitura un’intera ontologia sociale che informa il postmoderno) l’imperativo è il non dipendere dagli altri. “Liberi gli uni dagli altri”, si sente ripetere spesso nel film, come se questo fosse il passo decisivo nell’emancipazione dall’individuo. L’autonomia – e quindi la libertà – viene tutta schiacciata sull’indipendenza: il che equivale a considerare l’altro - o forse sarebbe più corretto dire qualsiasi alterità - come un nemico. Rifuggi il prossimo tuo. Come se la postmodernità fosse uno stato di natura 2.0.
Nel momento in cui saremo tutti svedesi, le lettere ai padri dei giovani kafka che fine faranno? Verso chi ci ribelleremo? La liberalizzazione della vita ci ha voluto donare quelli che prima erano oggetti di trasgressione; dando per scontato che quegli oggetti potessero vivere al di fuori della dimensione trasgressiva stessa. Allora un giorno potremmo svegliarci e accorgerci che la società senza interdetti non è niente di più che la somma delle solitudini che la compongono.


