Domanda preliminare: di cosa stiamo parlando?
di Francesco Lamendola - 06/05/2017
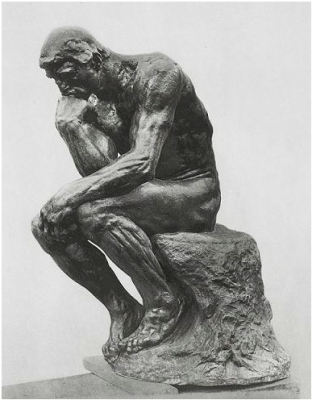
Fonte: Il Corriere delle regioni
Una delle ragioni della gran confusione, della perplessità, e anche del pessimismo e dello scoraggiamento che hanno così larga parte nello stato d'animo dell'uomo moderno, nel suo modo di essere, di amare, di odiare, di sperare, di lavorare, di crescere i figli, di perseguire uno scopo nella vita, è la mancanza di chiarezza rispetto a ciò di cui si sta parlando, su cui si sta ragionando, su cui si sta operando.
Quando si parla di qualcosa, o si ragiona su qualcosa, o ci si occupa di qualcosa, la prima domanda che ci si dovrebbe porre, anzi, la domanda preliminare, anteriore a qualunque altra, e perciò a qualunque risposta, o pensiero, o azione, che entrino nel merito della questione, dovrebbe sempre essere: di che cosa stiamo parlando? Sembrerebbe una cosa ovvia, ma non lo è. Si tratta di individuare la cosa, di metterla a fuoco, di separarla da ciò che essa non è. Molti non lo fanno, e, così, girano a vuoto, inseguendo una meta che è fuori bersaglio. Né si tratta solo di dare una precisa definizione delle cose: perché dare una definizione è necessario, ma risulta utile solo se corrisponde a una reale chiarificazione concettuale; se diamo una definizione teoricamente chiara, ma, in effetti, ci portiamo dietro un modo di pensare confuso, non abbiamo fatto alcun progresso rispetto alla chiarezza di cui abbiamo bisogno per progredire e per giungere a qualche risultato apprezzabile. Ciò vale per tutti gli ambiti del pensiero e della vita pratica: dalla medicina alla religione, dalla scienza alla storia, dalla filosofia all'arte.
Prendiamo la medicina: prendiamo il caso del tumore. Che cos'è un tumore? Prima di imbarcarci in discussioni su come curarlo e su come prevenirlo, abbiamo ben chiaro l'oggetto della nostra riflessione? La definizione comunemente accettata è quella dell'oncologo Rupert Alan Willis: un tumore, o neoplasia ("nuova formazione") è una massa abnorme di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo. Se, poi, alla parola "tumore", si aggiunge l'aggettivo "maligno" (o "benigno"), si carica quella definizione di significati fatali e irreversibili, e il malato incomincia a entrare nella condizione psicologica di chi si prepara a morire o a guarire, perché così gli è stato detto che accadrà. Senza addentrarci negli aspetti squisitamente medici della questione, ma restando ad un livello concettuale generico, osserviamo che la parola latina tumor, che significa, semplicemente, "tumefazione", e quindi "rigonfiamento", e, colme tale, non ha, di per sé, un significato infausto, descrive una delle manifestazioni classiche della "infiammazione", la quale, a sua volta, è una risposta dell'organismo - risposta difensiva e riparativa, e perciò "utile -,a d una causa esterna fisica, chimica o biologica, o anche di tipo psicologico ed emozionale: rubor, arrossamento della pare infiammata; tumor, tumefazione; calor, calore; dolor, dolore; e functio laesa, alterazione funzionale. Perciò, una domanda come questa: i tumori al seno, o i tumori al fegato, o i tumori ai polmoni, sono aumentati o diminuiti negli ultimi vent'anni?, è una domanda mal posta. Non ci sono tumori al seno, al fegato o ai polmoni; ci sono i tumori che prendono questo o quell'organo. Oppure la domanda: i tumori sono aumentati negli ultimi cinquant'anni?, è anch'essa mal posta, perché bisogna innanzitutto vedere cosa s’intende per tumore. Se si intende "cancro maligno", cioè se si dà alla parola un significato specifico che non corrisponde a una vera patologia, ma che trasforma in sentenza di morte la semplice descrizione d'un processo riparativo delle cellule, che risulta abnorme solo se staccato dal suo contesto e della sua dinamica interna, e soprattutto dalle sue cause, è impossibile rispondere, perché, in passato, quella parola non aveva acquistato un tale significato, e quindi una "patologia tumorale", a rigore, non esisteva, perché non era contemplata dalla medicina. Questo, naturalmente, non significa che i tumori non esistono, altrimenti cadremmo nella sindrome di don Ferrante, il quale, convinto che la peste, di per sé, non vi fosse, rifiutò di prendere alcuna precauzione, ne fu colpito e morì. Certo che i tumori esistono e certo che le persone muoiono; però bisogna cercar di capire di che cosa stiamo parlando. Forse stiamo parlando di una cosa diversa da quella di cui credevamo di parlare, o di cui dovremmo parlare: stiamo parlando di un "cancro maligno", invece dovevamo parlare di una "tumefazione". La terapia dovrebbe scaturire, come del resto in ogni altro genere di malattia, da una presa di coscienza del fattore scatenante e concentrarsi su quello, perché, una volta compreso perché alcune cellule sono "impazzite" e hanno incominciato a riprodursi e a proliferare senza controllo, si può incominciare a riflettere su come gestire la situazione; non prima. Ciò sembrerebbe contraddire il buon senso istintivo, che ci suggerisce di non chiedere, mentre la nave sta affondando, come e perché ciò sia accaduto, ma di affrettarci a svuotare i locali allagati con le pompe, prima che sia troppo tardi. In realtà, il vero buon senso ci imporrebbe di vedere, per prima cosa, dove si sia prodotta la falla: perché, se non provvediamo a individuarla e a turarla, per quanta acqua noi possiamo aspirare fuori dalla nave, continuerà ad entrarne molta di più dalla falla che si è prodotta, e tutti i nostri sforzi affannosi saranno inutili, né riusciremo a salvare la nave, e, con la nave, a salvare noi stessi.
Oppure passiamo all'ambito della cronaca. Si parla, per esempio, di "migranti" e di "migrazioni": ma sono davvero migranti, e sono delle vere migrazioni? Perché, se i "migranti" sono, in realtà, le avanguardie di un esercito d'invasione, esercito per ora disarmato e, anzi, formato a persone deboli e inermi, bisognose di tutto; e se le "migrazioni" sono, in realtà, delle invasioni suscitate ad arte e pilotate con la massima freddezza, allora rischiamo di parlare di un qualcosa che non esiste nella realtà, ma solo nel mondo della informazione televisiva e a mezzo stampa, truccata e manipolata opportunamente da chi vuole diffondere una percezione distorta della realtà, e, forse, da quelli stessi che stanno mettendo in movimento milioni di persone, dall'Africa e dall'Asia, per invadere l'Europa, islamizzarla e sostituirne letteralmente la popolazione.
Si parla anche, nell’ambito del politcally correct, di violenza sulle donne e di femminicidio. La brava professoressa femminista entra in classe e dice agli alunni: Oggi, ragazzi, alla luce di quel che è accaduto ieri, e di cui hanno parlato i giornali e le televisioni (la brava professoressa progressista e femminista è sempre molto informata, come si evince dal fatto che legge ogni giorno il quotidiano e ascolta due o tre telegiornali o radiogiornali), dobbiamo parlare di un grave problema, di una vera e propria emergenza sociale: il femminicidio. Ed ecco che si accende una accalorata tavola rotonda intorno al tema scottante del femminicidio, e tutti sono lì, pieni di sgomento e di rabbia (le femmine) e di terribili sensi di colpa (i maschi) a chiedesi perché, a immaginare delle risposte, delle misure per prevenirlo o per reprimerlo. Benissimo. Ma esiste, poi, il femminicidio? Certo che esistono le donne uccise da uomini: dai loro padri, dai loro fidanzati, dai loro mariti; e anche dalle cugine, dalle zie o dalle amiche gelose, ma questo è meglio non evidenziarlo troppo, perché guasterebbe il teorema femminista, basato sulla esclusiva e innata cattiveria del maschio. Esistono anche degli uomini uccisi dalle donne, dalle loro amanti, dalle loro mogli, dalle ragazzine in cerca di squallide avventure, e perfino dalle loro madri, se è per questo. Ma il fatto che esistano delle donne che vengono uccise dagli uomini non è la stessa cosa che dire che esiste il femminicidio. Per parlare di femminicidio, bisogna che questi uomini uccidano le donne perché sono donne, cioè per odio verso il loro sesso, e non per gelosia, o per rabbia, o per esaurimento nervoso, o per qualsiasi altro motivo soggettivo e passionale, e magari d’interesse, come invece avviene, molto più semplicemente.
Un altro parla dell’antisemitismo: un giornalista seduto a una tavola rotonda, uno “storico” di quelli alla Paolo Mieli, che sanno sempre tutto e che sono presenti dappertutto; oppure il solito professore o professoressa progressista e “liberale” (il che vuol dire tutto e il contrario di tutto, ma, nella nostra cultura italiota, vuol dire soprattutto radical-marxista, il che, a sua vota, è un ossimoro e una contraddizione intrinseca, impensabile in qualsiasi altra cultura); e, naturalmente, il solito anticlericale, qualche volta anche vestito, o piuttosto travestito, da “teologo” cattolico, e persino da cardinale o da vescovo cattolico, più che mai smanioso di ribadire l’equivalenza fra l’antisemitismo e il genocidio nazista e, pertanto (logica ineccepibile, come si vede, nella testa di quei signori!) fra quest’ultimo e le ben note “responsabilità” della Chiesa cattolica, che ne è stata, se non proprio la mandante morale, quanto meno l’antesignana e, per certi versi, la fiancheggiatrice; o se, per caso, non fosse stata neppure questo, sarebbe stata comunque colpevole d’imperdonabili omissioni e di criminali “silenzi”, specialmente nella persona del papa Pio XII. Tuttavia, dovremmo innanzitutto domandarci: ma di che cosa stiamo parlando? Primo: stiamo parlando dell’antisemitismo religioso o di quello biologico? Perché sono due cose molto, ma molto diverse. L’una si riferisce agli ebrei come seguaci di una religione, quella mosaica; l’altra agli ebrei come popolo. Secondo: “antisemitismo” non è un termine idoneo a indicare qualsiasi atteggiamento di critica verso gli ebrei, o, dal 14 maggio 1948, verso lo Stato d’Israele. Se così fosse, arriveremmo all’assurdo che criticare, che so, un ragazzo ebreo il quale getta una cartaccia sul marciapiede, sarebbe una manifestazione di antisemitismo; così come, restando su tale linea di “ragionamento” (o piuttosto di farneticazione), criticare un automobilista negro, o asiatico, che non si ferma al semaforo rosso, equivarrebbe a una manifestazione di razzismo e di etnocentrismo. Perciò, andiamoci piano con certe semplificazioni ideologiche e con certe conclusioni affrettate.
Potremmo continuare a lungo, ma crediamo di aver chiarito il concetto. Se non facciamo realmente chiarezza su ciò di cui stiamo parlando, rischiamo di parlare del nulla, o, peggio, di creare dei sofismi e di giungere a delle false conclusioni. Purtroppo, gran pare della cultura moderna poggia su tali sofismi e su tali false convinzioni. Le cause di ciò sono molte, ma, fra esse, ne spiccano due sulle altre: la pretesa, tipicamente democratica, che tutti possano sapere, capire e giudicare qualsiasi cosa, anche senza preparazione, anche senza intelligenza, anche senza spirito critico; e la sistematica, pianificata manipolazione del pensiero da parte delle élite occulte, le quali si servono, per tale opera, delle élite visibili, ossia delle classi dirigenti e della intellighenzia, ovviamente progressista, modernista e “liberale” (nel senso indicato sopra), che fungono da cinghia di trasmissione delle direttive provenienti dall’altro e attuano, concretamente, l’opera di ”persuasione”, ossia d’istupidimento, dell’opinione pubblica, creando, fra l’altro, le parole-specchietto, come “femminicidio” e “antisemitismo”, allo scopo di realizzare più facilmente i loro segreti obiettivi. I quali sono abbastanza semplici: pervenire al controllo totale degli uomini, senza che essi se ne accorgano senza che se ne rendano conto, senza che lo sospettino, e anzi, addirittura, nella ferma convinzione di essere più liberi, più infornati e più consapevoli di quanto non lo fossero le passate generazioni.
Ne deriva che, oggi, per riconquistare la chiarezza del pensiero, è necessario aprirsi il varco, letteralmente, a colpi di machete, nella selva selvaggia dei luoghi comuni, delle parole-specchietto, dei ricatti linguistici che diventano ricatti morali (vedi quanto detto sull’accoglienza dei poveri ”migranti”): insomma, bisogna strappare le maglie della tela vischiosa e micidiale che le élite occulte, per mezzo delle élite visibili e ciarliere, hanno tessuto intorno a noi e persino dentro di noi, come un ragno paziente, instancabile, crudele, che già pregusta il momento in cui potrà divorare, con tutto comodo, la mosca che vi è rimasta intrappolata inavvertitamente. E qui sorge una ulteriore difficoltà, della quale, peraltro, abbiamo già più volte parlato (cfr. in particolare, il nostro articolo: Viviamo in un mondo di dormienti che diventano feroci se qualcuno tenta di svegliarli, pubblicato sul sito di Arianna Editrice il 12/05/2009, e ripubblicato su Il Corriere delle Regioni il 03/04/2017): le mosche non sanno di essere tali; non sanno di aver posto le zampine sulla tela del ragno; non sanno che c’è un ragno pronto a divorarle. Non solo: le mosche si credono aquile possenti, libere, capaci di volare in alto, verso il sole, nella pienezza delle loro forze (vedi il mito della caverna di Platone). Pertanto, se qualcuno tentasse di aiutarle a comprendere la loro vera situazione, il minimo che potrebbe accadergli sarebbe di non essere creduto, e di vedersi respinto come un seccatore, un presuntuoso, un allarmista. Una reazione tipica dell’anima condizionata occultamente: prendersela con i pompieri anziché con gl’incendiari. Perciò, stando così le cose, che fare? Non è che si possa fare molto, al di fuori di se stessi. Però si può fare molto in se stessi, ed è già questa un’opera ciclopica, oltre che necessaria. Chi sa mettersi in discussione; chi cerca sinceramente il vero; chi sa domandarsi: ma chi cosa stiamo parlando?, è sulla strada giusta, quella della liberazione. Il resto lo farà Dio. Quanto agli altri, non aspettiamoci ringraziamenti, semmai le pietre della lapidazione. Non importa: le cose vanno fatte perché è giusto farle, non per il premio che se ne riceverà dagli altri…


