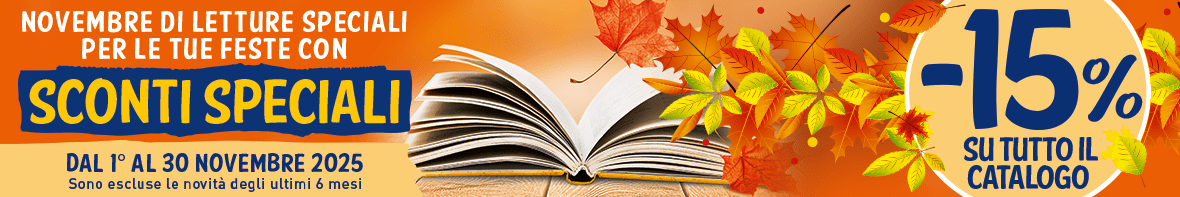Il Giappone secondo il periodico Limes (con insofferenza per il nazionalismo al governo)
di Riccardo Rosati - 25/08/2018

Fonte: Barbadillo
Un imprescindibile chiarimento metodologico e di orientamento
Dire di Roland Barthes è generalmente dire della scrittura, del testo, della significanza, e ancor più del significato. La domanda più che legittima sarebbe quella del perché di questo riferimento al grande linguista e letterato francese in una analisi della monografia che la nota rivista di geopolitica Limes ha dedicato al Giappone lo scorso febbraio. Di primo acchito si potrebbe pensare a un rimando a quello stupendo testo che Barthes ha rivolto proprio a questo Paese e dal titolo: L’impero dei segni (“L’Empire des signes”, 1970), ma così non è. Il motivo che ci ha spinto a iniziare queste nostre riflessioni parlando della scrittura in sé risiede nel fatto che anche un campo di indagine e ricerca come la geopolitica cambia la propria prospettiva, rivelando contemporaneamente la sua identità, in base al lessico che si utilizza e al modo in cui le frasi vengono formate. Ecco, allora, che va ricordato che esistono sostanzialmente due orientamenti nell’affrontare questi complicati temi: il primo, che è poi quello di Limes, è tendenzialmente non ostile al globale e a un progresso di matrice tecnocratica; il secondo, seguito da chi scrive, si inquadra, invece, in una posizione tradizionalista, per la quale, riprendendo un concetto caro al celebre geopolitologo tedesco Karl Haushofer (1869 – 1946), le Nazioni sono sempre e prima di ogni altra cosa: “sangue e suolo”.
Abbiamo sentito la necessità di un tale incipit, giacché se, per il volume che ci apprestiamo ad analizzare, capiterà di trovarci in disaccordo con alcune delle posizioni in esso espresse, nella maggior parte dei casi non sarà per via della qualità intrinseca dei singoli articoli, perlopiù di buon livello, ma quasi esclusivamente a causa di una irrisolvibile distanza sia metodologica, sia intellettuale.
Probabilmente, il contributo di principale interesse nel numero di Limes intitolato: La rivoluzione giapponese, lo si ritrova nell’Editoriale stesso (7-29), nella sua articolata disamina che non si limita sinteticamente ad anticipare, come sovente accade in scritti del genere, le tematiche poi affrontate dai singoli articoli, bensì si concentra nel proporre, persino con una certa dose di convinzione, la prospettiva che Limes ha sulla attuale situazione politica dell’Arcipelago. Su questo, nulla da obiettare, salvo la mancanza della firma di chi ha redatto l’Editoriale; una pecca, a nostro modesto avviso, che denota una vocazione più giornalistica che accademica nello scrivere. Assai meno “neutrale” è, tuttavia, la schematica e parziale comprensione che qui si propone del Premier nipponico Abe Shinzō, la quale compare come una sorta di “ritornello” nei vari contributi, però soltanto in quelli a firma degli italiani. Nondimeno, malgrado la solita insofferenza della sinistra nostrana verso i cosiddetti “uomini forti” e con inclinazioni nazionalistiche, la onestà intellettuale ci impone di riconoscere una parte di verità nel seguente giudizio sulla politica del Premier nipponico: “Giocando a fini propagandistici la carta dell’intesa fra liberaldemocrazie […]” (18-20).
Il Giappone è un mondo a sé, questo gli specialisti lo sanno bene, e un aspetto importante di questo fascicolo è per l’appunto l’avvalersi delle riflessioni di diversi ricercatori e docenti nipponici, così da offrire anche una prospettiva interna sui cambiamenti in atto nel Sol Levante. In più di uno di tali contributi si parla di come l’Impero Giapponese avesse esteso la sua influenza per brevi ma decisivi anni, tentando invano di erigere la Sfera di Coprosperità della Grande Asia Orientale, sino al collasso del 1945, quando gli Stati Uniti, pur di evitare la invasione diretta del Giappone, lo costrinsero alla resa per via di un doppio e, riteniamo, criminale bombardamento atomico. Per la prima volta nella sua leggendaria vicenda, l’Impero del Sole era sottomesso al giogo straniero, asservito ai cosiddetti “occhi blu” (aoime), ossia gli occidentali.
Dalla formidabile ripresa del dopoguerra, il Giappone è stato per il resto del mondo sinonimo di avanguardia tecnologica, locomotiva industriale internazionale, nonché potenza finanziaria e commerciale che negli anni ’80 del Novecento pareva prossima a scavalcare addirittura gli Stati Uniti, di cui questo complesso Paese asiatico è da anni una sorta di “ancella geopolitica”, fungendo come una portaerei naturale, a guardia dell’Oceano Pacifico. Il Secondo Dopoguerra ha fatto del Giappone un raro caso di coesistenza di potenza economica e minorità politica.
Seppur ridotto a vassallo degli statunitensi, il Sol Levante è stato capace di serbare il suo carattere, di restare fedele alla sua superiore missione patriottica adattandosi, per forza e non per scelta, questo va sempre tenuto bene a mente, ai vincoli imposti dallo scomodo alleato. Ciononostante, questa grande Nazione ha vissuto la contemporaneità mutando la sua pelle, ma non certo l’anima. Eppure, come giustamente evidenziato nell’Editoriale, sussiste tuttora, anzi è ancor maggiore che in passato, per il Giappone il “problema americano”, nella sua non agevole necessità: “Ma i realisti di tono moderato – trascuriamo i pur numerosi pacifisti e altri idealisti – inclinano a constatare che il sofferto vincolo americano resta per ora indispensabile di fronte al risorgere della potenza cinese, all’ipoteca nucleare nordcoreana […]” (15).
Due scritti particolarmente interessanti
Come detto, in generale tutti i contribuiti presenti nella rivista sono quantomeno interessanti. Per comprensibili motivi di spazio, ci soffermeremo qui di seguito su quelli che hanno maggiormente destato la nostra attenzione.
Per primo va menzionato l’articolo di Dario Fabbri, intitolato: L’importanza di essere Giappone (33-45), sostanzialmente una “eco” di quanto già detto nell’Editoriale, in cui troviamo comunque alcuni validi spunti sulla formidabile capacità di resistenza e di innovazione dell’Arcipelago e del suo Popolo.
Tōkyō sta rientrando nella dimensione geopolitica, nel segno di un antico adagio giapponese: Keizoku wa chikara nari (継続は力なり, “Continuare è potere”). In effetti, non esiste altro Paese che negli ultimi due secoli sia cambiato tanto radicalmente e velocemente e con effetti così estremi come è stato per il Giappone. Da arcipelago isolato a potenza coloniale in meno di trent’anni; da Nazione, però solo formalmente, storicamente vassalla della Cina a egemone asiatico; da nemico giurato degli americani a loro alleato, attestandosi nel contempo quale avanguardia tecnologica del pianeta. Sconvolgimenti spaventosi che avrebbero disintegrato qualsiasi collettività, smembrato qualunque Popolo, ma non certo quello giapponese, sono queste le corrette osservazioni dell’autore.
Del resto, malgrado la portentosa ascesa degli ultimi quindici anni del colosso cinese, il Giappone resta pur sempre la terza economia del mondo. Parimenti la coatta modernità che lo ha avvinto dal Secondo Dopoguerra in poi ne ha sì intaccato vari elementi portanti: la lingua, i costumi, finanche la alimentazione, ma non certo la sua vera identità etnica. Inoltre, nel Sol Levante rimane inalterata la assoluta fiducia nella gerarchia, la quale ha consentito alla Nazione di sopravvivere a se stessa e di essere sostanzialmente quella cultura complessivamente unica qual è. Un Paese che potremmo azzardare di riassumere con un duplice assioma: la solidità lo ha reso un soggetto etnico inconfondibile; tanta sostanza ne impedisce puntualmente la sua comprensione all’esterno.
Lo scritto di Fabbri, non per lo stile, ma per i contenuti, ci trova sostanzialmente concordi, se non fosse che la prospettiva di cui abbiamo parlato in apertura ci obbliga a ravvisare un errore, e ci auguriamo ci venga perdonato l’essere draconiani, capitale; il quale poi è ripetuto in altri articoli del volume di cui stiamo parlando. Ovvero, il definire il Giappone una “talassocrazia” (33). Tecnicamente tale affermazione risulta corretta, ma solo se si concepisce la geopolitica come una rete di interazioni economico-politiche; secondo una ottica moderna quindi, scevra dalla comprensione della essenza spirituale che connota i luoghi abitati dai popoli, specialmente nel caso del Giappone, poiché, come spiegato ancora da Haushofer nel suo straordinario testo: Il Giappone costruisce il suo impero (Parma, All’insegna Del Veltro, 1999), il Sol Levante si è sì mosso nel periodo del suo espansionismo in Asia attraverso il vettore marino, ma non spinto affatto dalle vili mira mercantilistiche che hanno caratterizzato l’Impero Britannico prima e gli Stati Uniti poi. Il Giappone Imperiale fu “nella forma” una talassocrazia, tuttavia nella effettiva sostanza storica, esso si comportò come una “tellurocrazia”. Tali differenze prospettiche possono apparire leziose, ma non lo sono, anzi qui si misurano, come detto, due assolutamente inconciliabili visioni del mondo.
Sempre Fabbri cura una interessantissima conversazione con Tōmatsu Haruo (47-52), storico della strategia e Preside della Facoltà di Relazioni Internazionali presso l’Accademia Nazionale di Difesa ( 防衛大学校, Bōei Daigakkō) di Yokosuka. Giudichiamo questo contributo il più prezioso tra quelli inclusi in questo numero di Limes. Invero, il prezioso insight di Tōmatsu, segnatamente nella acuta riflessione sul dualismo tra Esercito e Marina nelle gerarchie militari nipponiche (48), sviluppatosi costantemente dalla Restaurazione Meiji (1868) in poi, è un dato storico nodale per la comprensione del primo Periodo Shōwa (1926 – 1945) e che raramente abbiamo avuto la fortuna di incontrare negli studi dei blasonati – più per fama che per tangibile valore – nomi della yamatologia contemporanea. Tale acerrima rivalità tra Esercito e Marina si accentuò notevolmente con il coinvolgimento diretto del Sol Levante nelle questioni cinesi, facendo sì che il primo, cioè l’Esercito, ottenesse un peso politico crescente, fino a instaurarsi come potere di Governo vero e proprio, inaugurando quello che gli specialisti sono soliti chiamare il Militarismo Giapponese, definito altresì come: “Valle Oscura” (黒い谷, “Kuroi Tani”).
Tōmatsu riferisce di un cambiamento in atto in Giappone colmo di inquietudini, che egli descrive come: “Una delicata fase di sospensione, nell’attesa di diventare altro. Da una parte vi sono i burocrati, incaricati della politica estera dalla fine della seconda guerra mondiale, che hanno perso ogni sensibilità strategica perché abituati ad affidarsi agli Stati Uniti. […] Infine vi sono ammiragli e generali, nostalgici dell’impero, che vorrebbero inaugurare una nuova stagione espansionistica, senza contemplare le gravi conseguenze che questo comporterebbe. Ne deriva un paese che oscilla tra un indolente nichilismo e una repressa aggressività […]” (47). Nel rispondere con precisione a ogni domanda che gli pone Fabbri, lo studioso giapponese offre notevoli spunti di riflessione non solo sull’attuale posizionamento politico e strategico del suo Paese, ma specialmente fa questo, ricollegandosi alla storia recente dell’Arcipelago. Per tale motivo, consideriamo questa intervista una voce bibliografica che dovrebbe essere costantemente presente nei futuri studi geopolitici sul Giappone.
Gli altri scritti di maggiore utilità
Ci sono comunque altri scritti di sicuro interesse inclusi in questo volume. Ad esempio, quello di Nishio Takashi: Lunga vita al todōfuken (53-59), in cui si affronta il tema di come oggi nel Paese le prefetture non siano più semplici unità amministrative, bensì delle “entità ecologiche”, linguistiche e culturali, capaci persino di plasmare l’identità individuale dei cittadini.
Nishio spiega come nell’attuale sistema di governance (parola giustamente assai poco amata dalla corrente tradizionale della geopolitica) giapponese, il sistema delle autonomie locali (todōfuken) sia il più antico e consolidato. Ci sono ben 47 todōfuken nell’Arcipelago, di cui le denominazioni e i confini sono rimasti pressoché invariati sin dalla Restaurazione Meiji. Tuttavia, se all’apparenza queste unità della autonomia locale sono rimaste immutate, le loro caratteristiche politiche e sociali sono, al contrario, fortemente cambiate dopo la costituzione dello Stato centralizzato del Periodo Meiji.
Di stringente attualità è il tema che si affronta nel pezzo: La crisi demografica e una nuova restaurazione Meiji (73-78) di Stephen R. Nagy, in cui si parla della questione del rapidissimo invecchiamento della Popolazione in Giappone, situazione che sta creando enormi problemi sociali e, specialmente, economici. Risolvere tale problema, anche se una vera soluzione non pare essere stata trovata dai governanti del Paese, è di vitale importanza. Ad esempio, si sta tentando di “sostituire” le persone con i robot – l’automa è da sempre un elemento che suscita grande fascino in questa cultura – per quanto riguarda alcuni lavori di assistenza sociale, benché questo sembri un rimedio più vicino alla fantascienza che alla vita reale.
La emergenza demografica ha spinto il Parlamento ad adottare politiche economiche, di sicurezza, migratorie e culturali che promettono di cambiare volto al Paese, seppur nell’animo dei nipponici a ogni grande cambiamento ci si augura puntualmente di restare uguali a se stessi.
Un tema che ben pochi conoscono, e che quasi nessun yamatologo italiano colpevolmente ama trattare, è quello che troviamo nell’articolo di Ian Neary: Burakumin, gli ultimi resteranno ultimi (83-87), ove si racconta della discriminazione verso i membri della casta degli esclusi (specialmente i discendenti dei conciatori di pelli), una forma di “razzismo interno” che rivela la ossessione tutta giapponese per la purezza del sangue. Infatti, esistono in Giappone persino delle apposite agenzie investigative che ricercano nel passato delle persone, così da prevenire matrimoni “misti”. Va comunque detto, che nel dicembre 2016, la Dieta (il Parlamento Giapponese) ha approvato una legge per promuovere l’eliminazione della discriminazione dei burakumin (termine traducibile come: “gente di villaggio” o “di borgata”). Si tratta della prima volta in assoluto in cui un atto legislativo si riferisce alla ghettizzazione delle comunità buraku.
Pochi Paesi hanno legato la loro vicenda nazionale a quella della propria Marina tanto quanto il Giappone nel corso degli ultimi duecento anni, come ci racconta Alberto de Sanctis nell’articolo: La rinascita della flotta nipponica nel nome delle antiche glorie (97-105). Nel volgere dei pochi decenni vissuti a cavallo dei secoli XIX e XX, la flotta da battaglia nipponica (海軍, kaigun) ha sperimentato una crescita rapida ed esponenziale che le ha permesso di giocare un ruolo cruciale nella parabola storica dell’Asia. Per decenni simbolo indiscusso del potere imperiale, la Marina del Giappone ha contribuito a rendere il Paese una delle maggiori potenze militari della prima metà del ‘900.
Era ovviamente inevitabile l’affrontare la questione della prossima abdicazione del sovrano Akihito prevista per il 2019. Lo fa Hosaka Yuji ne: Il volto umano dell’imperatore (121-125). Un evento che ricorda, sebbene alla lontana, l’abdicazione di Papa Benedetto XVI avvenuta il 28 febbraio 2013, e che rende nota al mondo intero la imbarazzante, per i giapponesi, fragilità di un regnante che, malgrado le vicende costituzionali del Secondo Dopoguerra, molti nell’Arcipelago non hanno mai cessato di considerare come divino. Inoltre, visto che l’attuale sistema dell’imperatore-simbolo non contempla una fattispecie di questo tipo, la popolazione giapponese ha reagito con grande sgomento alla decisione dell’Imperatore (Tennō) di essenzialmente abbandonare il proprio ruolo per problemi personali, quasi che la natura umana e quella divina del Tennō potessero essere scisse.
Infine, di grande utilità, se pensiamo alla evoluzione dello scenario politico estremo-asiatico, è l’aver trattato dell’occupazione giapponese (dal 1910 al 1945) della Penisola Coreana; episodio coloniale che ha visto i nipponici macchiarsi talora di autentici crimini, tra tutti il fenomeno delle cosiddette comfort women: giovani coreane costrette con la forza a soddisfare le necessità sessuali dell’Esercito Imperiale. Una ferita, come racconta Antonio Fiori nel suo articolo: Lo Stretto di Corea è sempre più largo (227-234), che continua a pesare sui rapporti tra Tōkyō e la Corea del Sud, mentre, sul fronte opposto, crea ancora tensioni il mai chiarito rapimento di cittadini nipponici da parte di agenti di Pyongyang. A tal proposito, anche in Occidente è balzato agli onori della cronaca il caso di Yokota Megumi, rapita da agenti infiltrati dalla Corea del Nord, nel novembre del 1977 e mai più tornata in Patria. Su questo argomento è recentemente stato pubblicato il testo del giornalista Antonio Moscatello: MEGUMI. Storie di rapimenti e spie della Corea del Nord (Napoli, Rogiosi, 2017).
Il Giappone non fa la rivoluzione, ma rinasce!
Tirando le somme, possiamo vedere che sono numerose le mappe e le cartine presenti in questo interessante numero di Limes, come per ribadire quel primato della Geografia sulla Filosofia Politica tanto caro proprio a Haushofer. Non per nulla, a lui si deve la creazione della scuola geopolitica nipponica, la quale indirizzò fortemente le scelte del Governo durante il periodo del Militarismo. Alcuni dei princìpi fondanti della Nippon Chiseigaku (chi/terra [地], sei/politica [政], gaku/studio [学]) erano rivolti a denunciare quella “brutalità dei bianchi”, di cui per primo parlò Julius Evola nel suo, come sempre, profetico articolo: Ora tocca all’Asia. Il tramonto dell’Oriente (pubblicato inizialmente ne Il Nazionale, II, 41, 8 ottobre 1950 e ora incluso in Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull’Oriente 1927 – 1975, Riccardo Rosati [a cura di], Roma, Pagine, 2016). Per i nipponici, la loro inarrestabile espansione in Asia fu una: “guerra di liberazione dal dominio coloniale bianco” (23). E, come giustamente riportato nel qui citato Editoriale, fu di enorme importanza il contributo apportato dal pensiero di Haushofer, al fine di strutturare una idea alta dell’Imperialismo Giapponese: “Il pancontinentalismo di scuola haushoferiana contribuì a strutturare il progetto di Grande Asia Orientale […]” (26).
Quel “Giappone profondo” di cui talora si parla, non lo si conosce poi quanto si crede. Esso è stato, ed è tuttora, un nucleo, perlopiù familiare, alla cui sommità svetta la figura del Sovrano. L’americanismo del Secondo Dopoguerra ha indebolito questa eccezionale struttura sociale, esclusivamente nipponica. Tale fenomeno deteriore di colonizzazione culturale è stato parzialmente arrestato dalla tragedia naturale che ha colpito la regione del Tōhoku l’11 marzo del 2011. Quello sfortunato evento permise tuttavia la rinascita del kizuna (絆, “legame”), ricompattando una intera Nazione, a quel tempo intontita da una alienazione dell’individuo che raggiunse l’apice col fenomeno degli Hikikomori (引き篭り, letteralmente: “quelli che si tirano in disparte”), giovani che si chiudono in casa anche per anni, vivendo una realtà fatta solo di Internet e televisione, rifiutando ogni contatto diretto con altre persone (su questo argomento, segnaliamo la intelligente serie animata: Welcome to the N.H.K. [24 episodi, 2006], diretta da Yamamoto Yūsuke). Oggi è doveroso, per uno yamatologo non asservito al globalismo, parlare di ben altro Giappone, forse anche migliore e più forte di quello che abbiamo amato da bambini, giacché è ridiventato un Paese/Popolo; un qualcosa di cui noi italiani non riusciamo mai a comprendere l’importanza.
L’Editoriale di Limes si chiude con una sorta di provocazione: “Tra le sopravvivenze delle antiche glorie non pare brilli il bushidō. Per la tristezza, immaginiamo, degli spiriti samurai” (29); quasi a volersi fare incomprensibilmente gioco della eredità politica e morale del grande Mishima Yukio, incoraggiando in tal modo quel “perdendo il Giappone”, al quale diversi anni fa dedicammo un agile volume specialistico (cfr. Riccardo Rosati, Perdendo il Giappone, Roma, Armando Editore, 2005). Non possiamo certo rallegrarci di questa posizione, poiché rivela per l’appunto quella già stigmatizzata inconsapevolezza del “Giappone profondo”.
È necessario accorgersi che quello che alcuni leader conservatori dell’Arcipelago, come Ozawa Ichirō, volevano e vogliono ancora oggi è un ritorno a un: “Giappone normale” (22). Invero, un messaggio, neanche troppo velato, che si evince correre sottotraccia in questa pubblicazione, è che il “revisionismo storico” in Giappone abbia radici vigorose e che quell’Occidente atlantista, il quale è un punto di riferimento di una testata come Limes, non lo guardi certo di buon occhio. Nuovamente, malgrado distanti da tali posizioni, non possiamo certo negare la correttezza del dato; è sufficiente, a tal fine, ricordare una figura come quella del politico e scrittore Ishihara Shintarō, che fu anche amico di Mishima, che sostiene da sempre che il Massacro o Stupro di Nanchino, perpetrato durante le sei settimane che seguirono l’occupazione della città da parte delle truppe giapponesi nel dicembre 1937, non sia stato altro che il frutto della propaganda del governo di Pechino. Sempre l’Editoriale conferma come nel Sol Levante stia rinascendo qualcosa che riporterà, forse, indietro le lancette della Storia: “Di qui l’unicità della nazione nipponica nel cambiare restando se stessa. Capace di vedere senza essere vista. Offrendo al «barbaro» la faccia conveniente (tatemae), per sé custodendo l’intimo, autentico pensiero (hon’ne). A guardia dell’armonia (wa), bene supremo” (8). Ciò detto, per ribadire come il lessico sia anche un elemento geopolitico, riteniamo che il titolo stesso di questo volume sia concettualmente errato, visto che associare a questo Paese la parola “rivoluzione” è mistificante, giacché esso l’ha sempre aborrita, vedasi la Restaurazione (o Rinnovamento) Meiji del 1868. Del resto, uno dei massimi esperti di Giappone del secolo scorso, l’italiano Fosco Maraini, non la pensava diversamente da noi: “Il caso giapponese è di straordinario interesse in quanto offre un classico esempio di ostinata impermeabilità alle interpretazioni marxiste, di luminosa trasparenza a quelle weberiane” (Fosco Maraini, Ore giapponesi, Milano, Corbaccio, 2000, p. 13).
* Un ringraziamento alla collega orientalista Annarita Mavelli per i suggerimenti e la revisione del testo