L’emergere degli Stati Civiltà
di Salvo Ardizzone - 04/03/2024
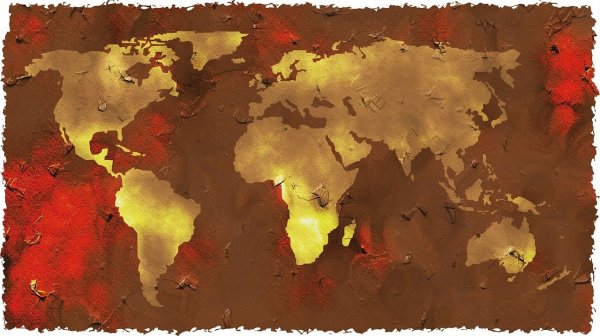
Fonte: Italicum
L’unipolarismo americano ha determinato l’instaurazione del Globalismo, Imperialismo e Universalismo. Ma i costi del mantenimento dello status quo di superpotenza crescono sempre più rapidamente della capacità (e convenienza economica e politica) di mantenerlo. E’ prossimo l’avvento del multipolarismo, che ha per protagonisti gli Stati-Civiltà, che dispongono di cultura capace di unire popolazioni anche diverse, di articolare strategia espansiva su vasti territori che tendono a “ordinare” secondo regole proprie, con peculiari gestioni delle risorse e delle economie. E’ il ripudio degli standard occidentali, insieme all’assioma che per modernizzarsi occorra occidentalizzarsi.
Premessa
Il decomporsi dell’unipolarismo sta determinando una transizione egemonica, un epocale passaggio di poteri che ci sta portando in “terra incognita”, sbrigativamente etichettata dai più col termine “multipolarismo”, piaccia o no ormai da almeno 80 anni assente dal mondo. Provare a comprendere motivi e meccanismi del fenomeno fuor da mera affermazione politica – o del tutto assertiva in assenza di contenuto – aiuta a intuire contorni e caratteristiche di ciò che sta emergendo.
In precedente articolo, abbiamo trattato lungamente di come l’unipolarismo americano abbia determinato l’instaurazione del Globalismo, Imperialismo e Universalismo attraverso l’impiego delle tre tipologie di guerre ibride, rispettivamente: Global Marketing, Guerra Economica e Guerra Cognitiva. Con la prima di esse, ha assunto il controllo dei mercati globali esportando una visione – se così può dirsi – del mondo e certamente uno stile sociale; con la seconda, ha conseguito l’obiettivo di realizzare il proprio interesse economico a scapito delle economie altrui; con la terza, ha imposto un modello sociale e culturale insindacabile, unico ammesso e ritenuto accettabile, mediante la manipolazione delle menti.
Ciò avrebbe creato un sistema egemonico destinato a durare molto a lungo, se gli Stati Uniti non avessero infranto le dinamiche del potere esercitandolo in modo del tutto peculiare. Dacché gli imperi stanno nella Storia, essi alternano fisiologicamente fasi di espansione che metabolizzano in successive fasi di consolidamento. È evidente che un impero di nuova formazione, come lo erano gli USA nel 1945, avesse un approccio dinamico quanto espansivo che, tuttavia, per diversi anni ebbe un argine – diremmo un necessitato senso del limite – nel duopolio con l’URSS, con cui si spartirono più o meno consensualmente (in ogni caso specularmente) il mondo.
Il punto è che l’implosione dell’URSS ha fatto svanire quel senso del limite, tramutando il dinamismo americano in frenesia espansionistica, in senso d’assoluta onnipotenza. Trascurando, e rifiutando, ogni fase di consolidamento e così andando incontro a overstretching certo. Esattamente quello che oggi gli USA stanno subendo a causa di “endless war” (le guerre senza fine) in campo militare, economico e culturale con un mondo ormai troppo vasto (oltre 8 miliardi di esseri umani) e segmentato (quasi 200 stati senza contare molti e rilevanti soggetti politici non statuali) per essere retto unidirezionalmente da unico centro di preteso potere.
Una deriva fortemente accelerata dal disfunzionale quanto compulsivo uso dell’hard-power cui essi ricorrono. Dottrina vuole (e indagine storica conferma) che l’utilizzo di tale declinazione del potere segni il cambio di fase geostrategica del sistema che lo impiega, dall’espansionismo al consolidamento o viceversa. Un periodo temporale limitato in cui l’hard power viene esercitato per il raggiungimento di uno scopo cui segue nuovo equilibrio di sistema, e ciò perché esso obbedisce al principio d’efficienza, ovvero mira a un determinato risultato a prescindere dall’onere che comporta. Insomma, costa assai più dei guadagni e non è dunque sostenibile nel lungo periodo perché esaurisce. Gli USA, invece, lo stanno adoperando da tempo per puntellare la pretesa espansionistica di un impero che s’avvita in crisi manifesta, rifiutando postura di consolidamento. Ovvero, perseverando e incrementando un overstretching già rivelatosi insostenibile. Ciò segnala fallimento – peggio, mancanza – di geostrategia, perché infrange la sua prima legge: essa predica che gli obiettivi vanno comunque parametrati alle risorse, ostinarsi a indirizzarle a 360 gradi su tutto il globo, quale esso è divenuto oggi, non persegue uno scopo ma insegue una chimera.
Tutti gli imperi hanno avuto e hanno criticità, per esempio in quello spagnolo era eclatante l’incapacità di mettere a frutto le enormi risorse cui poteva attingere che, semplicemente, dilapidava (anche in questo caso per ragioni strutturali), dinamica che, alla lunga, ne ha causato il declino. La differenza sta nella rapidità del decadimento e nella capacità o meno di opporre resistenza e resilienza nel contrastare forze contrarie, e adattarsi al cambiamento in prolungati periodi di difficoltà. Esempio è l’Impero Romano, che seppe mutare molte volte pelle – e non solo – per sopravvivere attraverso i secoli. Quello americano dimostra di non saperlo fare e di degradare con stupefacente rapidità. E ciò è legato a sua essenza, alla natura dell’impero che ha costruito e al suo modo di indirizzarlo: in altre parole, alla maniera che gli USA hanno di intendere cultus, oikos e stratos, ovvero Geoeconomia, Geocultura, e Geostrategia. Che nella pratica significa matrice liberale, declinata sia in versione conservatrice che liberal (Geocultura), prassi neoliberista (Geoeconomia) e connaturato espansionismo di una nazione che si sente “eccezionale”, investita dal “destino manifesto” di dominare il mondo (Geostrategia).
A osservazione geopolitica – che si sforza di mantenersi fredda nell’indagare i fatti e studiarne le dinamiche – queste bizzarre caratteristiche dell’impero USA non segnalano fenomeno contingente, ma configurano strutturale disfunzionalità del suo sistema, che tende a disconoscere limiti, a negare dignità o la possibile esistenza dell’altro da sé (che esiste, eccome!), a inseguire l’utile quanto più immediato. Con ciò negandosi concettualmente visione prospettica oltre l’oggi. Vietandosi pensiero strategico che guarda alle conseguenze. Al domani e anche al dopodomani, categorie del tempo da esso escluse.
I risultati sono del tutto evidenti: raggiunto l’apice del Globalismo (intersezione massima di assimilazione e liberismo), in dottrina chiamata “Chiave di Wallerstein”, il Global Marketing più estremo diviene prevedibile da competitor e avversari – si svela nella sua dinamica – dunque meno incisivo, suscitando nel mondo reazioni opposte sempre più efficienti e per l’Egemone logoranti. Con ciò ridisegnando la polarizzazione del dominio economico e culturale che migra verso altri luoghi, verso altri poli d’irradiazione. È dinamica già in atto da anni, accelerata dalle pratiche di “reshoring” e “friendshoring” poste in atto dagli USA che, nel tentativo di difendersi e colpire paesi considerati “revisionisti” perché contestano la loro pretesa “supremazia a prescindere”, stanno provando a ridisegnare le “supply chain”, ovvero le catene di approvvigionamento di prodotti e servizi. Con ciò spezzando quelle esistenti con risultati eufemisticamente deludenti, che si ritorcono su loro e chi li segue. Nei fatti, sull’impero americano nel suo insieme.
Allo stesso modo, raggiunto il punto più avanzato dell’Imperialismo (punto estremo d’intersezione fra liberismo ed espansionismo), chiamato “Chiave di Gilpin”, i costi del mantenimento dello status quo crescono sempre più rapidamente della capacità (e convenienza economica) di mantenerlo. Con ciò determinando la forzata contrazione – anche geografica – dell’impero, obbligato a lasciare ad altri parti crescenti della sua precedente sfera d’influenza. A quel punto, le stesse misure che l’impero adotta per imporre la propria economia e rintuzzare l’ascesa di altre potenze – o punirle per la loro “ribellione” – finiscono per ritorcersi contro di lui. Esemplare è l’uso compulsivo delle sanzioni che, oltre a dimostrarsi sempre meno efficace a causa dell’elevato – e crescente – numero di soggetti sanzionati, ha reso sempre più conveniente la de-dollarizzazione, così imprimendole forte accelerazione. Con ciò indebolendo il principale pilastro su cui si regge il potere americano.
Infine, l’apice dell’azione congiunta di espansionismo e assimilazione configura l’Universalismo, massima espressione d’invasività perché si rivolge alle menti, con l’obiettivo di plasmarle a propria convenienza. La “Chiave di Huntington” è il suo punto estremo, esito della Guerra Cognitiva che in questo ambito viene combattuta, raggiunto il quale la propaganda diffusa dall’impero – la vulgata mainstream – perde rapidamente credibilità, scade a caricatura subendo un tracollo. I popoli perdono interesse per la narrazione prima dominante, volgendosi ad altre vulgate. Basta volgersi attorno per rendersene conto.
Chi ce l’ha e le serba ancora tornerà alle proprie radici, o a ciò che crede tali (c’è grande differenza su cui torneremo), in ogni caso togliendo acritico sostegno all’impero; dinamica che crea fratture esterne a esso, sottraendo crescenti parti dei domini al suo controllo e alla sua influenza mettendone in dubbio l’egemonia, e interne – ancor più insidiose – perché spezza basi e perno del potere. Fa venir meno la giustificazione del prezzo che il popolo è chiamato a sostenere per il mantenimento dell’impero. Basta guardare alla situazione interna USA per averne dettagliato esempio.
È dalle conseguenze dello sfiorire di Globalizzazione, Imperialismo e Universalismo che prende il via l’emergere degli Stati-Civiltà. Fenomeno che rimarca ancor più nitidamente per contrapposizione alle caratteristiche dell’impero americano.
L’avvento degli Stati-Civiltà
Gli Stati-Civiltà sono potenze la cui influenza si estende assai più in là delle proprie frontiere– talvolta del proprio ceppo etno-linguistico – modellando il proprio estero vicino, alle volte territori di riferimento anche più distanti. È il ritorno del concetto d’area d’influenza, anatema per orecchio liberale che vede l’intero pianeta propria indistinta zona d’appannaggio. Ne è conseguenza il fatto che la parte di mondo dove liberal-democrazia governa tende a riconoscersi nell’Unipolarismo USA e nel rules based order da essi imposto, mentre gli Stati-Civiltà intendono l’ordine mondiale – il “Nomos della Terra”, citando Carl Schmitt – come Multipolare, meglio, Policentrico.
Più specificamente, gli Stati-Civiltà hanno idea di sé, del proprio “stare nel mondo”; dispongono di cultura capace di unire popolazioni anche diverse, di articolare strategia espansiva su vasti territori che tendono a “ordinare” secondo regole proprie, con peculiari gestioni delle risorse e delle economie. Insomma, hanno una “visione” che declinano secondo Geocultura, Geostrategia e Geoeconomia proprie. Con ciò possedendo tutti gli ingredienti di una sovranità compiuta, basati su sostanziali valori non negoziabili desunti dalle rispettive tradizioni per come da esse (e in esse) articolati nel corso della Storia.
Per queste innate peculiarità ciascuno degli Stati-Civiltà ha identità distinta, non sovrapponibile ad altre. E in nome di tale identità, che – da sottolineare ancora – non può essere negoziata, si pongono in naturale contrapposizione con il preteso Universalismo occidentale, che mira a instaurare (oggi, in realtà, tenta con crescente insuccesso di mantenere) gli stessi principi su tutto il pianeta. Allo stesso modo tendono a respingere il Globalismo, rifiutando nei contenuti culturali e mantenendo i meccanismi economici e commerciali che ritengono convenienti, meno che mai ad accettare l’Imperialismo che rigettano del tutto, accettando rapporti in base a propria utilità e coerenza con gli interessi nazionali. È ripudio degli standard occidentali, insieme all’assioma che per modernizzarsi occorra occidentalizzarsi. Come pure, che l’adozione di una economia di mercato implichi necessariamente l’adesione ai meccanismi liberisti.
A guardar bene questo snodo della Storia, rileva che la competizione avvenga fra culture e loro emanazione. Nel mondo liberal-democratico, ovvero durante regno Unipolare, era l’economicismo a caratterizzare i rapporti fra i satelliti dell’impero e una era la cultura, al singolare perché uniforme e unica per tutti. Preteso metro universale cui tutti erano tenuti a omologarsi, puro strumento dell’Egemone che tutto regolava. A caratterizzare le relazioni fra gli Stati-Civiltà sono invece le culture, plurali, che ne informano differenziata visione del mondo, proiezione di sé e dei modelli di gestione della società.
Visti in questa prospettiva, gli Stati-Civiltà possono essere paragonati ai passati imperi che hanno retto e modellato il mondo, ma ancor di più – per l’enfasi esiziale sulla Geocultura che li informa – vanno accostati ai Grandi Spazi, ai Grossraum teorizzati da Carl Schmitt: vaste aree su cui insistono popoli che hanno comunanza di esperienze storiche e relazioni con i territori, sviluppando così culture contigue, assonanti. Su queste basi primarie, formate da tradizioni comuni, assimilabili, possono confluire in vario modo altri – molteplici – fattori d’integrazione: etnia, posizione geografica, religione, etc. L’insieme di tutto ciò ne definisce lo “stare nel mondo” che caratterizza la compresenza in un Grande Spazio. Come avrebbe detto Heidegger il suo “dasein”.
Per definirsi Grossraum occorre comunque stazza, primariamente culturale, poi demografica, possibilmente economica – in fondo è la meno caratterizzante; necessita comunque area omogenea, che accetti e riconosca propria una derivante sintesi politica espressa da soggetto guida che la proietti su un vasto territorio, dal quale è esclusa per principio azione di potenza terza.
Ma perché gli Stati-Civiltà stanno emergendo adesso, riproponendosi attori primari della Storia quando, solo pochi decenni fa, taluni sostenevano che essa fosse finita? La spiegazione sta nelle culture – più precisamente le Geoculture – che sono riemerse quando la Geocultura dominante ha mostrato crescenti limiti e inadeguatezza. Fatto è che la cultura di un popolo riveste ruolo insostituibile per la tenuta sociale e politica della sua nazione. Una cultura forte e radicata è capace di interpretare la realtà che muta traducendo stimoli ed eventi in fattori di forza, d’integrazione d’elementi altri, “metabolizzandoli” all’interno del proprio universo valoriale e fornendo risposte alla contemporaneità che muta coerenti a esso. In questo senso, ancora una volta è tipico l’esempio dell’Impero Romano, capace per lunghi secoli di utilizzare e fare propri gli ingredienti più diversi ritenuti utili per “vivere nei tempi”, senza nulla perdere della propria essenza.
Nelle temperie odierne dell’Occidente, giova ricordare che la civiltà è frutto di risorse spirituali (appunto, attinenti alla sfera culturale nella vasta accezione) e materiali (afferenti potenza economica e militare); la sua capacità di affermarsi è combinata conseguenza di esse. Trasposto in più freddo ambito geopolitico, la Geocultura afferisce alla cosiddetta “Sfera Spirituale” che dà orientamento e legittimazione al cosiddetto “Arco Materiale”, con ciò intendendo la combinazione di Geostrategia e Geoeconomia. Senza Geocultura capace di tenere unita una nazione e di proiettarsi fuori di essa, trovando positiva accoglienza negli ambiti cui è rivolta, Geostrategia e Geoeconomia risultano vane, quantomeno azzoppate. Ridotte a pura forza bruta, dunque condannate a collasso per esaurimento.
Aprendo parentesi necessaria, rileviamo come il rapporto col sacro sia parte essenziale della tenuta di qualsiasi società; l’abbandono di esso, anche solo il suo decadimento, incide fortemente nell’espressione della cultura di un popolo, quindi sulla possibilità che esso ha d’articolare una Geocultura che – senza l’elemento del sacro – è semplicemente svuotata. E ciò perché è esso a dare senso e coesione alla comunità; declinato a livello più alto, alla nazione e allo stato che l’amministra; studio della Storia ci dice che non è sui singoli individui che un paese può reggersi ma – appunto – sul senso di comunità. Qui non parliamo di una singola religione, ma del modo in cui i popoli declinano e vivono il sacro, ovviamente ciascuno a suo modo, coerentemente a proprie sensibilità e culture sedimentate nei secoli.
L’Occidente ha eliminato il sacro, relegandolo al più a superficiale pratica religiosa, tollerata quando non criticata, con ciò uccidendolo e decretando al contempo la morte del senso di comunità. Forse il più rilevante dei mutamenti nella Storia della sua civiltà. Per qualche tempo le società occidentali hanno ovviato col succedaneo delle ideologie ma, eliminate anch’esse, non è rimasto alcunché a dare il tono di fondo su cui articolare una cultura unificante e, da essa, definire una Geocultura. Con ciò sancendo una propria strutturale debolezza, diremmo un’estrema vulnerabilità dinanzi a realtà terze. Non a caso è opposta la situazione negli Stati-Civiltà: in ognuno di essi è forte il senso del sacro, quanto meno la sua concreta influenza sulla nazione. Basta osservare le realtà russa o turca dove la sfera religiosa è potente strumento di coesione o proiezione, nel caso dell’Iran è addirittura elemento fondativo. Anche l’India, malgrado fratture interne, punta sull’induismo per darsi anima unica e con ciò forza; in Cina è sul substrato culturale confuciano, sulla naturale preminenza della comunità sull’individuo singolo, avulso da essa, che si basano le politiche dimostratesi vincenti.
Ma tornando alla nostra narrazione, da quanto detto sin qui consegue che l’attuale transizione egemonica non vedrà l’affermazione di nuovo egemone globale; ciò sarebbe contraddizione dell’essenza degli Stati-Civiltà che si basano invece sulle “differenze” sulle loro peculiarità. Del resto, tornando all’esempio dell’Impero Romano – che alle latitudini occidentali permane esempio primo di impero – è vero che esso si dichiarava universale, ma su quella parte di mondo che ordinava e plasmava coerentemente al proprio orizzonte valoriale. Come abbiamo detto in precedente occasione, l’idea di impero è unica ma, al pari della Tradizione, trova modi e forme diversi a seconda dei contesti in cui s’invera, ovvero, a seconda della cultura che li caratterizza.
Per tali ragioni, l’ordine mondiale che sta emergendo è piuttosto basato su un Policentrismo, costituito – appunto – dai vari Stati-Civiltà, cui è sotteso un multiforme reticolo differenziato di relazioni orizzontali e verticali: in primis fra essi e poi fra essi e le entità politiche a loro vicine o esterne alla loro sfera d’influenza; secondariamente, fra i soggetti che permangono al di fuori degli Stati-Civiltà. Un ordine regolato dal ritorno al Diritto Internazionale, da troppo tempo sostituito/piegato dal rules based order a Stelle e Strisce, e da standard propri, non altrui. Uno stato del mondo che, a occhio aduso a egemonismo globale (e incurante della conseguente condizione d’assoggettamento), apparirà come somma confusione foriera di paure ma che, piaccia o no, per attori politici compiuti dotati di sovranità rappresenta normalità che archivia il preteso Unipolarismo, esso sì anomalia dinanzi alla Storia del mondo.
Né a riflessione attenta appare convincente l’argomento che tale sistema porterà più guerre, e per diverse ragioni. L’attuale moltiplicarsi di conflitti è generato dalla ribellione del mondo – o, quantomeno, della sua assai più vasta parte – a un Egemone che non si rassegna a ridimensionare la sua pretesa di dominio, perché si vede Numero Primo o nulla. È il rifiuto di crescente parte dell’umanità di subire regole americane e omologarsi a standard estranei a sé e ad altri convenientia gemmare conflitti; sostenere che per eliminarli si debba accettare sudditanza è idea bizzarra che contraddice la Storia, a cominciare dal non lontano processo di decolonizzazione, e nega la stessa sovranità delle nazioni e il principio di auto-determinazione dei popoli. E non è tutto.
È stata la liberal-democrazia americana, allora rappresentata da Woodrow Wilson, a reintrodurre il concetto di bellum justum, accadde a Versailles nel 1919. Citando ancora una volta Carl Schmitt, facciamo notare come da allora la nascente potenza americana archiviò strumentalmente il concetto di jus in bello, ovvero di conflitto regolato dal Diritto Internazionale, sostituendolo – appunto – con quello di bellum justum, guerra giusta, che non prevede quindi uno justus hostis, un nemico giusto, legittimo, e che inscindibilmente reca con sé la justa causa, la giustificazione per qualsiasi cosa si faccia per tale supposto buon fine.
I passaggi sono evidenti: dichiarata o subita poco importa, una guerra giusta è condotta comunque in nome del “bene”, contro un nemico che, a questo punto, è configurato come il “male”; distruggerlo, annientarlo in ogni modo è lecito, anzi, è condotta “moralmente” obbligata. Con ogni evidenza, è concetto mirante a disumanizzare l’avversario demonizzandolo, e con ciò rendendo dovuto e meritorio il suo annientamento qualunque sia il mezzo usato. C’è questo alla base del sistematico doppio standard che il mainstream mediatico delle liberal-democrazie ha adottato per i freedom figthers, i suoi “combattenti per la libertà”, nelle infinite guerre che si sono succedute. Secondo esso, ci sono bombe cattive, quelle del nemico, e bombe buone, necessarie, comunque giustificate, da quelle su Nagasaki e Hiroshima a quelle che cadono su Gaza, passando per gli infiniti morti nelle città europee rase al suolo fra il 1943 e il 1945, in Corea, Vietnam, Serbia, Afghanistan, Iraq, Palestina, Siria, Yemen, Ucraina e via discorrendo.
A guardar le cronache del mondo, risulta che è essenzialmente l’Egemone ad aver mosso guerre per affermare i suoi interessi, ammantati da superiore legittimazione morale. Massima proiezione di Guerra Cognitiva che, tuttavia, nelle temperie attuali funziona sempre peggio. Costretta oggi a sovradosaggio fino al caricaturale, a pura smaccata propaganda, finendo per essere, prima che inutile, controproducente. Che suscita rigetto virante in crescente avversione nei paesi dove cultura propria è capace di decodificarla – Sud Globale in generale, negli Stati-Civiltà in particolare; manifesta disaffezione all’interno di un Occidente che non dispone ormai di Geocultura propria.
Dinanzi a narrazione mainstream i singoli stati occidentali sono divisi fra scetticismo e disinteresse della popolazione. Al più consenso passivo, residualmente attivo, per carenza manifesta di una narrazione ormai manifestamente logora, del tutto distaccata dalla realtà. Molto ha contribuito in questo la lunare gestione della pandemia, che in vaste fasce sociali ha generato prima dubbi, poi sospetto, infine avversione. È un dissenso che tuttavia rimane in stato magmatico per incapacità di aggregarsi in solido fronte, causa carenze di compiuta cultura condivisa e conseguenti fratture della società.
Cultura, visione del mondo, identità profonda e dunque non singola ma comunitaria, sono state del tutto insterilite dopo tre generazioni d’imposta Geocultura altrui. Né istintiva adesione a frammenti affioranti dal passato serve, sono semplici riflessi di tempi tramontati, privi di radici e dunque incapaci d’interpretare compiutamente il presente, di dare idea di sé e anima a nazioni. Meno che mai è possibile prendere in prestito il mondo valoriale altrui, come fanno taluni guardando ad altri Stati-Civiltà. La Geocultura è essenziale per unire una nazione, per costruirvi attorno uno stato, ma è frutto autoctono che impiega molto tempo a maturare – ammesso sia esistente – ne è vietata importazione pena sudditanza. In terra d’Occidente ciò è stato sperimentato per anche troppo tempo.
Come muta il mondo
Da quanto detto è chiaro chi possa ergersi a Stato-Civiltà: Russia, Turchia, Iran, India e Cina ne sono paradigmatici esempi, pur nella loro estrema diversità, e non potrebbe essere diversamente. Più e prima del loro singolo cammino e interessante vedere come la loro ascesa stia destrutturando i pregressi equilibri del mondo e ridisegnando ambiti e aree d’influenza, un tempo caratterizzate dall’indiscusso potere egemonico unipolare oggi in contrazione. Una capacità d’irradiazione che s’intreccia variamente in funzione dei diversi interessi di cui i nuovi attori primari sono portatori, e trova sinergie.
Malgrado aderiscano anche a format partoriti dall’ordine americano (vedi G20, BMI, FMI) gli Stati-Civiltà preferiscono aggregarsi in organismi alternativi (vedi BRICS, SCO, AIIB, etc.), in quanto essi rigettano il concetto di ascrizione a blocco ma, piuttosto, concepiscono i forum cui danno vita come spazi d’interazione per realizzare convergenze d’interessi, strumenti di collettiva affermazione. Nei fatti, consorzi costituiti da portatori d’istanze differenziate – alle volte anche contrapposte – che ambiscono a coltivare in autonomia, rifiutando pretese egemoniche altrui, comunque articolate. Allo stesso modo, essi contestano gli attuali assetti che regolano il Diritto Internazionale e l’ONU, ancora oggi cristallizzati su regole di 80 anni fa, pensate per un mondo che non esiste più da tempo, che continuano ad assegnare spropositato vantaggio a taluni soggetti (vedi il permanere del diritto di veto e i seggi permanenti al Consiglio di Sicurezza assegnati a potenze come Francia e Gran Bretagna oggi marginali). Non ci soffermeremo ulteriormente su questi temi, già in parte trattati in altre occasioni e che comunque necessiterebbero di vasto approfondimento, preferiamo piuttosto tratteggiare i peculiari indirizzi di fondo che stanno emergendo.
Due sono ormai le dinamiche primarie che spiccano consolidate: la prima è lo spostamento del baricentro del mondo dall’area atlantica a quella pacifica, oggi, più estesamente, indo-pacifica. Ciò segna la fine dell’epoca colombiana e di ciò che ha comportato per secoli: un mondo incentrato sui traffici fra le due sponde dell’Atlantico, prima per assicurare risorse e sfogo demografico all’Europa, poi – con la migrazione a Occidente del potere talassocratico – per instaurare il nuovo impero americano cui l’Europa è stata inscritta. Così costituendo un blocco di potere che in fase primaria ha gestito il mondo in condominio con l’URSS e successivamente – dopo implosione della rivale – espandendo il suo dominio su scala globale. Dinamica che abbiamo già lungamente descritto.
Il punto è che, parafrasando Halford Mackinder, negli ultimi decenni – e sempre più velocemente – il cuore da cui si comanda il mondo è migrato nel Mar Cinese e nelle sue appendici, quadrante divenuto rapidamente il più dinamico e ricco del pianeta. Dall’Indonesia al Giappone, dall’India all’isola-continente Australia, passando per Corea del Sud, Taiwan, Vietnam, Malaysia e Singapore, una moltitudine di paesi già in ascesa e proiettati verso future affermazioni contornano quelle acque – e rotte – oggi di gran lunga le più cruciali per ciò che vi è ai margini e vi passa sopra.
Molto ci sarebbe da dire sulle diverse dinamiche che hanno determinato questo radicale mutamento, per brevità diciamo solo che quegli attori hanno utilizzato al meglio gli strumenti della Globalizzazione, seppur in maniera differenziata. Taluni riconoscendosi in essi per convenienze varie, seppur con distinguo (Giappone e Sud Corea), altri per convinzione e contiguità (Australia), altri ancora rigettando l’implicito messaggio geoculturale ma sfruttando appieno i meccanismi economici e finanziari. Fatto è che su tutti è stata ed è la Cina a emergere per stazza, risultati ottenuti e prospettive. Un’ascesa percepita dall’Egemone come doppiamente pericolosa perché avvenuta nel quadrante di mondo divenuto cruciale.
Per gli USA il Pacifico – anzi, ormai dilatato a Indo-Pacifico – è la partita della vita, contenere la Cina è per essi percepito obiettivo irrinunciabile, pena abdicare alla pretesa d’essere Egemone eterno, iattura considerata maggiore delle conseguenze economiche disastrose di una frontale contrapposizione. Ma risorse e attenzione latitano a Washington, assorbite e distratte dai tanti conflitti e dalle molteplici crisi che continuano a gemmare nel mondo, per questo non si stancano di stringere patti e avviare iniziative fra gli attori dell’area, perché siano essi a opporsi a Pechino: l’AUKUS, il QUAD e le tante altre intraprese nel Pacifico tendono a questo. Ma ci sono tanti ma.
Il peso economico e commerciale di Pechino, accompagnato dalla sua estroversione politica, suscitano reazioni bipolari nei suoi vicini. Essi non possono fare a meno del potenziale del Sistema Cina e tuttavia ne temono stazza e postura che intende adeguare alle dimensioni raggiunte. Per loro ideale sarebbe mantenere lo status quo, di arruolarsi senza se e ma sotto le bandiere americane (come gli europei contro la Russia) non se ne parla: hanno troppo da perdere – loro se ne rendono conto – e non si fidano degli USA. Con ciò mostrando assai più discernimento dell’Europa. Per cui nessuno si mostra pronto a scendere in guerra per l’egemonia americana, meno che mai dopo la fuga dello Zio Sam dall’Afghanistan, il sostanziale abbandono dell’Ucraina e la plateale sfida alla talassocrazia americana (essenza dichiarata del potere americano) lanciata nel Mar Rosso non da potenza primaria, come la Cina, ma dallo Yemen. Tutti invece vorrebbero che le cose continuassero come in passato, esatto opposto di ciò che vuole Washington perché quella è dinamica che la vede perdente. Ed evolve verso crescente affermazione cinese.
Per questo diversi “decisori” USA cominciano a pensare a una guerra, da scatenare prima che il progressivo rafforzamento cinese la renda impossibile. Del resto, Geopolitica vuole che le transizioni egemoniche portino allo scoppio di un conflitto, dopo che l’intensificazione massima delle Guerre Ibride (Global Marketing, Guerra Economica e Guerra Cognitiva) si dimostra incapace d’assegnare all’Egemone che le muove una vittoria netta. Il più delle volte è attacco preventivo di soggetto dominante verso quello emergente, oppure conflitto scatenato da potenza in ascesa per ridisegnare l’ordine esistente. Storia afferma che delle ultime 16 transizioni di potere, 14 siano sfociate in una guerra. Tuttavia, pur rimanendo sinistra prospettiva sullo sfondo, dubitiamo di un’immediata evoluzione del confronto sino-americano in conflitto aperto, causa accertata debolezza di Washington – di cui persino essa è per una volta consapevole – e per tradizionale pazienza strategica di Pechino.
Prima di passare oltre, è obbligo soffermarci – sia pur brevemente – sulle trasformazioni in atto in Medio Oriente, frutto di paradigmatica azione di Stato-Civiltà: l’Iran. Facendo leva su Geocultura indirizzata da sapiente Geostrategia articolate nel tempo e nello spazio, esso sta portando a collasso irreversibile il sistema d’assoggettamento posto dall’Egemone sull’intera regione. A ben vedere, l’azione di Teheran non configura proiezione egemonica sul quadrante, bensì l’esportazione di una visione del mondo, di un canone valoriale tradotto in prassi politica differenziata in funzione degli ambiti in cui attecchisce e si sviluppa. Con ciò configurando un nitido esempio di Grossraum che sta sorgendo dalla destrutturazione di precedenti sistemi d’assoggettamento funzionali a interessi esterni all’area, e gestiti in loco da governi del tutto ancillari a essi.
Un’operazione che, malgrado ogni tipo d’ostacolo frapposto, nel lungo periodo sta producendo l’implosione dell’ultima entità coloniale presente nel mondo – Israele – e, più in generale, della prassi colonialista condotta sotto varie vesti dall’Occidente nella regione. Rileva che il degrado dell’egemonismo nell’area è tale da indurre soggetti già inscritti a pieno titolo nel sistema di dominio americano a riposizionarsi per trovare convivenza con la realtà emergente (vedi Arabia Saudita, Emirati, etc.).
Ciò detto, la seconda dinamica primaria che emerge come consolidata nell’attuale transizione egemonica è la ripartizione delle materie prime e il loro utilizzo, che qui, causa vastità del tema, ci limiteremo solo a segnalare. Prassi neocolonialista propria del periodo unipolare voleva che le risorse globali venissero rastrellate dall’Occidente e sue appendici per alimentare le loro economie, dove veniva accumulato un crescente valore aggiunto lasciando briciole al resto del mondo. La situazione attuale evolve a esatto opposto: facendo perno sugli Stati-Civiltà, non più disposti ad assoggettarsi a pratiche derivanti da interessi terzi, i paesi del Sud Globale stanno ridisegnando Geoeconomia e flussi delle commodities. In tal senso esemplare è l’azione dell’OPEC, evoluto armai da anni a OPEC+, che adotta politiche proprie, non più espressione degli interessi occidentali.
Altrettanto emblematica è l’evoluzione che sta avvenendo in Africa, continente simbolo del colonialismo e poi del neocolonialismo. L’Occidente l’ha considerato territorio da cui prendere risorse a discrezione senza nulla lasciare, con risultati devastanti sotto gli occhi di tutti, a questo aggiungendo la pretesa d’imporre standard culturali e politici estranei alle popolazioni. In pratica facendolo oggetto di spietate Guerre Ibride per depredarlo e controllarlo con gli strumenti di Globalizzazione, Imperialismo e Universalismo. Ciò ha generato un rigetto dell’Occidente e delle élite locali che ne erano sua emanazione, un diffuso sentimento che sta dietro alla catena di colpi di stato che negli ultimi anni ha fatto crollare tanti regimi funzionali agli interessi occidentali, e alla vasta approvazione popolare che li ha accolti. E motiva l’ampio consenso alle iniziative di Cina e Russia, quest’ultima perché nettamente percepita come anti-Occidente.
La Cina, in particolare, negli anni ha investito in Africa oltre 400 miliardi di dollari, certo importando materie prime ed esportando prodotti finiti, ma anche costruendo infrastrutture prima inesistenti e ora impianti di trasformazione delle risorse locali, con ciò determinando la crescita di quei territori. Un percorso non privo di criticità (vedi la “trappola del debito”) ma che vengono ora mitigate da percorsi negoziali senza sparare un colpo di fucile né pretesa d’imporre standard politici e culturali di sorta. Con ciò l’Africa (e le sue enormi risorse) è destinata a essere integrata in un percorso di crescita esterno all’Occidente, su cui – semmai – rovescerà le sue produzioni.
Esempi di tal fatta nel mondo ne potremmo portare tanti altri ancora ma non serve, il punto è che l’Occidente – specie l’Europa – verrà tagliato fuori dalle materie prime del Sud Globale (il processo è già in corso), quantomeno costretto a pagarle assai più, e a subirne futura concorrenza con ciò sancendo nel tempo sua definitiva deindustrializzazione e collasso dell’economia. Né in alcun modo suonano convincenti le iniziative messe in cantiere dagli USA per porre rimedio alla situazione: quello americano è sistema già largamente deindustrializzato da molti decenni e la “Rusty Belt” è lì a dimostralo. Per le sue condizioni strutturali, sarà assai difficile – meglio, proibitivo – ridisegnare l’economia degli Stati Uniti, reintegrandovi stabilmente produzioni a medio-basso valore aggiunto: chi vorrà ridimensionare così drasticamente la redditività degli investimenti nella patria del liberismo?
E l’Italia?
Dal punto di vista geopolitico, difficilmente esiste paese la cui via è più nettamente segnata dalla posizione geografica dell’Italia. Ma se ciò è chiaro a fredda osservazione, non lo è affatto a un Sistema-Paese che è “attore mutevole” per eccellenza: incline ad accodarsi a decisioni che altri prendono in sua vece, ad adattarsi a nicchia che gli è assegnata; in definitiva, a seguire interessi di terzi ignorando quali siano i propri. In tale contesto la strategia è assente, meglio, oggetto sconosciuto da un establishment incapace d’articolare pensiero proprio perché aduso ad assumere quello altrui per sudditanza.
A prescindere da giudizi di merito – e sarebbero tanti! – fatto è che i punti di riferimento dell’Italia siano tutti in crisi e ciò che la circonda muti, anzi, è già mutato e muterà ancora. Ciò implica rischio certo di divenire preda o teorica opportunità di conseguire (finalmente) i suoi interessi. Nel mare che la circonda e da cui rifugge come fosse minaccia, nel suo estero vicino (pensiamo all’Africa, che percepisce solo come problema causa migranti, o ai Balcani), nel vasto mondo di cui un’economia manifatturiera ha bisogno per importare risorse ed esportare prodotti. Fatto è invece che malgrado l’Italia si consideri assai poco, disporrebbe – ad applicarvisi e volerla mettere a frutto – di potenziale Geocultura dirompente, proporzionalmente assai maggiore a sua stazza. Sommando un Identitarismo, che terzi sono assai disposti a riconoscerle, a Mercantilismo, potrebbe svolgere un Global Marketing di successo (assai diverso da quello americano, come visto basato su liberismo e assimilazione) che, in termini geopolitici, sfocerebbe in “Patriottismo Economico”, speculare opposto di Globalizzazione. Ad avere capacità di pensiero e volontà che – ahimé – mancano del tutto.
Realtà dice invece che l’Italia da oltre trent’anni, e più che mai negli ultimi, ha fatto sistematiche scelte di campo contrarie ai suoi interessi più elementari, legandosi alle sorti di un Egemone in manifesto affanno invece che ritagliarsi autonomia, con ciò vietandosi di cogliere le opportunità del momento e inimicandosi le realtà emergenti. In pratica, per abituale prassi servilista e incapacità d’autonomo pensiero, si sta addossando costi e conseguenze di conflitti su cui non ha alcuna voce in capitolo, e che gli arrecano sommo danno. Che dire? Se non ci vivessimo anche noi solo: “Auguri!”.


