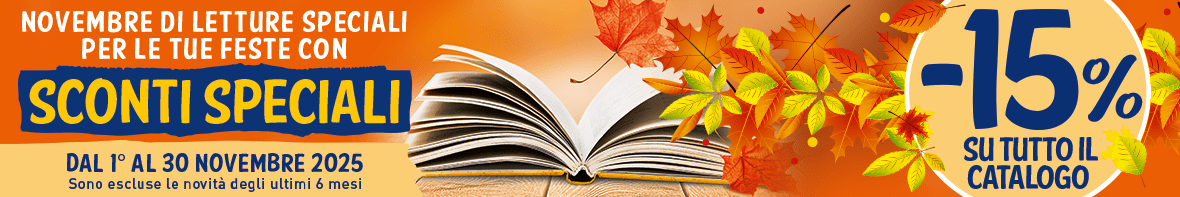La storia si ripete, anche se non allo stesso modo
di Fabio Falchi - 02/09/2010
Ascesa e declino delle grandi potenze è un celebre saggio dello storico Paul Kennedy (1), che suscitò un ampio dibattito sia negli Stati Uniti che in Europa. In quest’opera, Kennedy, prendendo in esame un periodo di tempo che va dal 1500 al mondo contemporaneo, cerca di provare che il rapporto tra le risorse economiche e le spese per la difesa è la causa fondamentale dell’ascesa o del declino di una grande potenza e si propone di offrire una chiave di interpretazione anche per eventi futuri. Nonostante che la prospettiva condivisa dall’autore sia, in un certo senso, economicistica – in quanto Kennedy trascura del tutto i fattori culturali e sociali, pur riconoscendone esplicitamente l’importanza anche per ciò che concerne la storia militare – uno dei meriti del libro di Kennedy è senz’altro quello di aver messo bene in luce non solo che esiste una correlazione tra potenza militare (e ovviamente politica) e potenza economica, bensì che tale correlazione può essere “negativa” quando le spese militari di uno Stato sono di gran lunga superiori rispetto alle sue risorse economiche. Dato che nell’ultima parte dell’opera viene analizzato il rapporto tra gli Usa e le altre potenze, in particolare le “potenze emergenti” (si rammenti che negli anni Ottanta erano già evidenti i segni della crisi strutturale dell’Unione Sovietica), molti pensarono che lo studioso britannico intendesse difendere la tesi secondo cui il declino degli Usa sarebbe stato inevitabile. Tuttavia, tenendo conto della correlazione sopraccitata e del fatto che la potenza di uno Stato è sempre relativa, è evidente che Kennedy invece riteneva che il futuro difficilmente avrebbe visto una egemonia globale degli Usa, vuoi per la crescita economica (favorita anche, secondo Kennedy, da una spesa militare relativamente bassa) di altri Stati (Giappone e Cina, ad esempio) o di altre “entità” politiche (soprattutto la Comunità europea), vuoi per l’insufficiente “base economica” dell’America rispetto alla propria politica di potenza (2). Comunque sia, non v’è dubbio che gli Usa, dopo il repentino crollo dell’Unione Sovietica, abbiano tentato di imporre un modello unipolare (in particolare, cercando di dominare l’Eurasia) e che tale tentativo si possa considerare fallito, in parte proprio per i motivi già previsti da Kennedy nel suo studio.
D’altronde, lo squilibrio tra risorse economiche e potenza militare continua a caratterizzare la politica statunitense e si è addirittura aggravato negli ultimi anni. Malgrado la grave crisi economica che gli Stati Uniti devono affrontare, le spese americane per la difesa, anche durante la presidenza di Obama, tendono a crescere e gli impegni militari all’estero diventano sempre più gravosi, senza che gli Usa riescano a conseguire successi duraturi (vera e propria fuga dall’Iraq, dopo avere causato centinaia di migliaia di vittime civili ed aver compromesso il futuro di quel Paese per molti lustri a venire, nonché l’incapacità di ottenere un reale controllo dell’Afghanistan, nonostante l’impiego dei droni e di numerosi contractors per operazioni cosiddette “sporche”). Solo nel 2009 gli Stati Uniti hanno stanziato per la difesa 534 miliardi di dollari (mentre nel 2010 tale cifra sale a 701 miliardi) benché la somma complessiva sia stata di circa 780 miliardi di dollari, calcolando altre spese (tra cui quelle per la guerra in Iraq e in Afghanistan), ma senza contare i bilanci (segreti) dei servizi d’intelligence (3).
E’ ovvio quindi che tale squilibrio non è causato da scelte politiche contingenti, ma è indice piuttosto di un tratto costitutivo del sistema americano. Tanto è vero che già negli anni Cinquanta il sociologo Charles Wright Mills, in un saggio giustamente famoso, sostenne che in America non vi era una autentica democrazia, poiché il “vero” potere era detenuto da una élite – i cui membri erano ai vertici delle istituzioni politiche, militari e dei maggiori gruppi economici – e l’economia era, in sostanza, un’economia di guerra (4). Del resto, è noto che gli Stati Uniti non uscirono dalla Grande Depressione degli anni Trenta grazie al New Deal rooseveltiano: se la spesa pubblica civile crebbe dai circa 10 miliardi di dollari del 1929 ai 17,2 del 1939, nello stesso arco di tempo il Pil calò da 104,4 a 91,1 miliardi di dollari e la disoccupazione aumentò dal 3,2% al 17,2%. Fu invece la Seconda guerra mondiale che permise agli Usa di risollevare la propria economia e di ridurre la disoccupazione nel giro di qualche anno a poco più dell’1% (5); ed è innegabile che dal dicembre del 1941 la macchina militare statunitense sia cresciuta fino a diventare uno dei pilastri fondamentali (se non il pilastro fondamentale) del sistema americano e della sua proiezione di potenza globale. Se in Europa occidentale, nel secondo dopoguerra, si diffonde il modello del Welfare State, negli Usa si consolida e si rafforza il “complesso” politico-militare-economico, il cosiddetto Warfare State; e se alla fine degli anni Settanta il Welfare viene messo in discussione dalla politica liberista della Thatcher, fino ad essere, in tutta Europa, smantellato o comunque notevolmente ridimensionato, negli anni Ottanta (ossia durante l’America di Reagan, anche lui, come la Thatcher, sostenitore della politica “meno Stato e più mercato”) le spese americane per la difesa aumentano (dal 1981 al 1985) del 7% all’anno; e dopo il crollo del Muro di Berlino, gli impegni miltari degli Usa, anziché diminuire, crescono: prima la Guerra del Golfo, che trasforma il Golfo Persico in un “lago americano”, poi la guerra contro la Serbia, quella contro l’Afghanistan e quella contro l’Iraq; e dal 2001 al 2010 il budget militare statunitense è più che raddoppiato (nel 2001 ammontava a 310 miliardi di dollari). Inoltre, non si può non considerare che, dal 1945 ai nostri giorni, gli Stati Uniti hanno attaccato i seguenti Paesi: Cina (1945-6, 1950-3), Corea (1950-3), Guatemala (1954, 1967-9), Indonesia (1958), Cuba (1959-60), Congo belga (1964), Perù (1965), Laos (1964-73), Vietnam (1961-73), Cambogia (1969-70), Grenada (1983), Libia (1986), El Salvador (anni ’80), Nicaragua (anni ’80), Panama (1989), Iraq (1991-99), Bosnia (1995), Sudan (1998), Serbia (1999), Afghanistan (2001-?), Iraq (2003-?).
D’altra parte, ancora più preoccupante è il fatto che l’economia americana sia talmente dipendente dal Warfare State che Washington potrebbe causare una crisi sociale ed economica ben più grave di quella che già affligge l’America, casomai dovesse optare per una drastica riduzione degli impegni militari e delle spese per la difesa. Vi è poi da tener presente che, se l’alleanza del tutto particolare tra gli Usa ed Israele offre agli Stati Uniti la possibilità di giustificare, indipendentemente da ogni altra considerazione, la presenza delle loro Forze armate nel Mediterraneo (anche dopo la scomparsa del Patto di Varsavia), l’enorme influenza della lobby sionista sulla politica americana rischia di moltiplicare gli impegni americani all’estero e di trascinare gli Usa in ulteriori guerre, allo scopo di difendere gli interessi e la “(pre)potenza” dello Stato sionista (e più passa il tempo e più difficile è capire se sia il cane che muove la coda o se sia la coda che muove il cane). Di conseguenza, sembra che la fine dell’unipolarismo statunitense non si configuri tanto come l’inizio di un nuovo equilibrio mondiale di tipo multipolare, quanto piuttosto come l’inzio di un nuovo scontro tra potenze. Se si ritiene con Costanzo Preve che la Quarta guerrra mondiale sia cominciata subito dopo la scomparsa dell’Unione Sovietica, allora pare giustificata l’affermazione che la prima fase di questa guerra si è sostanzialmente chiusa con una sconfitta strategica americana: non solo la “marea” americana si è fermata ben prima di poter raggiungere il “cuore” dell’Eurasia , ma il Leviatiano incontra difficoltà crescenti perfino in America latina (Venezuela e Brasile), si ritira dall’Iraq, sembra essersi smarrito nel labirinto afghano, non ha il completo “controllo” del Pakistan, è sul punto di perdere un alleato prezioso (la Turchia), deve affrontare nuove sfide di grandi potenze (la Russia e la Cina), “monitorare” la Corea del Nord e al tempo stesso è fortemente condizionato dalla lobby sionista, che preme per un sostegno alla politica d’Israele contro il popolo palestinese e per un’azione il più possibile dura nei confronti del Libano, della Siria e dell’Iran. Anche Tokyo dopo decenni di cieca (per quanto comprensibile) obbedienza a Washington, pare che voglia far capire alla Casa Bianca che il Giappone non è uno Stato americano. Cionondimeno, alleati fedeli del Leviatano rimangono- oltre ai Paesi “English speaking” e allo Stato sionista – i Paesi europei, anche se forse più per viltà che per convinzione, dato che perlomeno alcuni di essi avrebbero tutto l’interesse – non solo economico – a cercare di “smarcarsi” dagli Usa.
*
Rebus sic stantibus, non meraviglia quindi che ai gruppi dominanti italiani (ovvero i gruppi economici che, privi di strategie adatte ad un Paese industriale avanzato, incapaci di slancio produttivo e contrari ad un autentico rinnovamento sociale, possono continuare a difendere le proprie posizioni di privilegio solo impedendo che siano protetti e potenziati i settori strategici – Eni, Enel, Finmeccanica etc.- del Paese e penalizzando le piccole e medie imprese) (6) – convenga che la politica italiana sia del tutto subordinata agli interessi d’Oltreoceano (e naturalmente a quelli dell’entità sionista). Quanto affermato più volte dalla redazione del Coordinamento Progetto Eurasia e da quella del blog Conflitti e Strategie – vale a dire che in Italia da tempo opera una “quinta colonna” – non ha nulla a che fare con il “complottismo” (se è vero però che vi sono persone che vedono “complotti” ovunque, è anche vero che ve ne sono altre che pensano che non esistano né strategie né tattiche né “tendenze oggettive” – tanto che giudicherebbero anche Hegel un “complottista” perché la sua ricostruzione della storia della filosofia non è a lume di filologia, bensì di filosofia), ma trova puntuale riscontro nella realtà. Infatti, basta leggere i giornali di questi giorni per rendersene conto. Si attacca il Governo, non certo per difendere quel che è rimasto dello Stato sociale, il potere d’acquisto dei ceti meno abbienti o per criticare le privatizzazioni degli ultimi vent’anni (e l’elenco sarebbe lungo…), ma soprattutto per gli accordi con la Russia e la Libia, considerati come “mero affarismo” dai difensori dell’Occidente, notoriamente poco interessato al business. Ovviamente, si solleva pure la questione dei cosiddetti “diritti umani” (senza neanche prendere in considerazione se per tutelare questi “diritti” – ammesso e non concesso che sia possibile comprenderne il “senso” indipendentemente da ogni riferimento alle diverse culture dei diversi popoli – non sia meglio un “approccio indiretto”, per così dire, che non la politica del “muro contro muro”), sebbene possano essere violati da qualunque “Stato amico”, secondo il principio di “due pesi e due misure”. E che queste critiche al Governo siano fatte da “vili affaristi”, faccendieri di ogni risma, marionette a stelle a strisce e “riciclati” di ogni specie, sarebbe addirittura comico se l’Italia, rinunciando a sfruttare le proprie “potenzialità geopolitiche”, non solo corresse il rischio di giocarsi definitivamente la possibilità di acquisire maggiore indipendenza e di incrementare il proprio sviluppo, ma di essere coinvolta in un conflitto tra potenze (anche militare, per le ragioni già brevemente esposte), avendo tutto da perdere e ben poco o nulla da guadagnare.
*
Il prezzo che pagò l’Italia per una guerra non solo perduta ma perduta assai malamente fu, tra l’altro, quello di una grave limitazione della propria sovranità. Ciononostante, la guerra fredda diede all’Italia nuovamente la possibilità di fare scelte autonome e di intensificare le relazioni con i Paesi del Mediterraneo (tanto da poter fare una politica moderatamente filopalestinese) e perfino con la stessa Unione Sovietica, mentre il Welfare, sia pure all’italiana (precisazione necessaria, anche perché la mancanza di una vera tradizione socialdemocratica differenzia nettamente l’Italia da altri Paesi europei), evitò (o contribuì ad evitare) che i conflitti sociali e politici, per quanto aspri, degenerassero in una guerra civile (che non è difficile immaginare come sarebbe finita, tenendo conto della presenza delle basi Nato in Italia). Ormai però l’Unione Sovietica appartiene al passato, la Nato da alleanza difensiva si è trasformata in un’organizzazione politico-militare al servizio della Casa Bianca e in Italia le basi Nato sono oltre un centinaio. La politica filopalestinese ha lasciato il posto ad un filosionismo vergognoso, “girotondini”, guitti e giullari di corte guidano la protesta e si vuole completare l’opera, iniziatasi con “Mani pulite”, facendo in modo che il Welfare State (all’italiana) diventi un “ingranaggio” del Warfare State americano. Con conseguenze, anche in questo caso, facilmente prevedibili, dacché si dovrebbero molto più temere gli “amici” che non i “nemici”.
Oggi più che mai ci vorrebbero “nocchieri” esperti e coraggiosi, mentre al timone vi sono marinai d’acqua dolce ed “imbelli”. Nell’estate del 1943, una volta “liquidato” il regime fascista, la classe dirigente italiana pensò unicamente a salvare sé stessa, infischiandosene degli italiani. Dall’inizio degli anni Novanta, la classe dirigente italiana se ne infischia completamente degli italiani e ora la parte di essa che “conta” si appresta a “liquidare” non un regime fascista (che esiste solo nelle menti ottenebrate di ex sessantottini imbottiti di dollari) né i marinai d’acqua dolce, ma il Paese. Come sempre, la storia si ripete, anche se non allo stesso modo.
NOTE
1) P.Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, Garzanti, Milano, 1989.
2) Ibidem, capitolo VIII, Gli Stati Uniti: il problema della prima potenza in relativo declino, pp.694-721.
3) http://byebyeunclesam.wordpress.com/2009/09/29/il-bilancio-occulto-della-difesa-americana
4) C.W.Mills, The power elite, trad. italiana L’élite del potere, Feltrinelli, Milano,1986.
5) Per questi dati, si veda, ad esempio, F. Battistelli, Armi: nuovo modello di sviluppo?, Torino, Einaudi, 1980.
6) Si veda l’ultimo articolo di Gianfranco La Grassa, http://conflittiestrategie.splinder.com/post/23219919/nessuno-dice-basta-di-giellegi-il-29-ag-10