Il lato oscuro del progresso
di Rita Remagnino - 22/11/2025
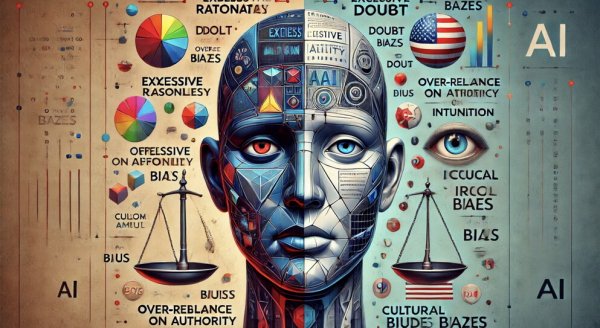
Fonte: EreticaMente
La «cultura della misurabilità» attualmente prevalente – emersa con la rivoluzione scientifica del XVI-XVII secolo – si fonda sull’idea che i fenomeni possano essere quantificati, misurati e analizzati attraverso strumenti e metodi matematici. Da qui, l’assunto secondo cui l’umanità si troverebbe all’interno di un «Grande Oggetto», cioè in una specie di universo-macchina (non si sa bene creato da chi, né per fare cosa) che lo scienziato inglese Rupert Sheldrake nel suo saggio Le illusioni della scienza ha schematizzato in modo esemplare:
- la Natura si comporta come una macchina
- il complesso energia-materia non può cambiare
- le leggi della Natura restano invariate
- la materia non ha alcun genere di coscienza
- la Natura non ha alcuno scopo, né obiettivo
- l’eredità biologica è trasmessa nella materia
- ciò che rimane nella memoria lascia tracce materiali
- la mente è un prodotto soltanto del cervello
- i fenomeni psichici sono illusioni
- la medicina materiale meccanicista è l’unica che funziona
Figure di riferimento come Copernico, Galileo, Keplero e Newton, hanno convinto la cosiddetta società occidentale che l’universo può essere compreso solo attraverso la ragione e l’osservazione sistematica. Una visione condivisa da Kant (Critica della Ragion Pura, 1781), che proclamò l’intelletto “legislatore della natura” e organizzatore dell’esperienza secondo categorie a priori.
In questo clima di «ottimismo radicale» presero forma sia il socialismo utopistico del XVIII-XIX secolo (Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc) sia il comunismo nato a Londra nel 1848 (Marx ed Engels, “Manifesto del Partito Comunista”), entrambi proiettati verso l’idea di un futuro alleggerito dalla fatica del lavoro grazie all’automazione e liberato dalle malattie per merito delle nuove «scoperte» scientifiche.
Ancora stiamo aspettando la realizzazione di queste rosee previsioni; la vana attesa, tuttavia, non ha impedito a vari intellettuali di immaginare società ideali basate sulla cooperazione e sul progresso tecnologico. Una visione ripresa ed ampliata nella seconda metà del Novecento dalla religione implicita transumanista, e in particolare dalla corrente denominata «extropianesimo» (da extropy, concetto opposto a entropy), fondata negli anni ’80-’90 dal filosofo Max More, con il quale si aprì una nuova «via della salvezza», riassumibile nel modo seguente:
1. Dinamica anti-entropica
L’extropia va perseguita come simbolo di ordine, intelligenza e crescita contro il degrado naturale (es. Alcor e la criogenia).
2. Ottimismo tecnologico
La scienza e l’innovazione risolveranno problemi antichi come la morte, la malattia e la scarsità di risorse.
3. Auto-direzionalità
Ogni individuo ha il diritto di modificare se stesso a piacimento, senza vincoli etici e/o biologici (es. wokismo, teorie di genere).
4. Autotrasformazione perpetua
I limiti biologici sono superabili attraverso le biotecnologie, la cybernetica e le IA.
5. Espansione nell’universo
La colonizzazione spaziale permetterà la creazione di una civiltà post-umana su altri pianeti (es. Marte).
Sviluppandosi in modo in modo tecnocentrico, il manifesto extropiano si fonda sull’idea che il progresso tecnologico, guidato da principi di razionalità ed espansione perpetua, alla fine valicherà ogni confine. In questo modo, il miglioramento dell’individuo (fisico, cognitivo ed emotivo) verrà garantito dall’avanzamento sinergico di biotecnologie, intelligenza artificiale, crioconservazione e nanotecnologie.
Utopie a parte, la teoria di More – un misto di tradizione illuminista e fantascienza americana – ebbe la lungimiranza di comprendere che il sistema geopolitico mondiale stava andando verso la multipolarità, perciò volse lo sguardo a Oriente. Dal taoismo attinse l’idea di ottimizzazione dell’energia vitale (qi), adattandola alla concezione di auto-miglioramento intelligente. Dal buddhismo (soprattutto Zen e Vajrayana) trasse alcuni parallelismi fra il superamento dei limiti biologici e la liberazione dal ciclo del samsara (rinascita). Dall’induismo (e dallo Yoga) prese il concetto di moksha (liberazione), destinato a sfociare nelle tecniche atte a trascendere i limiti fisici attraverso la tecnologia (biohacking).
Se si esclude l’aspetto proattivo dell’approccio estropianista (modificare attivamente la realtà), estraneo alle tradizioni orientali che invece privilegiano l’accettazione e il distacco, non si riscontrano vere novità in questa corrente, bensì rivisitazioni di antichi saperi. Ma d’altra parte, come scrisse Fritjof Capra nel celebre saggio The Tao of Physics (1975): le «scoperte stupefacenti» della fisica della seconda metà Novecento (in prevalenza, anglo-americane), sono ri-elaborazioni di antiche concezioni del cosmo di matrice eurasiatica.
Dunque, siamo in presenza di un «colonialismo di ritorno»:
• Teoria delle Stringhe/Multiversi ↔ “Net of Indra” buddhista (gioielli che si riflettono all’infinito).
• Ologrammi e Informazione Quantistica ↔ realtà come proiezione (maya nell’Advaita Vedanta).
• Eco-transumanesimo ↔ visioni animiste e panteiste (dallo sciamanesimo siberiano a Eraclito, fino a Spinoza), con la sola aggiunta dei rischi mascherati da «misure salva-pianeta» (es. greenwashing high-tech e geoingegneria).
• Etica delle IA e mind uploading ↔ domande già presenti nel dibattito «materialismo antico vs idealismo platonico»: “La mente può essere meccanizzata?“
Ecco perché Higgs non ha scoperto dio, né Darwin è riuscito a provarne l’inesistenza. Detto altrimenti (e parafrasando Max Planck): da decenni l’umanità sta procedendo “di funerale in funerale”. Invece di progredire verso un futuro migliore (come si credeva all’inizio dell’Illuminismo e del Positivismo), ci siamo prodigati a sfornare idee già cotte e vendere speranze di seconda mano, lasciando spazio a nuove disillusioni.
Ed ecco perché la scienza contemporanea non ha sviluppato dell’infinito una visione più profonda di quella posseduta dall’uomo primordiale, ma ha permesso alla cultura scientifica di trasformarsi in una florida industria. Soprattutto negli Stati Uniti, perché l’Europa post-bellica era troppo impegnata a raccogliere le macerie e regolare i conti con gli ideologismi ereditati dal nazifascismo, sui quali non è ancora riuscita ad avere la meglio.
Più cauta si è dimostrata la società cinese (grazie al concetto confuciano di zhōngyōng), che ha investito enormi capitali nella tecnica senza per questo abbandonare la cultura tradizionale, o tagliare i ponti con il proprio passato. In Occidente, avremmo potuto fare la stessa cosa: era prevedibile che la conoscenza scientifica non sarebbe bastata per salvare l’umanità da se stessa.
Il nostro mondo, invece, è rimasto invischiato nel rapporto conflittuale tra l’intelligenza tecnica dell’uomo e la sua immaturità. Ne è una testimonianza lo spettacolo mortifero offerto dalla scienza ufficiale, traducibile in una proiezione in loop di fotogrammi appartenenti a una mentalità anacronistica ripartita in categorie predefinite (es.: “soggetto/oggetto”, “natura/società”).
Intanto, il pensiero critico langue e le élite culturali sono state neutralizzate dal neoliberalismo e da internet (es. social network, YouTube, Netflix). Tra le persone di mezza età la cultura è diventata un passatempo, come la televisione o il giardinaggio, mentre tra i giovani funziona il ragionamento astratto e spaziale (es. trovare modelli in serie di figure, matrici di Raven) ma latitano le conoscenze generali, cioè la capacità di linguaggio e le abilità aritmetiche (effetto Flynn).
Muovendosi tra reminiscenze hippie, psichedelia, feticismo tecnologico e autoreferenzialità, la stessa «ideologia californiana» sta degenerando in tecnicismi fini a loro stessi. Colorati di neo-gnosticismo, i suoi riti si svolgono nei Templi della Scienza (Mit, politecnici, centri di ricerca, ecc.), mentre il teismo è gestito da potentissime lobby agenti in qualità di entità superiori o semi-divine che difendono colossali interessi economici.
Sia chiaro: nel sottobosco di questo oscuro villaggio governato da superomismo e scientismo magico, gli scienziati non-meccanicisti ancora esistono, ma i loro studi vengono sistematicamente sottratti all’attenzione del grande pubblico, per il quale, come sempre, valgono le teorie generate dal modello di produzione e sostituzione introdotto dalla Rivoluzione Industriale sette-ottocentesca (econocratica e anglosassone), promotrice del progressismo scientifico ad lìbitum.
Se volessimo condensare in un’immagine l’antropologia del progresso, potremmo disegnare la lotta tra la piramide (simbolo universale di trasformazione, ordine divino e ricerca della verità ultima) e la torre (simbolo di hybris, tracotanza e materialismo).
La piramide è stabile, poggiando su una base larga e solida (cultura + civiltà), mentre la torre è costantemente in bilico a causa della sua struttura «verticalista», ovvero «totalitaria», che istiga i costruttori umani ad alzarla sempre di più. Il suo delirio di onnipotenza è collegato al mito gnostico dello specchio (il mondo materiale è un’illusione da superare), oggi plasticamente espresso dal «Tempio del Dataismo» – l’Oracle HQ di Redwood City, California – composto da una schiera di altissimi grattacieli o torri che riflettono le loro sagome nell’acqua.
Si direbbe che i titani del tech siano consapevoli del peso della frammentazione dei saperi sulla creazione di categorie superflue di «scienziati senza cultura» e «mercanti senza scienza». O, forse, questo centro carismatico dall’apparenza mistica va preso senza filosofemi, essendo un’espressione del sogno umano di ridurre la complessità del reale a puri dati, ad algoritmi dominabili.
In entrambi i casi, comunque, il dataismo rivela gli stessi limiti che rivelò lo gnosticismo, il quale scambiò il riflesso per la sostanza, l’astrazione per la vita, condannandosi a fuggire in eterno dalla prigione della materia. Oggi tocca all’Oracle HQ di Redwood City il compito di esprimere il desiderio di evasione dalla materialità, simbolo dell’ideologia che ha sostituito il reale con la sua rappresentazione. La sostanza, però, è la stessa.
Ugualmente i transumanisti ansiosi di convertire il processo di trasvalutazione in elevazione, o liberazione, rischiano di essere attratti nell’orbita di un nuovo centro di natura ignota, e non necessariamente positiva, da cui si irradieranno nuove e più sofisticate illusioni. Meglio sperare in una “riforma del pensiero” (Edgar Morin), cioè in un sapere integrato capace di ricucire gli strappi tra discipline, riconnettendo l’umano al mondo.
Anzi: questo sapere potrebbe già essere attivo nelle pieghe invisibili del presente e operare per la risoluzione del conflitto «torre vs piramide». Ma non è il caso di montarsi la testa: siamo tutti troppo coinvolti per produrre risultati apprezzabili in tempi brevi, mentre il pensiero critico ha bisogno di una mente fredda per riprendere a funzionare, e quindi riconoscere la rete in cui attori umani e non-umani si muovono con pari dignità, incontrandosi e scontrandosi.
Proprio l’infrazione del patto originario che assemblò gli umani in insiemi di relazioni con animali, vegetali e minerali, ci ha portato qui dove ci troviamo adesso. Offrendoci, se non altro, la possibilità di riconoscere che l’uomo, in fondo, non è mai stato veramente moderno, essendo rimasto un apprendista stregone (B. Latour, Non siamo mai stati moderni, Elèuthera, Milano, 2018).
