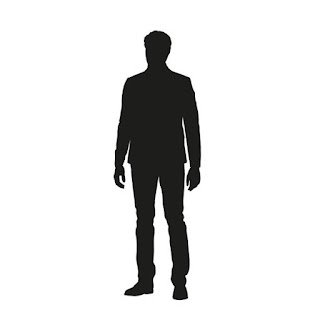1
Epicuro fallisce nel suo ragionamento per cui essere morti è un attributo che nessuno può avere (“se c’è la morte, non ci siamo noi, se ci siamo noi non c’è la morte”) perché non possiamo fare a meno, come persone, di sapere che un giorno non saremo più ma saremo stati. Noi anticipiamo uno sguardo retrospettivo su noi stessi che non potrà essere il nostro sguardo: ci poniamo all'esterno di noi stessi anticipando questo "divenire essere stati". Tale momento non si può integrare con il resto del nostro passato, ponendo una discontinuità radicale tale per cui la vita precedente appare quella di un altro uomo. Solo le persone hanno una conoscenza anticipatrice della propria fine (non gli animali) e sono in grado di proiettare uno "sguardo da nessun luogo" sul mondo come sarà una volta morti. Esso è lo sguardo della ragione che sa che la propria morte è la fine del mondo perché il mondo esiste solo come mondo di qualcuno e come mondo mio esso finisce.
2
La conoscenza della propria morte è qualitativamente diversa da tutti gli altri tipi di sapere, con i quali per esempio possiamo pianificare qualche impresa che importi un certo impiego del tempo o anche superi per estensione la durata della vita. Si tratta qui di un sapere circa la durata oggettiva della vita commisurata con qualche attività che sarà possibile attuare solo parzialmente in prima persona. Qui c’è un semplice rapporto mezzi-fini. Ma quando consideriamo la vita stessa una di queste imprese che si pianificano dentro la vita, qui inizia un’illusione che ci sia stata consegnata una configurazione carica di senso come la vita, quale impresa definita. Ciò presuppone che noi possiamo trarre un bilancio della vita nella sua totalità. Questa è un’illusione perché si fonda sulla finzione di disporre un criterio di giudizio della vita nella sua totalità, come se ci trovassimo fuori dalla nostra vita.
Tale finzione
1) è possibile solo alla persona
2) altera ciò che costituisce la specificità della nostra vita personale, che consiste nel disporre della nostra vita e dunque nel poterla perdere.
Ma
Perdendo la vita, ciò che l’uomo perde è se stesso. Il poter perdere la vita non è quindi un’opzione equivalente a qualsiasi altra, in particolare non è espressione del possesso della vita, perché chi perde la sua vita non continua come soggetto dopo questa perdita, mentre chi perde qualsiasi altra cosa, persiste come soggetto che manca della cosa persa. Quindi, benché la persona possa attuare questa finzione, non c’è un criterio per poter dire in modo definitivo che la propria vita è priva di senso, anche qualora la si “perdesse”, cosa che farebbe mancare il soggetto del giudizio.
Infatti un conto è lo sguardo da nessun luogo della ragione che può esercitarsi sul complesso della nostra vita, altro conto è l'individualità vivente che non ha un essere al di là della vita e quindi può solo fingersi un criterio esterno per giudicarla. Ogni criterio di giudizio della vita è dentro la vita e quindi determinato dalla vita, e non esterno. Giudicare dall’esterno sarebbe una fuga dall’essere se stesso personale
Ugualmente una considerazione del senso della vita in base a probabilità rientra nella fuga dall’essere-se-stesso personale perché la probabilità riguarda il ripetibile e la vita di ciascuno non è una vita fra le altre ma è unica.
Gli animali non possono considerare la propria vita in generale da un qualche punto di vista comparativo. Sono sempre al centro del loro mondo e non anticipano la loro morte. Il punto di vista della ragione rende la propria vita commensurabile con quella di tutti gli altri. La scoperta della persona è equivalente alla scoperta dell'incommensurabilità della propria vita personale con quella degli altri. Non potendo avanzare alcuna probabilità di durata – perché la propria vita è unica e non comparabile con quella di altri – l’ignoranza del momento della morte è rilevante e fa sì che la morte “colori” ogni momento della propria vita.
Vedere la vita nella sua totalità non è un immaginario compimento da un qualche punto di vista esterno, ma accade nel mezzo della vita quando la persona si comporta in un determinato modo con la propria vita. Noi non sappiamo quando moriremo. In ogni momento occorre saper morire senza che si debba dire che si è morti troppo presto. Nessuno muore troppo presto. Quindi è nel mezzo della vita che si dà la possibilità del compimento definitivo – la morte – che ci consente di proiettare lo sguardo sulla totalità della nostra vita, e che dunque fa sì che in ogni momento noi siamo al cospetto della totalità della nostra esistenza.
3
La riflessione sulla morte e sulla sua presenza in ogni momento della nostra vita rivela il carattere relativo di ogni contesto vitale. Ciò che nella vita è sensato, esiste soltanto nel presupposto della vita; dunque, non può valere per la vita stessa. Così appare l'idea di una mancanza di senso della vita. Nella vita, infatti, abbiamo familiarità con le cose ma non con la vita stessa. L'assenza di senso sta nel fatto che il non aver familiarità con la vita ma solo con le cose della vita ci fa apparire la vita insensata. Ma, a partire da ciò, noi scopriamo qualcosa che è oltre il vitalmente rilevante: un orizzonte di senso o contesto di senso che c'è soltanto per chi ha scoperto che morirà cioè per chi ha scoperto la finitezza del finito. L'assurdità di ciò che è semplicemente vitale integra l'ambito vitale di rilevanza. Ciò significa che oltre a quel che interessa al prosieguo della vita, vi è un senso dell'assurdo che la mette in questione globalmente, eppure tale senso diviene parte della vita stessa, cioè la integra. Questo si chiama contesto di senso. Noi sappiamo che ad un certo punto, di fronte alla morte, nulla di ciò che è familiare conterà più.
Ma esiste un'altra possibilità su cui è decisivo soffermarsi.
C’è la possibilità che non ci si veda minacciati dalla fine di tutto, perché qualcosa di prezioso sottrae qualche evento alla contingenza. È un bene che resterà comunque, malgrado la sua fuggevolezza, nel senso che se qualcosa di bene è capitato, è un bene che rimane il fatto che sia capitato e sarà sempre bene che sia avvenuto. Il niente di ciò che scompare nel tempo diviene prezioso. Si veda con la trasformazione dell’espressione “adesso” che indica qualcosa che scompare subito e passa, con l’espressione il 17 marzo 1996 alle ore 10 in cui ciò che è accaduto adesso, 17 marzo 1996 alle ore 10, rimane per sempre. Già nel tempo e in modi temporali, quindi, possiamo esprimere la partecipazione dell’adesso all’atemporalità mediante il futurum exactum. Il sarà stato 17 marzo 1996 sarà sempre stato e sarà vero sempre se l’adesso lo è stato una volta.
Un’azione buona, che è stata pur inefficace , viene tramandata e onorata come tale e pertanto viene fissata come un bene che rimane. Questa fissazione come qualcosa che permanentemente sarà stato un bene, la rende eterna, è il futurum exactum. Ora, l’anticipazione della morte colloca la vita come un tutto nella dimensione del futurum exactum. La sua finitezza non la rende assurda ma è la condizione del fatto che essa sia esperita come qualcosa di prezioso. Tale anticipazione della fine rende dunque possibile l’esperienza del senso e risulterebbe possibile se la vita continuasse indefinitamente, perché qualsiasi cosa fatta potrebbe essere rifatta e l’anticipazione dell’infinitezza soffocherebbe ogni relazione umana come relazione di esseri finiti. Insomma l’anticipazione della morte rende possibile il fatto che noi assumiamo la nostra vita come un tutto, cioè rende possibile il possesso della vita che connota l’essere personale.
4
Solo una vita personale può essere offerta: il morire come dedizione della vita e non come puro soccombere, come lo concepisce l’epoca contemporanea impegnata a prolungare la vita. Il cristianesimo considera il morire non come semplice estinguersi, ma come un’ultima cosa che all’uomo morente viene chiesto di compiere. La morte non appartiene alla dinamica della vita, ma il morire sì, ed è un atto, perché è il finire il movimento da parte di colui che si muove. Nella morte personale vi è una passività che è un subire che viene realizzato come atto. Ciò è compatibile con l’idea che l’uomo ha ricevuto e accolto il suo essere e lo possiede come un compito da realizzare. Anche il soffrire è una forma dell’essere che è dato e subito ma in tale subire è incluso l’accogliere riconoscente. Accanto a tale accogliere vi è anche un dover dare, un consegnare tutta la vita, anche la passata che è già sottratta in quanto passata e che la morte non può sottrarre ulteriormente ma solo fissare nel ricordo collettivo degli altri uomini e così renderla da loro posseduta…Il consegnare la vita diventa così una vera e propria preservazione di un reale possedere e così il morire diventa atto per eccellenza. Ed è l’anticipazione della morte, la conoscenza dell’inevitabile perdere tutto che, attraversando e strutturando la nostra vita, rende personale una vita. Solo l’affermazione del futurum exactum lascia che il presente diventi reale in senso pieno.