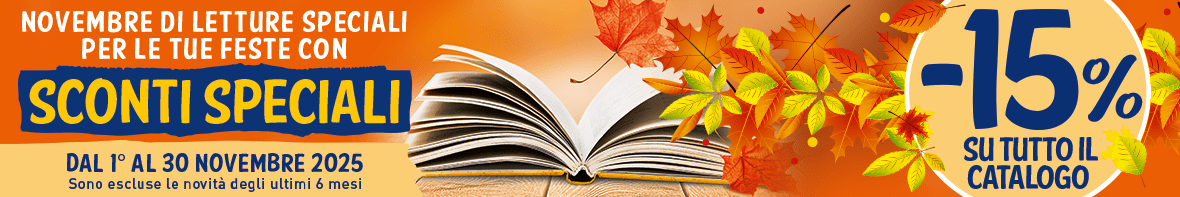Nobel o no, è sempre Zio Sam
di Roberto Zavaglia - 13/12/2009
Non essendo uno stupido, Obama è consapevole della stranezza di vedersi assegnare il Nobel per la Pace, pur essendo il capo di un Paese impegnato in due guerre. Nel suo discorso a Oslo, ha dunque cercato di rimediare a quella che appare a molti una palese incoerenza, affermando che “gli strumenti di guerra giocano un ruolo nel preservare la pace”. Si tratta, in pratica, di una ripresa dell’antico “si vis pacem para bellum”, che potrebbe essere sottoscritto da qualsiasi leader di qualsivoglia Stato al mondo. Attualmente, non si vedono in giro molti politici che, futuristicamente, esaltano la guerra come sola igiene del mondo. Se si chiedesse a Putin o a Hu Jintao perché continuano a rafforzare i propri eserciti, non darebbero una risposta molto diversa da quella di Obama, ma almeno la Russia e la Cina non sono, in questo momento, coinvolte in alcun conflitto.Al di là delle tante considerazioni negative che si potrebbero fare sui criteri di assegnazione di questa onorificenza, gli accademici norvegesi hanno deciso di conferire il Nobel a Obama non per quanto ha (ancora?) fatto, ma per le enormi attese che si sono concentrate su di lui. Come è noto, la storia personale e il colore della pelle del presidente Usa hanno fortemente aumentato le aspettative, ma l’atmosfera messianica che ha accompagnato la sua elezione non ci sarebbe stata senza il processo di personalizzazione della politica cui assistiamo da anni. E’ una deriva che ben conosciamo anche in Italia, dove il modesto dibattito sulle riforme istituzionali si concentra, soprattutto, sulla ricerca di tecniche (trucchi) elettorali per fare emergere due soli capi contrapposti, affinché, si sostiene, i cittadini possano scegliere in modo chiaro. Il popolo, ma meglio sarebbe dire gli spettatori, deve quindi concentrarsi sulle personalità dei candidati per comprendere quale sia il più adatto a governare.
Detto in modo lapidario, la personalizzazione della politica nelle democrazie parlamentari non è altro che una delle manifestazioni dell’antipolitica. Spostando l’attenzione dai contenuti alle “figure”, si priva la politica delle idee “in concorrenza” che ne dovrebbero costituire la base, le quali idee, infatti, dovrebbero avvicinarsi tutte verso un centro pragmatico, differenziandosi solo attraverso sfumature di metodo. Il leader carismatico scelto dagli elettori, essendo privo di un progetto e di una base sociale di sostegno, nulla potrà, però, contro gli interessi concreti che si imporranno facilmente. E’ un po’ quanto sta avvenendo con la presidenza Obama che, non a caso, sta deludendo molti dei suoi più ferventi sostenitori.
Se ci si chiede cosa di concreto ha combinato, finora, il “primo presidente di colore”, dove si è esplicata la sua ansia di cambiamento, l’ossessivo “change” della sua campagna elettorale, non si trova molto al suo attivo. Dopo avere foraggiato le banche con denaro pubblico, non è intervenuto per correggere i meccanismi di mercato che avevano causato la crisi. Nei giorni tumultuosi dei salvataggi degli istituti finanziari, sembrava che nulla potesse continuare come prima. Ci si aspettava che fossero aboliti, per legge, quegli strumenti della finanza creativa che avevano messo in crisi il sistema, gettando sul lastrico una massa di persone. Obama, che è contornato di consiglieri economici vicini a Wall Street, si è limitato a fare qualche paternale, mentre le banche hanno ripreso a guadagnare con gli stessi metodi spericolati del passato.
In campo sociale, il presidente vorrebbe introdurre maggiori tutele, avvicinandosi, almeno un poco, al modello europeo. Anche in questo caso, però, ci sono delle lobby che già lo hanno costretto a limitare l’impatto delle sue decisioni. Mercoledì scorso, una commissione di senatori democratici ha, forse definitivamente, messo fine alla cosiddetta opzione pubblica nell’ambito della riforma sanitaria, che prevedeva un intervento diretto dello Stato. Se, alla fine, la riforma otterrà l’approvazione del Congresso, vi saranno solo alcuni parziali progressi sul piano dell’assistenza, ma le grandi compagnie assicurative continueranno a gestire tutto il sistema.
Per quanto riguarda i fronti di guerra, le cattive notizie arrivano non solo dall’Afghanistan, ma anche dall’Iraq in cui, una volta di più, Washington ha creduto troppo presto di essere vicina alla “soluzione del problema”. Che la situazione non sia affatto pacificata, lo dimostrano i cinque attentati compiuti a Baghdad, martedì scorso, in meno di un’ora, che hanno causato almeno 120 morti. Mentre il popolo iracheno continua a versare il proprio sangue per le conseguenze dell’invasione, il previsto rientro delle truppe Usa diventa sempre più dubbio poiché, se avvenisse nei tempi previsti, il Paese rischierebbe di piombare in un caos dal quale potrebbero emergere forze ostili a Washington. Dell’aumento dei soldati in Afganistan deciso da Obama si sa, ma è interessante riflettere su un passaggio del discorso con il quale il presidente lo ha annunciato: “Al contrario delle grandi potenze del passato, noi americani non abbiamo cercato di dominare il mondo. Noi non cerchiamo di occupare altre nazioni, non pretendiamo le risorse di altre nazioni e non colpiamo altri popoli a causa della loro fede o etnia differenti dalla nostra”.
In queste parole, si evidenzia come Obama non sia affatto un “uomo nuovo”, estraneo alla tradizione Usa. C’è infatti l’eco della consueta polemica statunitense contro il vecchio imperialismo europeo, con la quale si ribadisce il destino eccezionale della “città sulla collina”, dove l’avvento della giustizia e della libertà hanno messo fine agli intrighi e all’immoralità del Vecchio Continente. Il presidente ha piena fede nella superiorità del modello Usa, ma in politica estera lo applica in senso “realista”. Dopo i disastri compiuti dai neoconservatori della precedente Amministrazione, che in fondo reinterpretavano la tradizione wilsoniana di interventismo democratico alla luce del crollo dell’Urss, Obama sa di dovere fare un passo indietro. Non c’è più dunque l’ambizione di esportare la democrazia, intendendo con ciò la volontà di estendere universalmente il proprio sistema politico e sociale, ma rimane la rivendicazione che gli Usa combattono solo guerre giuste, mai per motivi di potenza.
Ragionando in modo realista, Obama ha deciso di continuare i conflitti in cui ritiene in gioco il prestigio degli Usa, indicando però un termine delle operazioni militari, senza ricercare una vittoria definitiva. Più in generale, ha posto fine al clima aggressivo con cui gli Usa avevano gestito la prima fase del postbipolarismo soprattutto nei confronti della Russia, comprendendo che le sconfitte sul campo e la pesante crisi economica imponevano una svolta. Non è poco ed è tutto quanto è nei suoi, limitati, poteri. Di rivoluzione americana, contrariamente a quanto credevano gli ingenui, ce n’è stata solo una e non l’ha fatta Obama.