Il filo rosso ed il quadro storico che legano Leone XIII a Leone XIV
di Fabrizio Pezzani - 11/05/2025
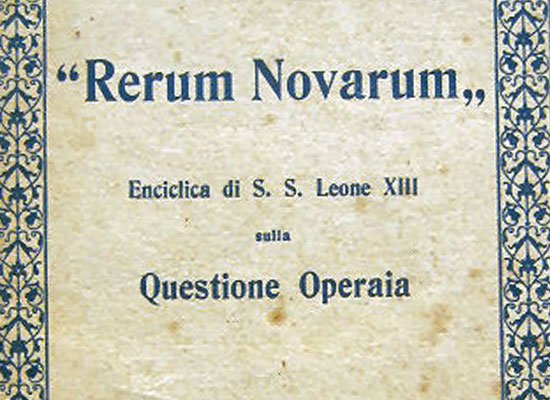
Fonte: Fabrizio Pezzani
L’elezione di un Pontefice porta sempre uno sguardo al passato ed alla storia perché la scelta del nome , nel caso quello di Leone XIV, ci porta a legare questo nome al suo predecessore Leone XIII per capire la continuità storica ed il legame che si crea tra il magistero del primo che viene richiamato dal secondo , questo ci porta alla lettura di un filo rosso e del quadro storico che legano nella storia i fatti e le vicende che vengono richiamate.
Leone XIII è stato il 256 vescovo di Roma e papa dal 1878 al 1903 , è ricordato come il papa delle encicliche che contribuirono a superare la perdita del potere temporale finito con l’affermazione del regno d’Italia.
La sua più famosa enciclica “Rerum Novarum” con la quale si realizzò una svolta nella Chiesa Cattolica, ormai pronta ad affrontare le sfide della modernità come guida spirituale internazionale. In questo senso correttamente gli fu attribuito il nome di «papa dei lavoratori» e di «papa sociale»: infatti scrisse la prima enciclica esplicitamente sociale nella storia della Chiesa cattolica e formulò quindi i fondamenti della moderna dottrina sociale della Chiesa .
Il tempo di Leone XIII è caratterizzato dalle conseguenze della rivoluzione industriale che all’inizio del secolo cambiò radicalmente il sistema economico dall’agricoltura all’industria e la connotazione dei sistemi sociali dando luogo alla lotta di classe tra il capitalismo e la forza lavoro salariata e sfruttata . In quel secolo Marx con Engels scrisse nel 1848 il “ Manifesto del partito comunista “ e nel 1867 pubblicò il primo volume de “ Il capitale “. A fronte degli scontri feroci tra capitale e lavoro la “ Rerum Novarum “ pose per la prima volta il problema dell’uguaglianza e della divisione dei risultati della produzione economica ; in quegli anni l’economia prese un ruolo determinante nell’evoluzione sociale e nel disegno dei sistemi sociali.
Tra le prime tesi dell’enciclica, vi è una critica netta al socialismo dell’epoca, accusato di voler abolire la proprietà privata e distruggere l’ordine sociale. Leone XIII difende invece il diritto naturale alla proprietà, considerandolo un’estensione del lavoro umano e del dovere dell’uomo di provvedere a sé e alla propria famiglia. La proprietà, secondo il Papa, non è solo un diritto economico, ma una condizione per la libertà e la responsabilità personale.
L’enciclica riafferma anche il primato della famiglia sulla società civile: essa precede lo Stato, ha poteri e diritti propri, e deve essere sostenuta, non ostacolata, dalle istituzioni.
È un grave errore considerare le classi sociali come nemiche per natura infatti il capitale ed il lavoro sono interdipendenti. Gli operai devono lavorare con fedeltà e senza violenza; i datori di lavoro devono rispettare la dignità umana, evitare lo sfruttamento e garantire il tempo per i doveri religiosi. Soprattutto, devono pagare un giusto salario, ricordando che defraudare i lavoratori è un peccato gravissimo. Anche i piccoli risparmi degli operai vanno tutelati. Con questa enciclica Papa Leone XIII entra di fatto nel tema che avrebbe caratterizzato i modelli di sviluppo del nuovo secolo mettendo al centro della discussione la lotta alla disuguaglianza e il diritto al lavoro.
Il secolo successivo fu caratterizzato dalle guerre che segnarono la fine delle monarchie e dei sistemi autoritari fascista e nazista ma anche dall’affermazione della rivoluzione del socialismo reale- comunismo nell’ottobre del 1917 . Il modello comunista ateo e materialista sarebbe stato combattuto dai pontefici del secolo fino all’arrivo di Giovanni Paolo II nel 1978 primo papa non italiano dopo 455 anni . La posizione di Giovanni Paolo II fu di forte scontro con il regime comunista sovietico e si adoperò per la favorire la lotta di “ Solidarnosc “ per la libertà . Il Papa vide cadere il regime comunista nel 1989 come risultato di uno scontro con i sistemi occidentali e nel 1991 a cent’anni dalla “ Rerum Novarum “ pubblicò come richiamo a quei principi l’enciclica “Centesimus Annus “in cui richiama i principi dell’economia e dei sistemi economici allargando i temi della precedente enciclica con un forte accento sulla disuguaglianza , la ricerca del bene comune ed una forte critica ai regimi collettivisti a confronto con i regimi di mercato che sembravano indicare la nuova strada da seguire con molte incertezze e problemi che l’enciclica mette in evidenza.
Quello che il Papa descrive è senza ombra di dubbio il capitalismo, con i suoi aspetti positivi ma anche con quelli negativi.
Un primo aspetto negativo presentato nell'Enciclica è inerente al carattere competitivo, e perciò duramente selettivo, di questo dinamismo economico fondato sul mercato. Il mercato, che ha ormai assunto dimensioni planetarie, dà luogo, proprio per la competitività che lo muove, a una situazione paradossale, in cui al suo dominio nessun paese può realmente sottrarsi, proprio mentre molte persone e nazioni non riescono a inserirvisi in maniera attiva e degna.
Il Papa non esita a parlare, a proposito del mercato, di «spietatezza» di una situazione che non ha nulla da invidiare a quella dei momenti più bui della prima fase industriale. Così, mentre da una parte l'Enciclica riconosce che il libero mercato «sembra essere Io strumento più efficace per collocare le risorse e rispondere efficacemente ai bisogni» , ma crea diversità profonde tra i diversi paesi.
Ma l’enciclica è costretta a richiamare, con la Rerum Novarum, l'urgenza di una giustizia degli scambi che vada al di là della tradizionale «aequalitas rei ad rem», per fondarsi sulle impreteribili esigenze della dignità di ogni uomo . Anche a proposito del profitto, l'Enciclica avverte che esso «non è l'unico indice delle condizioni dell'azienda. È possibile che i conti economici siano in ordine e insieme che gli ultimi, che costituiscono il patrimonio più prezioso dell'azienda, siano umiliati e offesi nella loro dignità. l'Enciclica .
Papa Giovanni Paolo secondo non vede i prodromi della rivoluzione finanziaria che di fatto inizia nel 1991 esattamente nello stesso anno dell’enciclica quando l’Accademia di Svezia assegna il primo premio Nobel alla finanza a Markovitz per gli studi pionieristici nel campo della finanza che da quel momento avrebbe radicalmente cambiato i sistemi economici e la distribuzione della ricchezza con una concentrazione della stessa senza pari nella storia dell’uomo .
I conti con la finanza ed i suoi dettati e conseguenze avrebbero indicato i problemi ai due Pontefici che seguirono Benedetto XVI che con l’enciclica “Caritas in veritate” approfondisce i diversi aspetti del rapporto tra carità, verità ed economia.
Il testo, inoltre, critica l’idea di un’economia completamente autonoma e mette in luce come l’abuso dello strumento economico abbia compromesso la giustizia sociale, alimentando la sfiducia negli individui verso i sistemi economici. La speranza cristiana, secondo l’enciclica, è diventata debole e incapace di orientare le azioni umane. La “carità nella verità” viene proposta come forza unificante per creare comunità, ma essa non può assicurare la fraternità senza un fondamento etico.
A questa Francesco si collegherà con l’enciclica “ Laudato si “ emessa nel 2015 in cui condanna formalmente i sistemi finanziari e la globalizzazione che crea più disordine economico e morale.
Le povertà, la disuguaglianza, l’emarginazione, la disoccupazione, il degrado morale, la sofferenza sono diventati non più problemi da affrontare nel rispetto dei diritti universali dell’uomo sottoscritti da tutte le nazioni nel 1947 alla fine della seconda guerra mondiale in occasione della costituzione dell’Onu, ma solo “danni collaterali” ad un disegno di realizzazione egemonica di pochi rispetto ai tanti.
Siamo diventati una società “totalmente” asimmetrica a quella disegnata e sperata in quegli anni di rinascita del mondo al senso ed al valore della vita umana. L’asimmetria che si evidenzia nel collasso sociale è l’espressione di un modello socioculturale fallito e che la crisi che stiamo affrontando è di natura antropologica e culturale; in questo senso l’enciclica parla di “rivoluzione culturale” come necessità di cambio di un paradigma che non è più in grado di rispondere alle domande ed ai problemi che dobbiamo affrontare.
Così Leone XIV si trova ad affrontare la estremizzazione dei problemi segnati dai Pontefici che lo hanno preceduto e le conseguenze di un sistema sociale che ha perso i legami con la religione e la desacralizzazione dell’Europa ne è il tragico esempio ; trova un mondo in guerra con i nazionalismi imperanti e scapito di quello tanto dimenticato che è il bene comune .
E’ un americano per la prima volta gli Usa hanno un personaggio religioso in cui identificarsi e non più solo figure militari e politiche , il suo Pontificato affronta temi e problemi enormi ma la ricerca della pace e dell’uguaglianza sono una tappa fondamentale per riprendere la saggezza dei pontefici che l’hanno preceduto.

