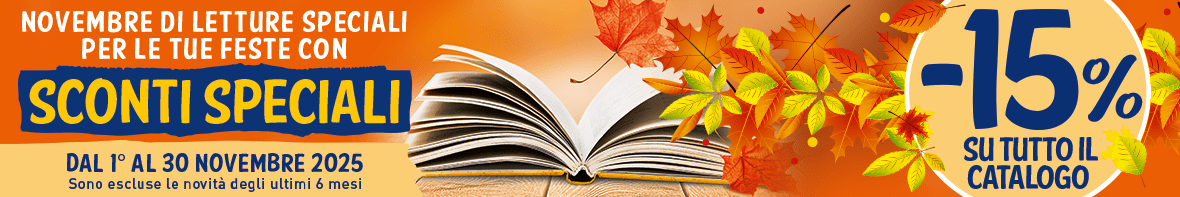Il moderato capitalismo di Marine Le Pen e il keynesismo che verrà…
di Umberto Bianchi - 01/05/2014
 Crediamo di non sbagliare se, guardando al risultato conseguito dal Front National della Marine Le Pen alle elezioni amministrative in Francia, possiamo tranquillamente affermare che questo è il primo, forte segnale di una profonda inversione di tendenza che, ben presto, toccherà l’intero Vecchio Continente e che poi andrà, via via, espandendosi in tutto il mondo. Il malcontento per le istituzioni europee o euroscetticismo, al pari del profondo disagio sociale determinato da una perdurante crisi economica, nascondono in verità una realtà ben più gravida di conseguenze di questi fenomeni. Il liberismo economico, il capitalismo, nella sua più intima aspirazione di voler demandare ai privati la gestione ed il pieno possesso di tutti gli aspetti della realtà, hanno clamorosamente fallito. Nonostante il Front National non sia esplicitamente anti capitalista, anzi, il ritorno alla Nazione, intesa come Koinè di intenti, aspirazioni ed istanze, porta ad una necessaria rivisitazione dei paradigmi socio economici che hanno caratterizzato l’Europa (ed il mondo intero,sic!) negli ultimi decenni. La maggior fluttuazione valutaria, assieme all’allentamento dei vincoli che regolavano gli scambi commerciali internazionali, promosse dal governo Nixon, sancirono la fine degli accordi di Bretton Woods e determinando decenni di continua instabilità economica, fecero da battistrada all’avvento del turbo capitalismo ed alla Globalizzazione degli scambi, della circolazione dei capitali, delle persone ed anche di certe malsane idee…Ora, il mito di una crescita economica senza fine, il sogno di un inarrestabile progresso, si è andato ad incagliare definitivamente, su una realtà sempre più caratterizzata da momenti di euforia delle varie economie, accompagnati da brusche crisi e ricadute, determinate dalla progressiva volubilità dei mercati finanziari.
Crediamo di non sbagliare se, guardando al risultato conseguito dal Front National della Marine Le Pen alle elezioni amministrative in Francia, possiamo tranquillamente affermare che questo è il primo, forte segnale di una profonda inversione di tendenza che, ben presto, toccherà l’intero Vecchio Continente e che poi andrà, via via, espandendosi in tutto il mondo. Il malcontento per le istituzioni europee o euroscetticismo, al pari del profondo disagio sociale determinato da una perdurante crisi economica, nascondono in verità una realtà ben più gravida di conseguenze di questi fenomeni. Il liberismo economico, il capitalismo, nella sua più intima aspirazione di voler demandare ai privati la gestione ed il pieno possesso di tutti gli aspetti della realtà, hanno clamorosamente fallito. Nonostante il Front National non sia esplicitamente anti capitalista, anzi, il ritorno alla Nazione, intesa come Koinè di intenti, aspirazioni ed istanze, porta ad una necessaria rivisitazione dei paradigmi socio economici che hanno caratterizzato l’Europa (ed il mondo intero,sic!) negli ultimi decenni. La maggior fluttuazione valutaria, assieme all’allentamento dei vincoli che regolavano gli scambi commerciali internazionali, promosse dal governo Nixon, sancirono la fine degli accordi di Bretton Woods e determinando decenni di continua instabilità economica, fecero da battistrada all’avvento del turbo capitalismo ed alla Globalizzazione degli scambi, della circolazione dei capitali, delle persone ed anche di certe malsane idee…Ora, il mito di una crescita economica senza fine, il sogno di un inarrestabile progresso, si è andato ad incagliare definitivamente, su una realtà sempre più caratterizzata da momenti di euforia delle varie economie, accompagnati da brusche crisi e ricadute, determinate dalla progressiva volubilità dei mercati finanziari.
Quella del 2008 si è rivelata poi essere la madre di tutte le crisi, avendo assunto una natura strettamente sistemica, ovverosia non occasionale, ma strettamente insita a questa fase del sistema capitalistico stesso, gettando pertanto la maschera sulla natura di quest’ultimo. In Italia, oggi, si fa un gran parlare di crisi, di Pil, di spread. Ogni anno sembra quello buono ed invece nulla; la crisi è là che morde come e più di prima. Le cifre da prefisso telefonico che danno corpo ai timori generati dalla crisi, non lasciano scampo: l’Italia vive una fase di recessione sinora mai vista. Non facciamo più parte del G8, almeno per quanto riguarda il Pil. Quando nel 2014 l’Italia sarà di turno alla presidenza dell’Unione europea, continuerà a partecipare al G8 senza più essere fra i primi otto grandi paesi industrializzati. Vi rimarrà solo per una consolidata convenzione, legata alle precedenti “performances”, ma sicuramente non per gli attuali risultati. Superato dalla Cina nel 2000 e dal Brasile nel 2010, quest’anno il nostro paese subisce un ulteriore sorpasso da parte della Russia, calando così al nono posto per Pil, superato di 50 miliardi di dollari alla fine del 2013.
A dar retta ad alcuni recenti dati del Fondo monetario, dal 1980 la Cina è cresciuta di 29 volte, l’India di 9, gli Stati Uniti di 5,8. Il tutto mentre l’Italia, in buona compagnia di altri paesi europei come Germania, Francia e Gran Bretagna, negli ultimi 40 anni, avrebbe vissuto una crescita economica, moltiplicata solamente per quattro. Sempre a sentire la stessa fonte, fra non oltre cinque anni l’Italia sarebbe fuori anche dai primi dieci posti , superata da Canada e India e relegata all’undicesimo posto, per il quale oggi competono Spagna e Corea. Ad onor del vero, però, certi dati statistici andrebbero letti ed interpretati con molta attenzione (specialmente se si tratta di dati FMI, sic!). Il fatto che determinati paesi, (un tempo considerati “sottosviluppati” o comunque affetti da gravi difficoltà strutturali) in un tempo relativamente breve, stiano ottenendo delle “performances” economiche ad oggi impensabili in Europa, non significa né comporta il raggiungimento di quegli standard di benessere medio, inteso come aspettative di vita, reddito pro capite, consumi, etc., riscontrabili tuttora in paesi come Europa Occidentale, USA, Canada, Giappone e qualcun altro. A dimostrazione di quanto qui detto, il dato di fatto che, con tutta la crisi economica, questi paesi sono tuttora oggetto di una massiccia immigrazione proveniente proprio da quelle cosiddette ”emergenti” realtà.
Non solo. La Globalizzazione avviluppa tutti i soggetti geoeconomici del pianeta (sia a livello di singole nazioni, che di veri e propri blocchi sovranazionali) in una vera e propria tela di interconnessioni, per cui qualunque epifenomeno di natura politica o economica o finanziaria che dir si voglia, finisce con il produrre effetti su tutte le realtà circostanti, in virtù di un vero e proprio effetto “domino”. Gli effetti dell’attuale crisi, pertanto, si stanno cominciando a far sentire anche in questi paesi. Il calo del potere d’acquisto in Occidente, implica una diminuzione del fatturato delle esportazioni di questi paesi. La necessità di stimolare i propri consumi interni, sia in virtù di una legge economica di reciprocità con le altre realtà economiche mondiali, sia per sopperire agli effetti della crisi che colpisce i consumi dei paesi occidentali, portano giuocoforza ad un aumento del costo del lavoro e ad un rallentamento dei livelli di crescita. Il tutto, senza voler contare che certi “trend” di crescita sono per lo più gonfiati dalla speculazione finanziaria internazionale, mirante ad ottenere risultati strabilianti in breve tempo, attraverso il disinvolto utilizzo del credito pubblico e privato o di strumenti finanziari “sporchi” (junk bonds, mutui “subprime, etc.), che determinano una crescita drogata, solo al fine del conseguimento di un risultato statistico, senza però alcun rilevante incremento infrastrutturale. Al primo cenno di crisi, la speculazione abbandona al proprio destino queste realtà, che finiscono con il ritrovarsi con gli stessi, irresoluti, problemi di sempre. Il caso del Brasile e delle sue recenti rivolte sociali, è emblematico di quanto qui affermato.
Per quanto riguarda il contesto europeo ed italiano, invece, la cronicizzazione della crisi è dovuta sicuramente ai fatti di cui abbiamo parlato, a cui vanno aggiunti alcuni peculiari elementi, di non trascurabile entità. La delocalizzazione, anzitutto, ha stravolto i già precari equilibri dell’economia nostrana, consentendo di trasferire interi comparti produttivi italiani, in realtà quali Polonia, Serbia, Thailandia, etc., il cui costo di lavoro, a tutt’oggi, risulta essere più basso del nostro, generando una crisi occupazionale senza precedenti. L’abolizione dei dazi, che ha permesso l’invasione dei nostri mercati da parte di merci e manufatti prodotti a basso costo in quei paesi il cui costo del lavoro, è più basso del nostro (Cina, etc.). La mancanza di quelle barriere protettive erette a difesa delle varie economie nazionali e che una volta non permettevano l’ingresso, o addirittura l’acquisto indiscriminato di intere aziende, da parte di soggetti esteri. La finanziarizzazione delle economie, attraverso l’abolizione di tutte quelle norme che, come la “Legge Steagall” (che proibiva la fusione tra banche d’affari e banche di risparmio, sic!) o quelle che proibivano le “trust” tra banche ed assicurazioni o tra mega istituti bancari, regolavano o, quanto meno, arginavano in parte lo strapotere delle banche. L’immigrazione, ovverosia la progressiva sostituzione e frantumazione delle classi lavoratrici di un paese, a favore di elementi allogeni, disponibili a lavorare a costi molto più bassi dei locali. L’incartamento delle dinamiche sociali e produttive in una forma di satrapia burocratica (da alcuni mentecatti spacciata quale “socialismo”), che crea delle vere e proprie zone franche, improduttive, al cui bacino elettorale attinge un potere politico oramai arroccato sulle proprie posizioni, anche se, con estrema malizia ed astuzia, finge di volersi auto rinnovare.
Di fronte a questo scenario, l’elezione di Marine Le Pen in Francia, rappresenta un primo ed importante segnale di rottura con la precedente tradizione di “moderatismo” europeista, espressa dai finti binomi destra-sinistra o conservatori-progressisti. Riportando l’attenzione sulla Koinè/Comunità come viva espressione del carattere e delle aspirazioni di un popolo, si finisce giuocoforza con il rimettere in discussione un’idea di economia (e pertanto del capitalismo!) che sinora sembrava andare per la maggiore. Allora, prepotente ritorna quella domanda che, come un silenzioso tarlo, sembra corrodere le coscienze di tutti, ma a cui nessuno vuole e osa rispondere: quale modello economico, per il travagliato 21° secolo? Vuoi vedere che ci tocca rivalutare il vecchio Marx, sebbene su di lui se ne siano dette di cotte e di crude? Un fatto è certo: una Francia lepenista potrebbe far tornare quanto meno indietro di molti anni, l’orologio delle scelte economiche del Vecchio Continente, proprio in nome di quella strettissima interrelazione tra le situazioni, che caratterizza l’attuale contesto globale e che, pertanto, rende molto più intrinsecamente fragili, scelte ed equilibri.
A tal proposito, c’è un fantasma che si aggira tra i responsabili delle politiche economiche del Vecchio Continente ed è quello di J.M.Keynes. Rassicurante ma anche denso di incognite. Incognite rappresentate dai risultati poco confortanti che decenni di keynesismo, applicati in chiave burocratica, hanno portato un po’ ovunque. Smisurata crescita del debito pubblico, stagnazione, stagflazione, inflazione e poi, infine, la folle corsa a liberarsi della sempre più ingombrante presenza di un settore pubblico, oramai divenuto la fonte primaria di un debito infinito. E allora tutti giù a privatizzare, svendere, come ossessi. La parola “stato” o “pubblico” sembrava equivalere ad una bestemmia. E poi, privatizzare corrispondeva a sanare. E poi la delusione, grande. La scoperta che un capitalismo decadente per andar avanti ha bisogno del debito, alimentato e sostenuto da rendite puramente finanziarie. E giù, quindi, a crear titoli dal nulla. Quel nulla che tutto si riprenderà, spazzando via speranze, aspettative, guadagni, in un crescendo di crisi da cui, tutt’ora, non si vede via d’uscita. Sì, questa è la storia in breve delle vicende legate al keynesismo ed alle sue distorte applicazioni.
Resta, comunque, la considerazione che, il fallimento del liberismo, riporterà i governanti europei a considerare, quanto meno, il ritorno ad un keynesismo, seppur di maniera. Ed è a questo punto che, per tutti coloro che intendono porsi su una linea di netto antagonismo rispetto al dominante “status quo”, porsi il non più rinviabile quesito su quali possano essere le modalità e le forme per dar luogo ad un socialismo del 21° secolo. Un socialismo che possa da fungere da valido bastione e contraltare alla micidiale capacità di adattamento dell’attuale capitalismo. Ma a quale socialismo fare riferimento? A quello marxiano per caso? O forse a quello di Proudhon o, ancor meglio, a quello dei piani quinquennali? Non sarà meglio quello delle socialdemocrazie europee? O forse quello del totalitarismo fascista? O non sarà che le forme-pensiero in cui si sono espresse le grandi narrazioni ideologiche del Novecento (marxismo e fascismo, sic!) oggi potrebbero essere inattuali o, quanto meno, invalidate da non indifferenti vizi di forma, che ne renderebbero problematica un’applicazione “tout court”?
Di fronte a tutte queste tematiche, il “populismo” della Marine Le Pen, sebbene possa ispirare un’istintiva simpatia, non è sufficiente. Se non accompagnato da una più incisiva azione di dibattito e chiarimento programmatico, in Francia come nel resto d’Europa, rischia di trasformarsi nell’inconsapevole veicolo di un keynesismo addomesticato alle esigenze di un capitalismo, a cui altro non rimane che tornare ad affidarsi ad iniezioni di denaro pubblico. Prova ne sia, che il programma economico della Le Pen è, per ora, impostato su un moderato liberalismo. L’uscita dall’Euro o dalla stessa Comunità Europea, potrebbero non rivelarsi assolutamente sufficienti, senza una chiara idea su dove e cosa andare a toccare. Nazionalizzare le attività economiche strategiche, industriali e finanziarie, banche centrali in primis, estromettendo i privati dal processo di emissione del denaro, agevolando, invece, tutte le forme di azionariato diffuso, di piccola impresa o di struttura economica cooperativistica. Rimettere in discussione ed annullare gli accordi frutto del WTO. Tornare alla piena sovranità economica (possibilità di fare bilancio, svalutare la propria valuta nazionale, etc.). Di fronte alla saturazione del processo di industrializzazione o di creazione di infrastrutture, puntare al rinnovo ed all’ottimizzazione di queste. Fare un uso (questo sì!) “keynesiano” del denaro pubblico, creando milioni posti di lavoro nel settore dell’ambiente, il cui livello di degrado (specialmente in Italia!) dovrà essere oggetto di un immane lavoro di messa in sicurezza, ristrutturazione e rivalorizzazione, che potrebbe coinvolgere una forza lavoro quantificabile in milioni e milioni di braccia. In conclusione, fare dell’Europa una Comunità di Stati Indipendenti (e non l’espressione di un circo equestre legato al carrozzone degli USA) estesa alla Russia e contrapposta all’arrogante espansionismo mercantilista degli atlantici, all’insegna di una nuova etica comunitaria. Questi obiettivi di massima, sono imprescindibili per chi, oggidì, voglia svolgere un’azione di intelligente contrasto all’avvento della dittatura globale. E queste prossime elezioni europee potrebbero (il condizionale è d’obbligo!), rappresentare l’occasione giusta per far affiorare a livello macropolitico, nuove e più radicali istanze. L’importante è, però, non confondere i gattopardi in cerca di nuove legittimazioni politiche, con i sinceri antagonisti. Un po’ come coloro che scambiano papponi, spacciatori e criminali comuni ucraini sovvenzionati dagli USA,( unicamente ed esclusivamente in funzione anti-russa) per dei sinceri ed onesti idealisti…