Globalizzazione carceraria. L’esplosione del carcere negli Stati Uniti e in Europa
di Danilo Zolo - 15/02/2007
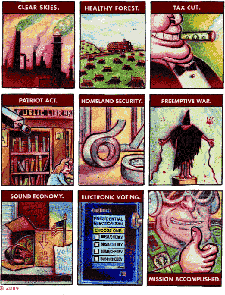 Oggi si parla sempre di più di lavoro precario e di conseguente incertezza delle condizioni materiali di vita. Si parla anche di indebolimento, di ritiro dello stato sociale. Ma le analisi svolte sulle politiche neoliberiste, di cui gli USA sono il primo e più influente laboratorio, mostrano piuttosto un mutamento di funzione dello stato che una sua semplice latitanza. Lo stato ritorna, ma per gestire la criminalizzazione della miseria fisica e psichica delle persone. La “guerra globale” verso i possibili nemici esterni si accompagna ad una guerra verso i nemici interni: eserciti sempre crescenti di perdenti ed esclusi, che bisogna letteralmente “rendere invisibili”. A. I.
Oggi si parla sempre di più di lavoro precario e di conseguente incertezza delle condizioni materiali di vita. Si parla anche di indebolimento, di ritiro dello stato sociale. Ma le analisi svolte sulle politiche neoliberiste, di cui gli USA sono il primo e più influente laboratorio, mostrano piuttosto un mutamento di funzione dello stato che una sua semplice latitanza. Lo stato ritorna, ma per gestire la criminalizzazione della miseria fisica e psichica delle persone. La “guerra globale” verso i possibili nemici esterni si accompagna ad una guerra verso i nemici interni: eserciti sempre crescenti di perdenti ed esclusi, che bisogna letteralmente “rendere invisibili”. A. I.
Gli Stati occidentali mostrano i muscoli quando si tratta di imporre ai cittadini le regole di un ordine pubblico sempre più rigido.
Lo fanno all’insegna dell’ideologia penale della Zero tolerance, che si è affermata negli Stati Uniti e che la deriva della globalizzazione ha poi rapidamente diffuso in molti paesi occidentali. Oggetto di un minuzioso controllo del territorio e di una repressione inflessibile sono i comportamenti devianti, anche di lievissima entità, dei soggetti marginali che non si adeguano ai modelli del conformismo sociale.
Un caso esemplare di questo fenomeno è rappresentato dalle politiche penali e penitenziarie praticate negli Stati Uniti nell’ultimo ventennio. Questa è la tesi che Lucia Re sostiene e documenta in Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa (Laterza 2006, pp. 212). Anche in questo settore l’esempio statunitense svolge un ruolo paradigmatico, cosicché la Gran Bretagna e poi gradualmente altri paesi europei, l’Italia compresa, si stanno adeguando all’ideologia penale della ‘tolleranza zero’ e sono coinvolti in un trend di rapido aumento della popolazione carceraria. In Italia in pochi anni siamo passati da una media stabile di 40-45 mila detenuti ai 56 mila degli inizi del 2005. E questa tendenza è presente in tutti gli altri principali paesi europei, e in particolare in Gran Bretagna, dove in dieci anni si è passati da 50 mila a 76 mila detenuti.
Oggi gli Stati Uniti godono di un primato planetario. A partire dal 1980 la popolazione penitenziaria si è più che triplicata, raggiungendo a metà del 2004 la cifra di 2.130.000 detenuti. Il tasso di detenzione è di gran lunga il più alto del mondo: 726 cittadini incarcerati ogni 100.000, sette volte più che in Italia. Questi dati appaiono tanto più rilevanti se si considera che negli Stati Uniti i detenuti sono soltanto un terzo della popolazione soggetta a sanzioni penali. Ci sono infatti oltre quattro milioni di cittadini sottoposti alle misure alternative della probation e della parole, e questo porta a circa sei milioni e mezzo le persone che subiscono una qualche forma di trattamento penale.
Queste cifre mostrano come ai processi di globalizzazione corrisponda negli Stati Uniti e nella maggioranza dei paesi occidentali una trasformazione non solo delle politiche penali ma delle stesse funzioni dello Stato. Il controllo sociale è divenuto la funzione centrale assegnata dai processi di globalizzazione alle autorità politiche degli Stati, e il controllo viene praticato come repressione poliziesca nei confronti degli appartenenti a categorie sociali considerate statisticamente devianti. E occorre sottolineare il fatto, come Lucia Re suggerisce, che non esiste alcun rapporto sicuro fra l’espansione della popolazione carceraria e l’aumento della criminalità. Negli Stati Uniti, in particolare, la comparazione fra i tassi di criminalità e l’applicazione di misure penali ispirate all’ideologia della “tolleranza zero” non dà alcun risultato persuasivo.
In realtà l’amministrazione penitenziaria tende a occupare gli spazi lasciati liberi dalla smobilitazione istituzionale di ampi settori della vita politica, sociale ed economica del Welfare State. Si tratta di un drastico passaggio da una concezione “positiva” della sicurezza - come prevenzione collettiva dei rischi e come solidarietà sociale - ad una concezione “negativa” della sicurezza, intesa come tutela poliziesca dell’incolumità individuale. Secondo Loïc Wacquant la deregolamentazione economica e l’iper regolazione penale vanno di pari passo: il disinvestimento sociale suppone e provoca il sovra-investimento carcerario, che è l’unico strumento in grado far fronte ai conflitti causati dalla demolizione dello Stato sociale e dall’insicurezza materiale che si diffonde negli strati inferiori della piramide sociale.
(Loïc Wacquant, sociologo e antropologo, è l’autore di uno studio fondamentale intitolato Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Agone, Marseilles 2004.)
A tutto questo occorre aggiungere che negli Stati Uniti è in corso la tendenza alla privatizzazione del carcere. E’ il cosiddetto correctional business, il cui volume di affari ha segnato una crescita esponenziale e la cui struttura ha assunto le caratteristiche di una “multinazionale delle sbarre”, diffondendosi in paesi come la Gran Bretagna, l’Australia, Israele e il Cile. Negli Stati Uniti, in un numero crescente di istituti penitenziari privati, molti dei quali quotati in borsa, è oggi rinchiusa una popolazione di oltre trecentomila detenuti, pari a circa un quinto della popolazione carceraria globale. La logica di questa impresa economica è ovviamente il profitto e questo incide in misura rilevante sulla qualità del trattamento carcerario: è ormai del tutto abbandonato il modello del carcere come luogo di “rieducazione” e di socializzazione, e non solo di segregazione e di limitazione della libertà.
Del resto questo modello è oggi in crisi, come sostiene Lucia Re, in tutto il mondo occidentale. Le ragioni principali sono il sovraffollamento degli stabilimenti, l’assenza di personale competente, la scarsità di risorse dedicate alle attività socializzanti, la paralisi delle attività lavorative. In Italia, ad esempio, i reclusi, stipati in celle anguste, sporche, fatiscenti, non riscaldate e male illuminate, dispongono mediamente di non più di due o tre metri quadrati a testa. Spesso sono costretti a conservare i propri indumenti e oggetti personali in scatole di cartone disposte sul pavimento. E sul pavimento sono sistemati i materassi sui quali dormono. Le attività collettive sono scarse, le relazioni con l’ambiente esterno sono difficoltose, mentre la comunicazione fra il personale penitenziario e i detenuti stranieri è impedita dall’assenza di conoscenze linguistiche o di interpreti. Pesanti sono in particolare le condizioni di vita dei malati di Aids, dei tossicodipendenti e degli stranieri extracomunitari. Una componente afflittiva non trascurabile è l’astinenza sessuale: essa è fonte di violenza, di distorsioni psico-sessuali, della pratica a lungo andare avvilente e debilitante dell’auto-erotismo. Se si aggiungono lo squallore degli ambienti, la cattiva qualità del cibo e la difficoltà ad essere curati fisicamente, si capisce perché nelle carceri italiane (ed europee) é in crescita costante il tasso dell’autolesionismo, del tentato suicidio e del suicidio.
Si può dunque concludere. assieme a Lucia Re, che negli Stati Uniti come in Europa l’istituzione carceraria è imputabile di una duplice irrazionalità: è irrazionale non solo rispetto al fine rieducativo, ma anche rispetto al controllo della devianza e della garanzia dell’ordine pubblico. Il carcere è semplicemente un luogo di afflizione - talora di vera e propria tortura fisica e psichica - e di violazione dei diritti dei cittadini reclusi. Esso opera come un luogo di autoidentificazione differenziale e di professionalizzazione del detenuto: alimenta subculture della devianza, assegna identità incancellabili a chi vi mette piede anche per poco tempo. A ciò si aggiunge il suo carattere iniquo dal punto di vista della composizione sociale, poiché la prigione, oggi come ieri, resta un luogo riservato essenzialmente agli strati più deboli e poveri della società.
Il diffuso fervore giustizialista che oggi esalta le virtù terapeutiche del carcere (e persino della pena di morte) e plaude alle politiche repressive della “tolleranza zero” non corrisponde affatto ad una richiesta di razionalizzazione del trattamento della devianza. Al contrario, al fondo di tutto questo ci sono nuove insicurezze e nuove, impellenti richieste di protezione. Accanto a estesi processi di emarginazione sociale, di discriminazione razziale e di impoverimento collettivo, ci sono paure irrazionali che riemergono in un mondo meno semplificato dalle ideologie e dalle credenze religiose e, nello stesso tempo, più complesso, turbolento e diviso: il mondo di Guantanamo, di Abu Ghraib e della globalizzazione carceraria.
* (Apparso in versione ridotta in il Manifesto, 30 marzo 2006. Tratto dal sito Jura Gentium.)
(Immagine di Peter Kuper “Successful mission”)
