Foliis ac frondibus
di Francesco Lamendola - 21/09/2012
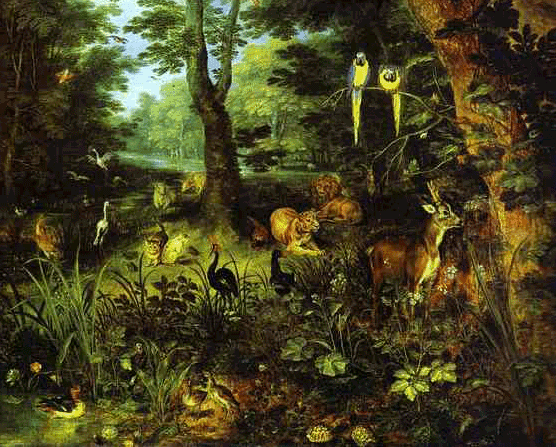
Il verde privato è un aspetto importante del volto delle nostre città; anche se non può essere goduto dalla cittadinanza, la sua sola vista, per quel tanto che ne traspare da dietro i cancelli e le recinzioni, già costituisce una festa per gli occhi; la sua ombra rinfresca il cammino, d’estate, anche sulla strada pubblica; il suo profumo si spande oltre muri e reti metalliche; il canto delizioso e il gorgheggio degli uccelli che vi fanno il nido, i loro voli nell’aria del mattino e della sera, sono un bene di tutti; e così pure il frinire delle cicale e dei grilli, il volteggiare delle farfalle multicolori, lo sbocciare dei fiori, il volteggiare delle foglie autunnali che formano un meraviglioso tappeto anche sui vicini marciapiedi.
Chiunque può godere di quei beni immateriali, a cominciare dall’abitatore dei piccoli e anonimi appartamenti dei palazzoni di periferia; chiunque, ad esempio, con un po’ di fantasia e di senso estetico, può chinarsi a raccogliere le foglie più belle e colorate di ippocastano, di platano, di acero, di tiglio, metterle sotto pressa a seccare e infine incorniciarle, ricavandone dei vivacissimi quadretti da appendere, con i quali rallegrare la monotonia delle pareti di casa.
Questi sono i vantaggi per chi non ha la fortuna di possedere un giardino tutto suo, ma abita in una città che sia ricca di giardini privati, oltre che pubblici: questi ultimi, purtroppo, raramente sono ben tenuti e non per colpa delle amministrazioni comunali, ma della scarsa educazione e ancor più dello scarso senso civico dei cittadini. Basta percorrere i vialetti del giardino di una scuola pubblica: sotto gli occhi dei professori, i ragazzi gettano ovunque cartacce e rifiuti, sdegnando i pur numerosi cestini disseminati un po’ dappertutto; né i bidelli, a termini di contratto, fanno una piega. E così le testimonianze della scarsa civiltà ecologica degli studenti restano spiacevolmente allo scoperto, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana: tutti le vedono, ma nessuno abbassa la schiena per raccoglierne almeno una parte, almeno le bottiglie di plastica o le lattine di aranciata, almeno i sacchetti delle patatine fritte o dei crackers.
I giardini privati, almeno, sono in genere ben tenuti e, anche se il resto della cittadinanza può solo goderne da lontano, né i bambini dei quartieri-dormitorio possono entrare per giocarvi (senza scomodare alcuna forma di retorica populista, né il Gigante egoista della favola di Oscar Wilde o, peggio, la squadra di calcio dei ragazzi della Via Pál), tutto sommato, per le ragioni anzidette, li si può considerare un bene della comunità: un bene estetico, psicologico e spirituale, anche se non, ovviamente, un bene giuridico, essendo i loro proprietari liberissimi di farne ciò che vogliono, anche di distruggerli per fare posto a garage, posti-macchina o magari piscine.
Purtroppo, da diversi anni è dilagata la moda del giardino con il prato “all’inglese”, che esige un taglio frequente e sistematico dell’erba, ovviamente con le rumorosissime e super-inquinanti falciatrici elettriche, come se un giardino fosse tanto più bello, quanto più ridotto a una specie di fondale verde totalmente asettico, dove la presenza di un solo ciuffo di vegetazione spontanea farebbe gridare allo scandalo e quella, peraltro saltuaria, di un gatto randagio, farebbe addirittura scattare un allarme simile a quello per una minaccia alla sicurezza nazionale.
A parte ogni considerazione di carattere estetico, un tal modo di concepire il verde privato è l’esatto corrispondente della pretesa, anch’essa ormai largamente diffusa, di eliminare radicalmente ogni genere di virus e batteri dall’ambiente domestico, affinché, come recita la relativa pubblicità televisiva, i bambini siano liberi di giocare a terra o sui tappeti, senza dover rischiare di contrarre chissà quali spaventose malattie; non pensando, però, che un ambiente del genere, se pure è possibile, fa sì che l’organismo umano cresca sempre più povero di anticorpi e pertanto assai più esposto alle malattie di quanto non lo sarebbe se vivesse in un ambiente che non assomigli in maniera così impressionante all’interno di una campana di vetro.
Un ragionamento del tutto analogo va fatto per il giardino. Pur consapevoli degli inconvenienti che ciò comporta - il maggior carico di lavoro per chi lo accudisce, il fastidio delle ortiche, il richiamo per una certa quantità di insetti molesti -, noi siamo fermamente favorevoli a un giardino il più possibile naturale: con l’edera che cresce liberamente e che alquanto sfacciatamente si arrampica lungo i muri, con l’erba alta e gli arbusti che intrecciano i loro rami in un apparente disordine, con le foglie secche che giacciono al suolo finché non si siano decomposte, e ciò con grande vantaggio dell’humus che, altrimenti, finisce per impoverirsi al punto da dover richiedere l’impiego massiccio di fertilizzanti chimici, dagli effetti collaterali sempre più dannosi.
A noi, l’edera selvatica piace quando ha disegnato una tale trama sui balconi delle finestre, da rendere pressoché impossibile l’apertura delle imposte; quando gli aghi di pino hanno formato uno strato così alto sul terreno, che il piede, camminandoci sopra, vi affonda con tutta la scarpa; quando i grandi petali delle magnolie, cadendo, hanno quasi intasato la vasca della fontana con i cavallucci marini scolpiti, e spandono ovunque un odore così intenso di fiori in decomposizione, da rendere l’aria pesante di effluvi e fermenti. Anche l’orto è più bello, se incorniciato da una folta siepe di sempreverdi; e, se richiede un bel po’ di lavoro per essere liberato dalle erbe infestanti, in compenso rimane immune dai cosiddetti fitofarmaci, suoi grandi nemici e avvelenatori.
C’è una pagina, nei «Miserabili» di Victor Hugo, nella quale il grande scrittore francese si sofferma a descrivere uno di questi giardini inselvatichiti nel cuore della grande città, con tutto il loro fascino arcano e il loro senso di poesia e di mistero - nel libro primo della quarta parte -, che riportiamo nella traduzione del conte Carlo F. Siecond (Milano, Editrice Lucchi, 1954, pp, 314-15):
«Quel giardino, abbandonato così a se stesso da più di mezzo secolo, era divenuto straordinario e incantevole. Coloro che passavano di là circa una quarantina d’anni fa, si fermavano a contemplarlo senza punto sospettare i segreti che nascondeva dietro lo spessore delle fresche e verdi fronde. Più d’un pensatore a quell’epoca ha lasciato penetrare indiscretamente occhio e pensiero dietro le sbarre dell’antico cancello catenacciaro, torto, tremolante, sostenuto da due pilastri verdi e muscosi, bizzarramente coronato da un frontone d’arabeschi indecifrabili.
C’era un sedile di pietra in un angolo, una o due statue coperte di muffa, alcuni pergolati schiodati dal tempo che marcivano sul muro; del resto non c’erano più viali né zolle erbose, ma gramigna ovunque. Mancata l’arte del giardiniere era tornata la natura. Le cattive erbe vi abbondavano, avventura ammirevole per un povero angolo di terra. La festa delle viole vi era splendida. Nulla in quel giardino si opponeva allo sforzo sacro delle cose verso la vita; lo sviluppo venerabile ivi era in casa sua.
Gli alberi s’erano chinati verso rovi, i rovi si erano innalzati verso gli alberi, la pianta s’era arrampicata, il ramo s’era piegato, quello che striscia sulla terra era andato a visitare quello che si schiude nell’aria, quello che ondeggia al vento s’era chinato verso quello che si trascina nel musco; tronchi, rami, foglie, fibre ciuffi, viticci, sarmenti, spine s’erano mescolati, intrecciati, sposati, confusi; in uno stretto e profondo abbraccio, la vegetazione aveva celebrato e compiuto in quel piccolo recinto di trecento piedi quadrati, sotto lo sguardo soddisfatto del Creatore, il santo mistero della sua fratellanza umana?
Quel giardino non era più un giardino, era una colossale macchia; cioè qualcosa di impenetrabile come una foresta, popolato come una città, fremente come un nido, cupo come una cattedrale, odorante come un mazzo, solitario come una tomba, vivente come una folla.
In primavera quell’enorme sterpaglia libera dietro il cancello e fra quelle quattro mura,entrava in amore nel sordo lavorio della germinazione trasaliva al sol levante quasi come una bestia che aspira gli effluvi dell’amore cosmico e che sente il succo dell’aprile salire e bollire nelle vene; e scuotendo al vento la prodigiosa capigliatura verde, seminava sulla terra umida, sulle statue corrose, sul poggiuolo crollante del padiglione e sino sul selciato della via deserta, i fiori a stelle, la rugiada in perle, la fecondità, la bellezza, la vita, la gioia, i profumi. A mezzogiorno, mille farfalle bianche vi si rifugiavano, ed era uno spettacolo divino veder turbinare là in fiocchi, nell’ombra, quella neve vivente dell’estate. Là, in mezzo alle gaie tenebre della verdura, una folla di voci innocenti parlavano dolcemente all’anima, e il ronzio completava ciò che il cinguettio aveva dimenticato di dire. La sera, un vapore fantastico si sprigionava dal giardino e l’avvolgeva; un lenzuolo di bruma, una tristezza celeste e calma lo coprivano, l’odore così inebriante dei caprifogli e dei vilucchi usciva da ogni parte come un veleno squisito e sottile; si sentivano le ultime chiamate dei falcinelli e delle cutrottole che si adagiavano sotto i rami, vi si sentiva quell’intimità sacra dell’uccello e dell’albero, di giorno, le ali rallegravan le foglie, di notte le foglie proteggevano le ali.
D’inverno la sterpaglia era nera, bagnata, irta, fumante e lasciava veder poco la casa. Invece dei fiori nei rami e della rugiada nei fiori, si scorgevano le lunghe sbavature d’argento dei lumaconi sul freddo e spesso tappeto di foglie ingiallite; ma, in tutti i modo, sotto tutti gli aspetti, in ogni stagione, primavera, inverno, estate, autunno, quel piccolo recinto destava la malinconia, la contemplazione, la solitudine, la libertà, l’assenza dell’uomo, la presenza di Dio; e pareva che il vecchio cancello arrugginito dicesse. Questo giardino è mio.»
Certo, il giardino parigino di Jean Valjean in Via Plumet, scenario predestinato agli amori di Marius e Cosette, era stato volutamente trascurato dal nuovo padrone, per suggerire l’idea che la casa fosse disabitata; ciò non toglie che un giardino selvatico possiede un fascino che nessun giardino moderno e razionale, con l‘erba tagliata all’inglese, avrà mai.
Tutto dipende dalla filosofia che presiede alla creazione di un giardino privato di città: se lo si pensa, in omaggio alle teorie funzionaliste, come un prolungamento dello spazio artificiale della casa e della città stessa, come uno spazio, cioè, da controllare, dominare, possedere nel senso più completo del termine, allora è logico che lo si voglia organizzare in maniera che la comparsa di una lucertola o, Dio non voglia, di un ramarro, appaia come un vera e propria eresia, anzi come una bestemmia. In tale prospettiva rientra la pratica di pettinare col rastrello la ghiaia dei vialetti, di potare i rami degli alberi in modo da renderne più leggiadro l’aspetto, di condurre una lotta senza quartiere, a base di prodotti chimici, contro i parassiti delle piante.
Se, al contrario, lo si immagina come una finestra spalancata, entro i limiti del possibile, sul mondo della natura, allora una certa voluta trascuratezza delle apparenze, la crescita spontanea dell’erba, la scarsa o nulla raccolta delle foglie morte, saranno pratiche coerenti con l’obiettivo perseguito: quello di far sì che sia il padrone di casa, psicologicamente, ad immedesimarsi nei ritmi e nelle figure del mondo naturale e non quest’ultimo ad essere forzato, affinché assomigli sempre di più al paesaggio artificiale delle costruzioni umane.
È chiaro che, in base a tale scelta di fondo, si avrà un giardino vuoto e silenzioso, oppure un giardino festosamente risuonante di voci e brulicante di vita. Chi ama il controllo e la manipolazione degli enti non apprezza ciò che al controllo tende a sfuggire e poco si presta alla manipolazione; per amare un giardino il più possibile “naturale” è necessario abbandonare la presunzione dell’ego e il suo narcisismo, che vorrebbe vedere ovunque, anche nella realtà esterna, uno specchio o un riflesso di se stesso.
Ad esempio un provetto ornitologo, o anche un semplice appassionato di uccelli, in un giardino selvatico avrà mille occasioni per familiarizzarsi con le varie specie alate, per imparare a distinguere e riconoscere i loro versi, per apprendere qualcosa circa le loro abitudini. Ma oltre alla dimensione naturalistica, un giardino non troppo curato e leccato offre anche uno spazio tranquillo per la contemplazione disinteressata del bello, per la riflessione filosofica, per la meditazione spirituale: tutte cose che si possono fare, si capisce, in qualsiasi altro luogo, ma che sono agevolate dalla quiete, dal verde delle piante, dal cinguettio degli uccelli.
Del resto, il giardino che si possiede riflette lo stato dell’anima del suo proprietario. Un’anima equilibrata, saggia, distaccata e compassionevole non sente l’impulso incontenibile al dominio sulle cose, dunque è disposta a concedere ampi margini di autonomia alla crescita spontanea dei vegetali e si mostra tollerante con l’eventuale intrusione di piccoli ospiti inattesi, senza sentirsi sminuita o minacciata nel proprio bisogno compulsivo di sicurezza.
Un’anima equilibrata e pacificata ama il giardino spontaneo e si riflette in esso, serenamente e naturalmente: molte cose dicono di noi i nostri gusti estetici, anche riguardo a un semplice giardino.
