La Cina spiegata all'Occidente
di Pino Arlacchi - 12/10/2025
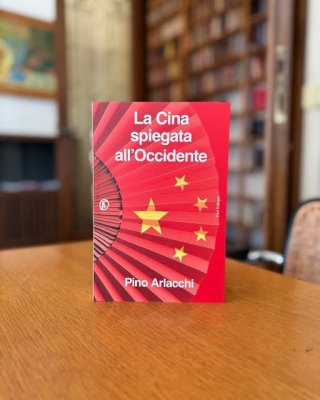
Fonte: Pino Arlacchi
Metto a disposizione dei miei lettori un testo tratto dal volume che ho appena pubblicato, e che tenta di spiegare le ragioni della rinascita della Cina come potenza mondiale non capitalistica ed alternativa all'impero americano che tramonta. Buona lettura!
Il ritorno della Cina in cima ai destini della terra è stato definito il più grande evento del nostro tempo, ma non è facile da spiegare, a meno che non si voglia chiudere subito il discorso dichiarando scontata la supremazia millenaria della sua civiltà rispetto alle altre, e in particolare rispetto alla civiltà europea.
L’argomento in questo caso può essere che la Cina è così perché è sempre stata così. Il crollo dell’Ottocento e l’incorporazione subordinata della Cina nelle trafile del capitalismo occidentale fino al 1949 sono da considerare poco più di un blip. Un accidente storico lungo una vicenda plurisecolare di stabilità sistemica. Un semplice inciampo che tra cento anni sarà appena menzionato.
Se decidiamo di vedere le cose in questo modo, attraverso il filtro di un determinismo storico assoluto, non c’è molto di cui dibattere, non ci sono speciali indagini da condurre e non ci sono segreti da scoprire.
Seguendo questa linea di pensiero, tuttavia, occorre prendere per buona, senza coglierne l’acuminata dose di paradosso, la celebre risposta del ministro degli Esteri di Mao Tse-Tung, Chou EnLai, alla domanda di Henry Kissinger se la Rivoluzione francese fosse stata un bene per l’umanità: «È troppo presto per dirlo».
Se invece non ci accontentiamo della spiegazione che attribuisce sic et simpliciter alla superiorità della Cina come Stato e come civiltà la straordinaria continuità storica di questi ultimi, e se non
vogliamo aspettare cent’anni, la prima domanda che dobbiamo porci è se il governo della Cina post-1949 ha rappresentato o no una rottura completa con il sistema di governo del Celeste Impero e con le sue radici nella cultura e nella filosofia più antiche della Cina stessa. Da questo dilemma – non difficile da sciogliere, come vedremo nella prima sezione di questo studio – ne dipendono altri, molto più ardui. Eccone alcuni.
Da cosa deriva la capacità della Cina di superare il capitalismo proprio nel punto di maggiore vanto di quest’ultimo, cioè nello sviluppo delle forze produttive?
Deriva da un aggiornamento dell’idea di Adam Smith che la Cina era capace di seguire meglio dell’Europa il “cammino naturale dello sviluppo”? Oppure dalla sua singolare dotazione di quella forza vitale chiamata ‘asabiyya dal più grande sociologo di tutti i tempi, Ibn Khaldun, una forza che le ha consentito di rispondere alle minacce interne ed esterne rigenerandosi e diventando ogni volta più forte di prima?
O dall’azione di entrambe?
La Cina odierna è socialista, o è solo una versione più sofisticata del “capitalismo di Stato” già affermatosi nei paesi del socialismo reale del Novecento?
Il marxismo dei dirigenti del Partito Comunista Cinese si è incrociato con i classici confuciani, o entrambe queste culture sono rimaste come bandiera di un modo di pensare e di governare tanto suggestivo quanto, in fondo, obsoleto? Occorre davvero prendere sul serio, insomma, l’algoritmo politico del “socialismo con caratteristiche cinesi”?
La Cina di oggi è ancora l’entità aperta, cosmopolita, non-espansionista e non guerrafondaia dei tempi imperiali oppure è diventata una minaccia per l’ordine internazionale in quanto superpotenza sfidante, orientata ad assumere lo stesso profilo aggressivo e militarista della potenza dominante americana?
Se la Cina attuale è una replica della potenza americana, quanto è probabile un confronto militare tra le due?
Questo volume è un tentativo di rispondere in modo non evasivo a questi e ad altri quesiti. Uno sforzo che non nasce dalla insensata pretesa di pronunciare l’ultima parola su mega narrative sinologiche iniziate in Europa con Marco Polo e che hanno impegnato le menti di molti illustri studiosi nei secoli successivi.
Non nutro questa ambizione, anche se talvolta mi faccio accarezzare dall’idea di scrivere “il grande romanzo della Cina”, magari durante la prossima reincarnazione.
Nelle pagine che seguono proverò a mettere a fuoco le principali forze che hanno animato e animano la società cinese usando la cassetta degli attrezzi delle scienze sociali. La mia ambizione è quella di aiutare il lettore a orientarsi nella marea di approssimazioni, stereotipi e false narrative che circondano il tema della Cina in Occidente. E di fare ciò sintetizzando il meglio della letteratura scientifica sulla Cina.
I magnifici tre
Il disegno di questo libro è relativamente semplice. Nei tre blocchi che lo compongono cerco di delineare i “tre segreti” che consentono di capire l’eccezionalità della vicenda cinese. Quella che molti chiamano “il miracolo cinese” riferendosi alla spettacolare resurrezione del paese dal 1978 in poi, con le riforme di Deng Xiaoping. Resurrezione iniziata in realtà, come vedremo, con la rivoluzione del 1949.
Non si tratta, in verità, di veri e propri segreti ma di mega fattori quasi sconosciuti al largo pubblico, e poco frequentati anche dai sinologi contemporanei. Fattori che sono anche risorse. Le risorse strategiche che hanno fatto della Cina ciò che è stata e ciò che è.
Il primo è il non-espansionismo della Cina, cioè il suo sinocentrismo universalista e pacifico, collegato a una profonda avversione alla violenza e alla guerra. Il secondo è il suo singolare sistema di meritocrazia politica, il governo dei migliori, che la dirige da più di duemila anni. E il terzo è il suo sistema economico-politico fondamentalmente non capitalistico. Socialista. Ritengo che questa triade sia la guida più sicura per capire la Cina post-rivoluzionaria. La Cina di oggi, erede della Cina imperiale molto più di quanto si possa pensare.
Questi tre mega fattori sono le colonne su cui poggia l’attuale civiltà cinese. Una civiltà molto diversa da quella europea nel suo ethos di fondo, nella sua visione del mondo e nel suo assetto istituzionale, ma simile a essa nella sua complessità e capacità di rinnovamento.
I tre mega fattori citati non agiscono separatamente ma si mescolano e rafforzano a vicenda. Come vedremo nel corso della nostra esplorazione, la combinazione di un’arte del buon governo che rifugge l’uso della forza, praticata da una élite meritocratica convinta che il mercato sia uno strumento dello Stato, è passata indenne dall’attacco occidentale dell’Ottocento e dalla creazione della Repubblica cinese nei primi del Novecento. Per poi essere fatta propria dalla rivoluzione socialista di metà secolo.
Il risultato – la Cina di oggi – è un manufatto sociologico complesso, dalle radici storiche profonde, che il governo di Pechino chiama “socialismo di mercato con caratteristiche cinesi”.
Ero diffidente verso questa definizione, che piaceva al mio maestro Giovanni Arrighi ma era liquidata come una massima propagandistica da molti osservatori e studiosi. Ma credo siano i risultati dell’evoluzione della Cina lungo gli ultimi due decenni e in particolare le linee strategiche inaugurate da Xi Jinping – ad avere dato pieno potere euristico a questa espressione.
Discuteremo a lungo di questo apparente ossimoro del “socialismo di mercato”, ma per coglierne appieno il senso non bisogna dissociarlo dalle “caratteristiche cinesi”, cioè dalle sue radici nell’antica civiltà dell’Impero di Mezzo.
Una civiltà il cui profilo si è delineato cinquemila anni fa, e da tremila anni si è fissato in un sistema dotato di una resilienza straordinaria.
Il carattere centripeto e pacifico di questa civiltà – un cosmo che guarda a se stesso e che si considera nel contempo universale, privo perciò di una spinta espansiva di tipo sia territoriale che economico e militare – è l’aspetto forse più difficile da afferrare per chi fa parte di una civiltà dal carattere opposto, “estroverso”, centrifugo e guerresco come quella occidentale, abituata a vivere dal Cinquecento in poi sulle spalle altrui.
Vedremo come il grado di espansività e di bellicosità delle due civiltà sia connesso con i loro caratteri di fondo, forgiati dalla geografia e dalla storia quasi negli stessi anni: l’antichità greco-romana dell’Occidente coincide con l’epoca degli “Stati combattenti” della Cina e della fondazione dell’Impero unificato nel 221 a.C. È proprio in questa epoca che si sono affermate le principali coordinate filosofiche ed etiche delle due civiltà: Confucio, Mencio, Mozi e i legalisti sono vissuti nello stesso arco di tempo di Socrate, Platone e Aristotele.
Ma quale profonda differenza tra le due scuole, specialmente nella loro cosmologia, nella gestione della diversità etnica e culturale, nelle loro concezioni della guerra e dell’uso della violenza, nonché dell’arte di governo e dei diritti dei cittadini!
La questione dell’espansionismo della Cina è il punto più cruciale sotto il profilo dell’attualità politica internazionale, un campo dominato in Occidente da pregiudizi e distorsioni molto radicati. Secoli di eurocentrismo, di razzismo e di colonialismo globale hanno costruito un muro che impedisce agli occidentali di vedere gli aspetti più salienti della civiltà cinese.
Crollata durante l’Illuminismo, questa barriera è risorta nel corso dell’Ottocento e del Novecento. E oggi – a mano a mano che la Cina diventa più vicina spinta dal vigore della sua economia e dal suo crescente status di grande potenza – questo muro è diventato una muraglia sinofobica.
Gli ammalati di sinofobia sono numerosi. Risparmio al lettore la lunga lista di titoli di volumi e di articoli sul pericolo giallo, sulla minaccia cinese, sulla invasione di merci fabbricate in Cina che agirebbero da avanguardie di conquista politica e da cavalli di Troia di un progetto di dominio mondiale. Sparare a zero su Pechino è un vecchio sport, pronto a riemergere a ogni giro di boa della storia. L’Occidente non può resistere alla tentazione di proiettare sulla Cina la propria psicologia aggressiva, formatasi lungo secoli di crociate, conquiste e pretese di dominare il mondo.
Per mezzo di questo libro spero di contribuire a contrastare l’industria della paura e dell’ignoranza che alimenta gran parte della narrativa sulla Cina diffusa oggi in Occidente.
La chiave per entrare nella mentalità della Cina e dei cinesi è la conoscenza delle istituzioni politiche originali che essi hanno creato nel corso dei millenni e dentro le quali vivono ancora oggi.
Istituzioni umane, piene perciò di difetti. Ma istituzioni efficaci, sorrette da un larghissimo consenso perché hanno permesso al popolo cinese di raggiungere oggi, nell’arco di una sola generazione, traguardi impensabili, ottenuti usando risorse interne e non sfruttando, invadendo e occupando altri paesi.
Gli attuali successi della Cina all’estero sono di natura esclusivamente economica e non hanno niente a che fare con disegni di dominio regionali o globali.
Il paese non intende esportare le sue istituzioni politiche né condiziona investimenti e aiuti esteri alla sottoscrizione di alleanze politiche o militari contro ipotetici nemici. Il progetto Belt and Road è un ponte verso il resto del pianeta fondato su investimenti in opere di pubblica utilità e non sulla ricerca di profitti capitalistici. La sua filosofia non è imperialista, ma di cooperazione e amicizia transnazionali.
La nozione che la forza del governo cinese poggi su solide basi proprie è la più dura da afferrare in Occidente perché non c’è un flusso di notizie affidabili su ciò che succede davvero in quel paese e su come la Cina si comporta nella scena internazionale. Media e governi euroamericani riempiono il vuoto di informazioni attendibili alimentando angosce su una sorta di imperialismo cinese che mima quello praticato storicamente dall’Occidente contro la Cina.
Il fattore meritocrazia politica è quasi ignoto al pubblico occidentale perché si trova completamente al di fuori dei radar mediatici e del flusso di conoscenze sulla Cina. Anche gli studiosi stranieri più indipendenti fanno raramente ricorso al concetto di meritocrazia per interpretare le dinamiche politiche cinesi e le strategie più rilevanti adottate da Pechino nel campo dell’economia e della finanza.
La riluttanza a trattare il tema dipende un po’ dal termine stesso di meritocrazia politica. Esso incorpora una valutazione intrinsecamente positiva dell’oggetto, che in questo caso non è altro che il mostro sacro del Partito Comunista Cinese: una istituzione-chiave, poco conosciuta e poco studiata, circondata da un alone di riservatezza e di segreto che occorre superare per comprendere il funzionamento dello Stato, della società civile e della politica della Cina.
Quando parlo di meritocrazia mi riferisco non solo alla sua versione socialista incarnata dal pcc, ma a una forma di governo basata su un’istituzione denominata “sistema degli esami”, istituito formalmente dalla dinastia Sui (581-618 d.C.) sulla scorta di forme di selezione che esistevano già sotto gli Han (206 a.C. 220 d.C.) e pienamente operativo ancora oggi. Ogni dipendente dello Stato e quasi tutti i dirigenti pubblici di alto grado vengono selezionati in Cina tramite un concorso competitivo che inizia con prove scritte e orali. L’operato di ciascun dirigente è sottoposto in seguito a regolari valutazioni con scadenze fisse e con criteri e procedure predeterminati.
Fin dalle sue origini il sistema soffre di alcuni vizi di fondo quali la corruzione, l’ossificazione e il rischio di perdita di legittimità. Era così nella Cina imperiale ed è così oggi. La differenza è che nel passato la meritocrazia era lo strumento di governo dell’imperatore, mentre oggi è il principio che struttura una leadership comunista che si dichiara al servizio del popolo.
In Occidente siamo abituati a considerare i partiti politici come delle associazioni di cittadini che si propongono di influen-zare la gestione dei beni comuni. L’amministrazione dello Stato è da noi una burocrazia indipendente, gelosa della sua autonomia perfino rispetto all’esecutivo cui obbedisce. La pubblica amministrazione occidentale si vanta di dipendere solo dalle leggi, e alcune sue parti – come le banche centrali e la magistratura – sono indipendenti per legge dal potere legislativo ed esecutivo. Le più alte cariche dello Stato in Occidente vengono nominate dal presidente o dal primo ministro di ciascun paese, oppure da organi interni di autogoverno.
Non esistono in Cina né divisione dei poteri né Stato di diritto. Il pcc in Cina coincide quasi con lo Stato, e rappresenta anche un segmento non indifferente della società civile. Non vige in Cina alcuna forma di indipendenza della magistratura, che è espressione dell’esecutivo e del Partito. Il presidente della Repubblica Popolare è anche segretario del Partito e capo delle forze armate. Il Politburo, il vertice supremo del Partito, indirizza e controlla strettamente l’operato del governo.
La singolarità del pcc è di essere nello stesso tempo Stato, Partito e società civile. L’élite della società civile cinese governa lo Stato tramite il Partito Comunista, che non è un’associazione politica come le altre ma un gruppo sociale di quasi cento milioni di persone vagliate una per una attraverso metodi la cui selettività cresce man mano che si va verso l’alto.
Alla base il sistema è aperto a tutti, senza riguardo a privilegi di ricchezza e potere. L’ascesa lungo i ranghi è fermamente meritocratica, con filtri e controlli periodici non di facciata. In teoria, chiunque può diventare presidente della Repubblica o segretario del pcc. In pratica, vige una prassi di cooptazione e di corsie privilegiate per gli eredi e i sodali dei massimi dirigenti.
La presenza del Partito è capillare, ubiqua. Il pcc è il sistema nervoso della Cina. Grazie alla sua componente civile, esso è sia software che hardware. È il Moderno principe di Antonio Gramsci, le cui riflessioni sono una buona guida per la comprensione del sistema politico cinese di ieri e di oggi. Secondo Gramsci, il Moderno principe è un Partito di intellettuali organici che organizza il consenso della società, la “volontà collettiva” del popolo, tramite la gestione dei beni comuni. La stessa funzione svolta dai literati, gli shi, il corpo dei dignitari-filosofi che ha governato la Cina imperiale per duemilacinquecento anni.
Pur avendo ospitato la più grande economia di mercato del mondo, la Cina non ha mai conosciuto, né nel suo passato remoto né oggi, il capitalismo. La Cina può essere definita capitalista solo rinunciando a usare la preziosa distinzione tra la sfera del mercato, che è universale, da quel prodotto squisitamente occidentale che è il capitalismo. Dobbiamo a Braudel la migliore definizione dei due separabili compagni. Il mercato ha a che fare con il mondo rumoroso e inquieto degli scambi e dei luoghi di compravendita. È popolato da piccoli felini, audaci, mobili e orientati al profitto. Confucio li chiamava “piccoli uomini” che dovevano essere lasciati in pace e se possibile favoriti, perché fonte di graditi profitti aggiuntivi a quelli dell’agricoltura. Il capitalismo, secondo Braudel, può sembrare simile al mercato, ma in realtà è l’antimercato, popolato dai grandi predatori che scorrazzano nella giungla da essi stessi creata, spesso invisibili e lontani dai luoghi di accumulo delle loro fortune.
Adam Smith è stato celebrato, senza leggere bene i suoi scritti, come l’alfiere del libero mercato e del capitalismo. Nelle sue opere principali Smith sostiene, invece, che il libero mercato deve essere uno strumento dello Stato, e cita proprio la Cina come esempio di uno sviluppo “naturale” del mercato portatore di stabilità e di ricchezza delle nazioni, in contrasto alla strada “innaturale” imboccata dagli Stati europei nelle mani dei capitalisti e dei banchieri dediti allo sfruttamento del commercio coloniale e delle guerre per la supremazia.
Il modello di sviluppo cinese è crollato assieme alla Cina imperiale a metà dell’Ottocento perché colpito nel suo tallone d’Achille della potenza militare. Il modello è risorto nel 1949 con la rivoluzione maoista ed è ridiventato con Deng Xiaoping un “socialismo di mercato con caratteristiche cinesi”. Un sistema economico e politico che sopravanza per forza intrinseca, produttività e saldezza il capitalismo americano dominato dalla finanza parassitaria e pervenuto alla fase terminale della sua egemonia. Questa narrativa è l’argomento della terza parte di questo volume, il terzo “segreto” della potenza della Cina odierna.
La parte conclusiva di questo studio è dedicata alle conseguenze della rinascita della Cina, ai suoi rapporti con gli Stati Uniti e con il sistema internazionale. Tento qui di rispondere all’interrogativo sul possibile scontro armato tra le due massime potenze del pianeta e alla domanda sul ruolo della Cina nel nuovo ordine mondiale post-americano e post-occidentale che si va consolidando.
La mia risposta alla prima domanda è netta, e risulterà scontata, quasi ovvia, per chi si sia dato la pena di leggere anche poche pagine di questo volume. Non credo alla “trappola di Tucidide”, cioè a una guerra tra Cina e Stati Uniti per la supremazia mondiale diventata inevitabile come quella tra Sparta e Atene del iv secolo prima di Cristo. Gli ostacoli allo scontro nascono dal fatto che per fare la guerra bisogna essere in due, e dal fatto che il declino americano sta avvenendo in un contesto globale sfavorevole all’uso della forza militare.
Quanto al secondo interrogativo, cerco di mostrare nel capitolo finale come l’ascesa cinese sia tutta interna a un riequilibrio storico dei rapporti tra il Nord e il Sud del pianeta, e come la politica estera cinese sia coerente con il profilo più equo e più pacifico del nuovo ordine multipolare.

