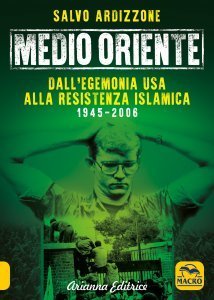Aspetti geopolitici del conflitto in Palestina
di Daniele Perra - 17/10/2023

Fonte: eurasia-rivista
Introduzione
In un articolo apparso sul sito informatico di “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, in data 20 settembre 2020 e dal titolo “Il declino USA e l’asse islamico-confuciano”, chi scrive faceva aperto riferimento al fatto che la ritrovata cooperazione tra le diverse componenti della resistenza antisionista, dopo le spaccature nate a seguito dell’aggressione alla Siria, avrebbe potuto rappresentare una “minaccia certa” per la sicurezza dello “Stato ebraico”. In particolare, si cercò di dimostrare come il ruolo attivo della Repubblica Islamica dell’Iran nel sostegno a gruppi come Hamas e Jihad Islamico avrebbe potuto incrementare notevolmente le capacità militari di questi ultimi portandoli ad un livello simile almeno a quello di Ansarullah nello Yemen (che per anni ha condiviso le sorti della Striscia di Gaza in termini di embargo e assedio)[1]. Ancora, in un altro articolo pubblicato sul medesimo sito informatico (in data 13 maggio 2021) per analizzare le dinamiche dell’attacco sionista al quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, si sostenne la tesi che tale “aiuto iraniano”, vista la particolare condizione della Striscia, avrebbe avuto i caratteri del semplice trasferimento di logistica, dati e informazioni per la costruzione di tecnologia militare (anche rudimentale) in loco[2].
Alla luce di quanto avvenuto a seguito dell’operazione “Tempesta di al-Aqsa”, si può affermare (senza timore di venire smentiti) che tali considerazioni non fossero affatto errate. Allo stesso tempo i recenti avvenimenti, con la morsa sionista sulla Striscia sempre più stretta e la dichiarata volontà genocida degli stessi vertici militari israeliani (il generale Ghassan Alian, ad esempio, oltre a paragonare Hamas con l’ISIS, ha esplicitamente apostrofato l’intera popolazione di Gaza come “animali umani” e promesso loro l’inferno), meritano di essere indagati nel dettaglio sia per darne un’interpretazione geopolitica, sia per decostruire il racconto “occidentale” nuovamente fondato sull’elementare schema del “c’è un aggressore ed un aggredito”, sempre utile per invertire le responsabilità di una tragedia ignorandone le cause nel tempo. Per fare ciò, questo contributo verrà suddiviso in due parti: nella prima parte verrà analizzato il dato politico-militare; mentre la seconda parte si concentrerà su alcuni aspetti geostorici del conflitto arabo-sionista.
Il dato politico-militare
La quasi totalità degli osservatori occidentali è rimasta stupita dalla complessità dell’attacco compiuto dal movimento di resistenza islamico lo scorso 6 ottobre contro l’entità sionista (un attacco portato via terra, mare ed aria attraverso l’utilizzo congiunto di gommoni, parapendii motorizzati ed il lancio, in grande quantità, di diverse tipologie di razzi capaci di sovraccaricare e penetrare il sistema di difesa antimissilistico Iron Dome realizzato con i generosi contributi delle amministrazioni statunitensi degli ultimi anni, in primo luogo quella Obama). Tra queste diverse tipologie di razzi spiccano i Qassam 1 e 2 (la cui produzione risulta piuttosto semplice e poco costosa, se si considera che spesso vengono utilizzati materiali di scarto dell’edilizia), l’Abu Shamala o SH-85 (così chiamato in onore di Muhammad Abu Shamala, comandante dell’ala militare di Hamas ucciso nel 2014), i Fajr-3 e Fajr-4 di fabbricazione iraniana (sebbene costruito utilizzando tecnologia nordcoreana basata sui vecchi sistemi missilistici sovietici a lancio multiplo) ed i missili R-160 di produzione siriana. Ha inoltre sorpreso la presenza nell’arsenale militare di Hamas di fucili m4 di fabbricazione nordamericana. A questo proposito, in modo da evitare inutili speculazioni fantageopolitiche che vorrebbero Hamas alleato del Mossad (sic!) e via discorrendo, occorre ribadire che la principale fonte di armamenti del movimento di resistenza è (inevitabilmente) il mercato nero. Senza considerare gli interi arsenali abbandonati dagli occidentali a seguito dell’indecorosa fuga dall’Afghanistan, è importante ribadire che sempre sulle colonne di “Eurasia” (anche riprendendo un’inchiesta del “Washington Post”, non esattamente una testata accusabile di essere espressione della propaganda russa)[3], si era già sottolineato il fatto che il voluminoso flusso di armi occidentali verso Kiev avrebbe finito in qualche modo per alimentare il mercato illegale della merce (pratica nella quale l’Ucraina indipendente ha storicamente avuto un ruolo di rilievo, anche grazie ad un tasso di corruzione tra i più alti su scala globale). Di conseguenza, non sarebbe affatto improbabile che un numero (anche ridotto) di queste siano andate a finire nella Striscia (armi di fabbricazione occidentale, ad esempio, molto probabilmente via ISI pakistano, sono state ritrovate anche tra i miliziani kashmiri che si oppongono all’occupazione indiana della regione).
In questo caso, il dato che dovrebbe essere analizzato, in realtà, è l’evidente fallimento dei servizi sionisti, che pure, in passato, erano stati particolarmente abili nell’infiltrare i territori della Striscia ed i ranghi di Hamas. Come già accennato, c’è chi ancora oggi sostiene la tesi dell’alleanza occulta o della creazione israeliana di Hamas. Ad onor del vero, sarebbe corretto affermare che, almeno inizialmente (ovvero, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso), vuoi per indebolire la guida “nazionalista” dell’OLP all’interno della lotta palestinese, vuoi per praticare il divide et impera all’interno delle fazioni della Resistenza all’occupazione sionista, Israele non ha particolarmente ostacolato l’ascesa di Hamas. Questo, è bene ribadirlo, in linea con quella che ha rappresentato la prassi politico-sociale del movimento di cui è figlio, la Fratellanza Musulmana (organizzazione nata in Egitto nel 1928 che si poneva l’obiettivo di ripensare la Umma islamica dopo l’abolizione del califfato operata dalla Turchia kemalista), ha costruito le proprie fortune attraverso la creazione di organizzazioni caritatevoli (ospedali, orfanotrofi, scuole e istituti di assistenza alle fasce più deboli della popolazione) che hanno rappresentato la struttura portante alla base del successo in un contesto economico estremamente precario come quello della Striscia di Gaza. Un successo che ha rappresentato quanto meno un grave errore di calcolo da parte degli apparati di sicurezza sionisti. Le difficoltà di questi (in parte dovuti anche ad un miglioramento delle capacità di controspionaggio di Hamas, altro aspetto che si lega ad una più stretta collaborazione con Teheran) non possono essere dissociate dalla profonde divisioni interne alla società israeliana (segnata da crescenti tensioni etniche se non addirittura religiose – la crescita delle comunità ortodosse che rifiutano il servizio militare non può essere sottovalutata – dall’ossessione del sorpasso demografico arabo e da un’inusuale, per Israele, scontro tra vertici politici e militari). Gli stessi appelli all’unità nazionale di Benjamin Netanyahu (aspramente criticato sia per il suo controverso piano di riforma del sistema giudiziario, sia per la sua politica della “tolleranza zero” nei confronti di qualsiasi, anche minima, richiesta palestinese) non hanno incontrato gli effetti desiderati. Nello specifico, il Primo Ministro è stato attaccato a più riprese sia da ambienti “progressisti” e “liberali” (come lo storico quotidiano “Haaretz”) sia da quelli più rigidamente conservatori.
Alle evidenti difficoltà politico-sociali interne (ad oggi, la principale minaccia per Israele rimane la frammentazione del suo tessuto sociale, non dissimile a quella del resto dell’Occidente) si sommano le difficoltà di natura militare. Le iniziali dichiarazioni di Netanyahu su un imminente ingresso nella Striscia di Gaza da parte delle forze armate israeliane si sono scontrate con la visione più “prudente” dei vertici militari, che, al momento, sembrano optare in primo luogo per un lento strangolamento della Striscia sottoposta a costanti bombardamenti “preparativi” ed al taglio delle forniture alimentari, idriche ed elettriche. Questo, oltre a mettere in luce la tradizionale ipocrisia dell’Occidente (che, a differenza di quanto fatto per gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, non pare intenzionato ad accusare di crimini di guerra Israele), porta allo scoperto i rischi ed i costi di una campagna militare terrestre in un contesto urbano densamente abitato. Non a caso, i centri studi nordamericani (sulla scia di quanto avvenuto nei due conflitti ceceni dell’ultimo decennio del XX secolo) avevano definito il combattimento urbano come la caratteristica peculiare dei conflitti del nuovo millennio. Un tipo di combattimento che privilegia quasi sempre il difensore e che secondo gli esperti di tattica militare può essere coronato da successo solo se l’attaccante ha un netto vantaggio numerico (da 6 a 10 a 1 sull’avversario)[4]. Gli stessi statunitensi incontrarono non poche difficoltà a Falluja e, nonostante un considerevole vantaggio numerico (circa 15.000 unità contro 3.000 insorti), riuscirono ad avere la meglio solo radendo al suolo interi quartieri della città. La Russia, a sua volta, fatta eccezione per il caso di Mariupol (città dall’alto valore strategico e “simbolico”) o per il “tritacarne” di Bakhmut/Artemovsk, ha scelto di limitare al massimo il combattimento urbano nel contesto del conflitto ucraino.
Ora, appare evidente che districarsi dentro il ramificato sistema di gallerie costruito dai miliziani palestinesi all’interno della Striscia non sarebbe affatto facile ed esporrebbe le forze israeliane a perdite pesanti (cosa che, a suo tempo, portò Tel Aviv ad abbandonare i sogni di espansione in Libano). Tuttavia, appare altrettanto evidente il fatto che l’unico esito possibile del conflitto per Israele è la “vittoria totale”: ovvero, la distruzione di Hamas (o almeno della sua capacità di offendere). Per raggiungere tale scopo l’ingresso nella Striscia (con tutti gli enormi rischi che esso comporta, anche in termini di pressione sull’industria bellica occidentale già provata dal conflitto ucraino) sembra inevitabile. Ed in preparazione di questo intervento si è già provveduto a mettere in moto una campagna informativa volta a disumanizzare e criminalizzare l’avversario (da identificare come “male manifesto”). In quest’ottica devono essere interpretate le notizie (in larga parte inattendibili) sul presunto massacro di minori nel kibbutz di Kfar Aza il cui scopo è semplicemente quello di preparare l’opinione pubblica ad un lungo conflitto; una pratica ben conosciuta in Occidente, dall’altrettanto presunto massacro di Račak che diede il via all’aggressione NATO contro la Serbia, alle accuse infondate contro l’Iraq nel 2003, fino alla campagna di disinformazione che ha spianato la strada alla distruzione della Libia (senza dimenticare il mai dimostrato massacro russo a Bucha, in Ucraina). A prescindere dalla conferma o meno di tali notizie, rimane curioso notare come la suddetta opinione pubblica non abbia mostrato la minima indignazione di fronte all’uccisione (questa volta reale quanto reiterata) di minori palestinesi nei territori occupati da parte delle forze di sicurezza israeliane. Eppure, come ha riportato l’organizzazione non governativa Save the Children, dall’inizio dell’anno fino allo scorso settembre, la strage ha raggiunto il triste primato di 38 morti[5]. Ad ulteriore dimostrazione del fatto che non esiste un “nuovo conflitto” in Palestina (come sostengono impropriamente alcune testate giornalistiche italiane) – quello a cui si sta assistendo è la semplice recrudescenza di un conflitto ultradecennale – e del fatto che è altrettanto improprio affermare che non vi sia stato alcun motivo scatenante dietro l’attacco di Hamas.
A questo proposito sarà utile aprire anche una breve partentesi sul contesto internazionale, visto che diversi analisti hanno sostenuto la tesi che l’operazione del movimento di resistenza palestinese fosse rivolta a vanificare gli sforzi nordamericani per la normalizzazione “ufficiale” delle relazioni tra Israele ed Arabia Saudita. Tale eventualità non è da scartare a priori, tuttavia, è necessario fare alcune precisazioni: a) storicamente i rapporti tra Hamas ed Arabia Saudita non sono mai stati particolarmente costruttivi (il movimento, al contrario, è sempre stato sostenuto da Qatar e Turchia, Paesi che hanno solide relazioni con Tel Aviv, sebbene con i loro alti e bassi); b) i rapporti tra Israele ed Arabia Saudita non hanno necessità di essere normalizzati in tempi brevi visto che vanno avanti già da lungo tempo in forma non ufficiale (come ha sostenuto la studiosa Madawi al-Rasheed, neppure l’embargo petrolifero seguito alla guerra dell’ottobre 1973 poteva essere considerato un atto ostile vista la sua durata estremamente limitata)[6]; c) non è affatto scontato che una normalizzazione dei rapporti tra Israele ed Arabia Saudita (sulla falsariga degli “accordi di Abramo” trumpisti) porti ad un congelamento del conflitto in Palestina o, addirittura, ad un nuovo accordo di pace israelo-palestinese che includa i movimenti di resistenza islamica oltre alla già ampiamente delegittimata Autorità Nazionale Palestinese; d) gli accordi di pace fin qui proposti in ambito occidentale sono sempre stati unidirezionali, ignorando completamente i diritti di una delle due parti (non ultimo il “piano/truffa del secolo” dell’amministrazione Trump che prevedeva, da un lato, la totale legittimazione degli insediamenti coloniali sionisti in Cisgiordania e, dall’altro, la creazione di un’entità nazionale palestinese priva di sovranità, demilitarizzata, ed a macchia di leopardo).
In linea teorica, dunque, sarebbe più corretto affermare che il recente accordo per la riapertura dei canali diplomatici tra Iran ed Arabia Saudita, patrocinato dalla Cina, abbia in qualche modo dato il via libera ad Hamas per l’organizzazione dell’attacco. Infine, sembrerebbe oltremodo scartabile la “pista Sadat”: ovvero, l’idea che i vertici di Hamas, come fece il successore di Nasser nei primi anni ’70, abbiano cercato lo scontro per dare una dimostrazione di forza e poter negoziare una via d’uscita dal conflitto in termini più favorevoli. Un movimento che si pone come espressione delle speranze di rivalsa della Palestina (a prescindere da elementi ed eventi non poco ambigui che ne hanno caratterizzato la storia) non è paragonabile alle aspirazioni personali del presidente di un Paese terzo, l’Egitto, il cui obiettivo finale era il progressivo inserimento nell’orbita occidentale. Tra l’altro, proprio Sadat cadde vittima di un attentato organizzato da un gruppo fuoriuscito dalla Fratellanza Musulmana, nonostante lo stesso presidente ne avesse riabilitato il nome dopo gli anni delle persecuzioni nasseriane (sebbene la Fratellanza abbia avuto un ruolo di non poco conto negli eventi che portarono al successo della “rivoluzione” degli Ufficiali Liberi nei primi anni ’50).
Aspetti geostorici
L’attivista e studioso francese Gilles Munier commentò così, sulle pagine de “La Nation Européenne”, la morte del militante di Jeune Europe Roger Coudroy che nella seconda metà degli anni ’60 si era recato in Palestina a combattere con i Fida’iyyin: “La lotta contro il sionismo oltrepassa ampiamente le frontiere della Nazione Araba […] L’attiva partecipazione di europei alla lotta di liberazione, lo si comprende facilmente, è una realtà troppo pericolosa per i sionisti, i quali non possono accettare a cuor leggero che la stampa si impadronisca della notizia. Israele, pilastro dell’imperialismo anglosassone, è una minaccia permanente per tutti i popoli rivieraschi del Mediterraneo. Accettarne l’esistenza significa ratificare la politica dei blocchi, il cui interesse consiste nel dividere per continuare ad imperare. La scomparsa di Israele toglierà alla VI Flotta USA il suo principale pretesto per incrociare nel Mediterraneo […] La questione palestinese e l’ipoteca sionista sull’Europa sono un unico problema, che potrà essere risolto solamente mettendo in riga l’organizzazione sionista mondiale. La storia mostrerà che Roger Coudroy, così come Che Guevara, non è morto invano”[7].
In altre parole, Munier affermava che non può esservi sovranità per l’Europa (in generale) finché Israele sarà lì. L’idea che l’entità sionista rappresenti un “pilastro dell’imperialismo anglosassone” non è priva di fondamento. A prescindere dal fatto che la flotta USA nel Mediterraneo si è rapidamente mossa verso le coste dell’entità sionista dopo l’attacco della resistenza islamica (senza considerare l’impegno di Washington a valutare l’invio di sistemi d’arme compatibili con quelli in dotazione all’esercito israeliano)[8], esistono innumerevoli precedenti storici a sostegno di tale tesi: dall’appoggio incondizionato nel corso del conflitto dell’ottobre 1973, alla dichiarazione dell’attuale presidente statunitense Joseph R. Biden “If Israel didn’t exist, the US would have to invent one to protect US interests”[9].
Ma l’amore occidentale per Israele ha origini lontane. Per tutto il corso del XIX secolo, ad esempio, proliferarono in Gran Bretagna associazioni (precorritrici dell’odierno e sempre più diffuso “sionismo cristiano”) che spingevano per un ritorno degli ebrei in Terra Santa (furono loro a coniare l’espressione successivamente utilizzata dal sionismo, ed assolutamente falsa, “un popolo senza terra per una terra senza popolo”). Tali riflessioni di carattere prettamente escatologico andarono rapidamente ad inserirsi in un discorso più ampio che intrecciava aspetti teologici a considerazioni puramente geopolitiche. Il politico britannico Benjamin Disraeli (ebreo sefardita convertito, forse non troppo genuinamente, al cristianesimo), diversi anni prima di divenire Primo Ministro di Sua Maestà, ad esempio, pubblicò alcuni romanzi in cui emergeva l’idea che la “nazione ebraica” avesse diritto ad una patria in Palestina. In uno di essi, oltre ad emergere l’idea di un protettorato inglese in Terra Santa, si leggeva: “Mi domandate cosa io desideri. La mia risposta è Gerusalemme. Mi domandate che cosa io desideri. La mia risposta è il Tempio, tutto ciò che abbiamo perso, che abbiamo desiderato…”[10].
Di fatto, l’apertura del Canale di Suez nel 1869 rese l’area del Vicino Oriente estremamente appetibile per gli interessi geopolitici britannici di controllo di una rotta che riduceva notevolmente i tempi di navigazione verso l’India (in questo senso si dovrebbe leggere anche uno degli ultimi colpi di coda del colonialismo europeo, l’aggressione congiunta franco-britannico-sionista all’Egitto nasseriano dopo la nazionalizzazione del Canale nel 1956). Ad onor del vero, Londra si oppose per lungo tempo alla costruzione del Canale temendo l’eccessivo rafforzamento francese nell’area. Tuttavia, quando si rese conto che tale strategia era inutile, giocò la carta della penetrazione finanziaria in Egitto. Un piano che si concretizzò proprio quando Disraeli era Primo Ministro, nel 1876, grazie all’acquisto del 44% delle azioni della Compagnia del Canale in cambio di 4 milioni di sterline che vennero prestate al governo britannico dalla Banca Rothschild (i cui proprietari, noti “filantropi”, erano gli stessi che mantenevano economicamente gli insediamenti ebraici in Palestina della prima fallimentare “aliyah”). Due anni più tardi il rafforzamento delle posizioni britanniche nell’area proseguì grazie al pieno controllo su Cipro a seguito del Congresso di Berlino. Ma fu solo nei primi decenni del XX secolo che l’alleanza tra il sionismo e la Corona britannica divenne esplicita grazie al lavoro incessante di Chaim Weizmann, un chimico esperto nella produzione di polvere da sparo per le navi che fu estremamente abile nell’infiltrare i vertici politici britannici e nel portare a compimento il progetto di Theodor Herzl di conquistare alla causa sionista una grande potenza europea proponendo l’eventuale entità ebraica come avamposto occidentale nel Levante. Lo stesso Herzl, infatti, aveva cercato di fare altrettanto (fallendo) sia con la Germania (addirittura, il padre del sionismo politico pensava che il tedesco avrebbe dovuto essere la lingua dello “Stato ebraico”) sia con l’Impero ottomano. La prima rifiutò perché non voleva irritare la Sublime Porta ed aveva a cuore il progetto di costruzione della ferrovia Berlino-Bagdad; il Sultano ottomano, invece, nonostante le promesse di un sostegno finanziario ebraico alle disastrate casse dell’Impero, non poté accettare l’offerta ergendosi a protettore dei luoghi santi dell’Islam.
Ad ogni modo, con la celebre Dichiarazione Balfour del 1917 (forse partorita dal governo britannico anche per fare in modo che l’influente e numerosa comunità ebraica statunitense spingesse Washington ad un intervento diretto all’interno del Primo conflitto mondiale), Londra si impegnava direttamente a costituire una “casa nazionale per il popolo ebraico in Palestina” e tradiva apertamente gli accordi presi con gli arabi che, in quegli stessi anni, sobillati proprio da agenti di Londra, si erano ribellati al dominio ottomano.
L’appoggio britannico determinò naturalmente un aumento esponenziale dell’aggressività e delle pretese sioniste sulla Terra Santa. Ed è sempre in questi anni che si iniziò a pensare ad una “soluzione per la questione araba”. A questo proposito, si possono individuare all’interno del sionismo almeno tre diverse tendenze. Inizialmente, si pensò ad una sorta di “assimilazione” degli arabi palestinesi che appare con vivida forza nel romanzo “fantastorico” di Theodor Herzl Altneuland (L’antica nuova terra), pubblicato nel 1902, in cui si sostiene che il sionismo, trasformando la Palestina in una società ideale che l’umanità tutta dovrebbe emulare, avrebbe finito per inglobare al suo interno una popolazione indigena che non avrebbe potuto far altro che trarre guadagno dalla presenza ebraica. L’idea dell’assimilazione, tuttavia, venne apertamente criticata da quello che fu l’interprete del sionismo culturale, Asher Ginsberg. Egli, in un testo dal titolo La verità dalla terra di Israele, scrisse: “All’estero tendiamo a credere che oggi la Palestina sia quasi del tutto abbandonata, una sorta di deserto non coltivato, e che chiunque possa arrivare e comprare tutta la terra che vuole. Ma la realtà non è questa. È difficile trovare nel Paese un terreno arabo che rimanga incolto […] I coloni trattano gli arabi con ostilità e crudeltà, invadono ingiustamente le loro proprietà, li picchiano senza vergogna e senza alcuna ragione e sono fieri di comportarsi così […] siamo abituati a pensare agli arabi come selvaggi, come bestie da soma che né vedono né capiscono ciò che accade attorno a loro”[11].
Un’altra tendenza, in linea con l’idea della “terra senza popolo” o della presenza su di essa di un “popolo senza identità”, fu quella della negazione del problema. Proprio Chaim Weizmanm, nel 1917, interrogato dal pensatore sionista Arthur Ruppin riguardo i possibili rapporti degli immigrati ebraici con la popolazione palestinese, rispose in modo seccato: “gli inglesi ci hanno assicurato che in Palestina ci sono solo qualche migliaio di kushim (negri) che non contano nulla”[12].
La terza tendenza, quella storicamente più diffusa, è stata quella dell’eliminazione fisica del problema alla radice (o spingendo la massa della popolazione palestinese verso i Paesi confinanti, soprattutto la Giordania, o letteralmente eliminandola in virtù di un afflato religioso che identificava i Palestinesi con i discendenti dei popoli biblici che abitavano la regione prima della conquista ebraica). A questa tendenza si sono legati personaggi come Ariel Sharon (i cui cecchini dell’Unità 101 sono passati alla storia per l’inquietante pratica di sparare su contadini arabi disarmati per cacciarli dalle loro terre) e Moshe Dayan che non ha mai nascosto il fatto che molti villaggi arabi venissero distrutti e/o rinominati in ebraico per cancellare storia e identità della Palestina antecedenti alla colonizzazione sionista (si pensi alla distruzione di un intero quartiere della vecchia Gerusalemme per costruire uno spiazzo di fronte al cosiddetto “muro del pianto”).
La tendenza all’eliminazione del problema, in realtà, era già ben presente nelle elaborazioni teoriche degli esponenti del sionismo socialista (quello che attirò anche le attenzioni di Stalin nella convinzione, errata, di poterlo usare in chiave di opposizione all’Occidente nel Vicino Oriente). Tra loro, spiccava Ber Borochov che, riprendendo le tesi marxiste presentate negli scritti sulla “questione ebraica”, sosteneva l’idea di un “rovesciamento della piramide” da effettuare per mezzo del lavoro. Questi, nella sua opera Basi del sionismo proletario (1906), partiva da un’analisi della struttura sociale ebraica che veniva presentata come una piramide rovesciata, con pochi proletari e contadini rispetto ad un numero elevato di piccoli commercianti, imprenditori e banchieri. Di conseguenza, la “liberazione del popolo ebraico” era impensabile senza la trasformazione della sua struttura sociale. E tale trasformazione poteva compiersi solo attraverso la concentrazione territoriale in Palestina (in cui anche secondo Borochov viveva un popolo privo di identità) e la costruzione su di essa di uno “Stato proletario ebraico” fondato sul lavoro.
L’enfasi sul lavoro, e soprattutto sul lavoro della terra (ben presente anche nelle opere di Aaron David Gordon), ha prodotto la retorica della “terra redenta” che poteva essere coltivata solo da ebrei. Così, mentre i primi coloni sionisti utilizzarono (e sfruttarono) ampiamente la manodopera araba, gli esponenti delle ondate migratorie successive optarono per un deciso cambio di tendenza impedendo ai contadini palestinesi la possibilità di lavorare la terra dalla quale per secoli avevano tratto sostentamento. Nello specifico, una volta che le terre venivano vendute al movimento sionista da latifondisti spesso neanche presenti in loco (avendo le loro dimore a Beirut, Damasco o Istanbul), queste venivano recintate ed i contadini palestinesi allontanati con le buone o le cattive. Dunque, afferma lo studioso Arturo Marzano: “mentre il modello della prima aliyah era quello di una società basata sulla supremazia ebraica sugli arabi, la seconda aliyah mirò all’esclusione totale di questi ultimi”[13]. Va da sé che l’equazione terra ebraica – lavoro ebraico – prodotto ebraico non impedì comunque forme di sfruttamento. I sionisti, infatti, a tale scopo, favorirono la migrazione in Palestina di ebrei yemeniti (più simili agli arabi) e, dunque, suscettibili di discriminazione pur mantenendo intatto il suddetto principio della terra redenta. Di fatto, anche il mito economico del kibbutz, ben presente nell’immaginario collettivo occidentale, andrebbe riconsiderato per quello che i kibbutz storicamente sono stati: delle enclave esclusiviste e rigidamente razziste. Senza considerare il mito, altrettanto irreale, dell’efficienza economica sionista (quella israeliana, in realtà, è un’entità fortemente dipendente dagli aiuti esteri, tanto che in molti studi accademici viene fatta rientrare nella categoria dei cosiddetti “Rentier States”).
Allo stesso tempo, a chi ancora sostiene che non vi fu un reale furto di terre arabe, sarà utile ricordare che nel 1946, anno dell’ultimo rilevamento, solo il 6% del territorio della Palestina sottoposta a mandato britannico era stato acquisito “legalmente” dal movimento sionista[14]. Non solo, ma sarebbe anche opportuno ricordare chi ha originariamente importato in Palestina i metodi del terrorismo rivolto contro la popolazione civile (si pensi all’uso indiscriminato della violenza da parte dell’Irgun, che era solito piazzare i suoi ordigni nei mercati o nelle corriere frequente dagli arabi)[15]. E sarà altrettanto opportuno ricordare che già prima del progetto di spartizione approntato dall’ONU i sionisti avevano preparato il cosiddetto “Piano Dalet”, il quale prevedeva la rapida annessione di territori che le Nazioni Unite avrebbero attribuito alla componente araba.
In conclusione, dunque, appare evidente anche come la soluzione dei “due popoli, due Stati” rimanga sostanzialmente impraticabile. In Palestina, oggi, si scontrano in primo luogo due visioni del mondo totalmente agli antipodi ed incompatibili: la civiltà del profitto di uno “pseudopopolo” sradicato (prodotto del mescolamento di etnie differenti) che radicandosi nuovamente ha semplicemente prodotto una mera imitazione di modelli occidentali (presentandosi come una civiltà dello spirito che si radica nella terra e nella tradizione e da essa rifiuta “testardamente” di scostarsi). Lo scontro rimane inevitabile, per il semplice dato storico che Israele, proponendosi oggi come appendice periferica dell’impero occidentale a guida nordamericana, assume di sé il peso della frontiera: ovvero, di quella linea di faglia tra civiltà differenti che si contraddistingue sempre per la presenza latente di forme di conflitto.
NOTE
[1]Si veda Il declino USA e l’asse islamico-confuciano, 20 settembre 2020, www.eurasia-rivista.com.
[2]Si veda Gerusalemme e Resistenza, 13 maggio 2021, www.eurasia-rivista.com.
[3]Si veda Flood of weapons to Ukraine raises fear of arms smuggling, www.washingtonpost.com.
[4]Si veda Russia’s Chechen wars 1994-2000. Lesson from urban combat, www.rand.org.
[5]Si veda Cisgiordania: il 2023 è l’anno più letale per i bambini palestinesi. Uccisi almeno 38 minori, più di uno a settimana, 18 settembre 2023, www.savethechildren.it.
[6]Madawi al-Rasheed, Storia dell’Arabia Saudita, Bompiani, Milano 2004, pp. 170-79.
[7]Contenuto in C. Mutti, Introduzione a R. Coudroy, Ho vissuto la resistenza palestinese, Passaggio al Bosco, Firenze 2017.
[8]Si veda Israele mobilita 300 mila riservisti per l’offensiva nella Striscia di Gaza, 11 ottobre 2023, www.analisidifesa.it.
[9]Si veda Biden, a veteran friend of Israel, www.timesofisrael.com.
[10]Contenuto in A. Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl ad oggi, Carocci editore, Roma 2017, p. 78.
[11]Ibidem, p. 49.
[12]A. Colla, Cent’anni di improntitudine, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici” 1/2018.
[13]Storia dei sionismi, ivi cit., p. 71.
[14]L. Kamal, Imperial perceptions of Palestine. British influence and power in late Ottoman times, Tauris, Londra 2015, p. 68.
[15]Si veda C. Schindler, The land beyond promise. Israel, Likud and the Zionist Dream, Tauris, Londra 2002, pp. 27-35.