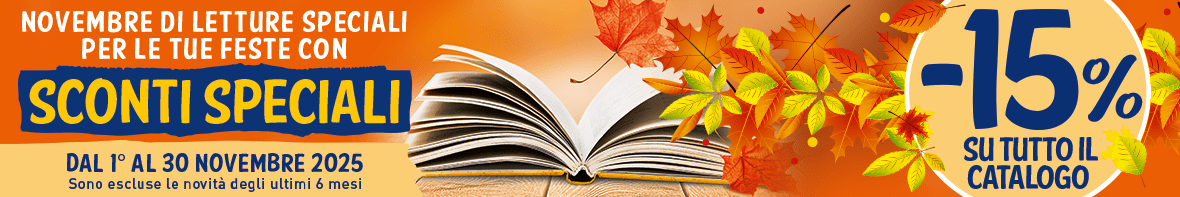Il destino dell’Austria-Ungheria nel pensiero politico di Giuseppe Donati
di Francesco Lamendola - 04/01/2010

Giuseppe Donati (Granarolo di Faenza, 1889 – Parigi, 1931) è stato una figura molto importante nell’ambito del cattolicesimo sociale del primo Novecento, anche se poi un tantino trascurata dalla storiografia nazionale.
Cattolico di formazione democratico-cristiana, e influenzato dal pensiero di Romolo Murri, nel 1914-15 fu un esponente dell’interventismo democratico, in contrasto con il filone maggioritario del mondo politico cattolico, nonché volontario nella prima guerra mondiale, che costituì, per lui, una preziosa esperienza sul piano culturale ed umano.
Nel dopoguerra, fu inizialmente in dissenso con don Sturzo e con il neonato Partito popolare, adoperandosi per impedire che la lega democratico cristiana vi si unisse. Egli stesso aderì al Partito popolare solo nel 1921, dopo il congresso di Venezia e dopo il fallimento del tentativo di dar vita ad una nuova formazione politica nazionale. Fu un tipico popolare di sinistra, non lontano, sul terreno sociale e sindacale, dalle posizioni socialiste, come non lo era Guido Miglioli, di cui ci siamo già occupati in un precedente lavoro («Guido Miglioli, le “leghe bianche” e il movimento contadino della Valle Padana», consultabile sempre sul sito di Arianna Editrice).
Nel gennaio del 1923 don Sturzo lo chiamò a Roma e da allora divenne uno dei principali collaboratori del sacerdote siciliano, svolgendo, fra l’altro, la funzione di direttore del quotidiano «Il popolo», che per sua volontà si schierò su posizioni intransigenti nei confronti di Mussolini e del suo nascente regime.
Sempre nel 1923, fu al centro di un contrasto con Alcide De Gasperi, il quale ventilava la possibilità di accettare la riforma elettorale basata su un premio di maggioranza: Donati vi si oppose, essendo fermamente convinto che il fascismo non si sarebbe «normalizzato» e non avrebbe conosciuto alcuna evoluzione in senso democratico.
All’indomani del delitto Matteotti - allorché, per un momento, la posizione di Mussolini sembrò sul punto di vacillare -, Giuseppe Donati si distinse come uno dei più decisi fautori della secessione aventiniana; e fu proprio lui a presentare - il 6 dicembre 1924 - la denuncia all’Alta Corte di giustizia contro il generale De Bono, direttore generale della Pubblica Sicurezza, che, in seguito al processo, dovette rinunciare a tutti i suoi incarichi, pur risultando, alla fine, assolto.
Queste sue coerenti, ma pericolose, prese di posizione resero la sua permanenza in Italia impossibile, talché, nel 1925, anch’egli dovette prendere la va dell’esilio, stabilendosi in Francia. In seguito alla legge del 31 gennaio 1926, si vide privato della cittadinanza italiana; provvedimento che fu poi revocato in occasione della celebrazione del decennale della marcia su Roma, in concomitanza con la concessione di alcune amnistie.
Durante gli anni dell’esilio - che, specialmente all’inizio, furono molto duri, poiché significarono la miseria - diresse due giornali antifascisti: dapprima il «Corriere degli Italiani», indi «Il pungolo», che si segnalarono entrambi per la loro vis polemica. Bisogna anche dire che, avendo allacciato rapporti con alcuni ex fascisti delusi e a loro volta espatriati, Donati venne a trovarsi in un ambiente saturo di sospetti e largamente infiltrato dalle spie del regime; situazione di cui egli non fu in alcun modo responsabile ma, semmai, la principale vittima.
Carattere franco e battagliero, Donati non risparmiò critiche neppure alla Concentrazione antifascista e ad altri gruppi che operavano, dall’estero, nel medesimo senso, ravvisando in essi gravi errori sia di merito, che di metodo.
Morì nel 1931; i suoi scritti politici sono stati raccolti solamente nel 1956. Si tratta, in gran parte, di scritti estemporanei, articoli apparsi sulla stampa dell’epoca, e particolarmente sul giornale cattolico «L’azione», nei quali Donati si mostra scrittore denso e vigoroso e polemista di notevole tempra ed efficacia. In particolare, il suo nome è rimasto legato proprio al giornalismo, più ancora che alla sua attività politica; tanto che egli è considerato praticamente l’inventore del moderno giornalismo d’inchiesta.
Dopo aver così delineato un sommario profilo dell’uomo e della sua opera, desideriamo qui soffermarci su di un particolare aspetto del suo pensiero politico, ossia - nel contesto del suo interventismo democratico, che lo avvicinava alle posizioni di un «laico» di sinistra, come Gaetano Salvemini - sulla sua riflessione circa il destino dell’Austria-Ungheria ed il futuro assetto dell’area carpatico-danubiana, con particolare riguardo al problema delle nazionalità, come allora si diceva, «oppresse», e alla questione adriatica, nonché alla futura sistemazione dei confini orientali del Regno d’Italia.
Tutto ciò non in chiave di astratta discussione politica, ma nella prospettiva, estremamente concreta, dell’atteggiamento che il nostro Paese avrebbe dovuto tenere, dopo le prime settimane di guerra e dopo il profilarsi di una grave, e forse irreparabile serie di disfatte, subita dalle forze armate austriache, preludio di un probabile crollo politico interno di quel Paese.
E qui emerge in primo piano la necessità di esporre con chiarezza le ragioni che lo spingevano a sostenere l’impossibilità, per l’Italia, di rimanere in una prolungata situazione di neutralità, pena vedersi esclusa poi, al tavolo della conferenza di pace, dal diritto di avere voce in capitolo circa il riassetto della carta geografica della Mitteleuropa.
In effetti, le rivendicazioni territoriali che l’Italia, secondo Donati, avrebbe dovuto formulare nei confronti dell’Austria appaiono estremamente modeste: il Trentino, più l’Alto Adige, ma quest’ultimo solo per assicurarsi la frontiera strategica del Brennero; una parte dell’Istria, lasciando all’Ungheria (evidentemente a Fiume, pur senza nominarla) uno sbocco al mare per le sue necessità commerciali; qualche ritocco marginale nel settore della Venezia Giulia. Niente Dalmazia, inevitabilmente destinata, secondo lui, a divenire terra slava; e niente Trieste, destinata ad essere costituita in Stato libero, dovendo essa continuare a svolgere la sua funzione di porto dell’Europa centrale, non si capisce bene se nell’interesse dell’Austria medesima o dello Stato serbo-croato che, necessariamente, sarebbe sorto in seguito alle vittorie militari della Serbia.
Le idee di Giuseppe Donati intorno alla questione della necessità dell’intervento italiano contro l’Austria-Ungheria e dei suoi realistici obiettivi di guerra sono esposte con molta chiarezza in un articolo apparso su «L’Azione» del 20 settembre 1914 e intitolato «La fine dell’Austria e gli interessi dell’Italia».
Due cose è necessario premettere, prima di passare la parola al Donati, per la corretta comprensione del suo pensiero: primo, le gravi sconfitte dell’esercito austro-ungherese nella duplice battaglia di Lemberg contro i Russi e nella battaglia del Cer contro la Serbia, avevano ingenerato l’impressione che il crollo dell’Impero asburgico fosse ormai questione di settimane, e che la Romania non si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione di intervenire nel momento ad essa più favorevole; mentre non accadde né l’una cosa, né l’altra.
Nonostante le sconfitte, l’esercito austriaco, con l’aiuto di quello germanico, riuscì a contenere la pressione dei suoi nemici e, già in dicembre, era in grado di passare alla controffensiva sul Dunajec contro i Russi, lanciando la campagna di Limanowa-Lapanòw, che tolse alle armate zariste la speranza di tracimare dai Carpazi verso la Pianura Ungherese. E, quanto alla Romania, essa attese ad intervenire fino all’estate del 1916, vale a dire più di un anno dopo l’ingresso in guerra dell’Italia: fu, anzi, solo la conquista di Gorizia a darle la spinta decisiva, oltre agli inattesi, strepitosi successi dell’offensiva Brusilov in Galizia orientale e in Bucovina.
La seconda cosa da tener presente è che il titolo dell’articolo, forse voluto dalla direzione de «L’Azione» per esigenze editoriali, non riflette affatto il senso del contenuto: giacché Donati non auspica affatto la cancellazione dell’Austria-Ungheria dalla carta geografia dell’Europa, bensì la sua conservazione, e sia pure entro i termini delle province abitate da Tedeschi e Magiari; mentre tutto il resto avrebbe dovuto passare alla Russia, alla Serbia, alla Romania e all’Italia, con Trieste eretta allo «status» giuridico di città libera.
Particolare non certo irrilevante, Donati non spende un ragionamento per il futuro destino della cattolica Polonia (lui, cattolico fervente), anzi, implicitamente esclude una sua resurrezione nazionale, laddove parla di ingrandimenti della Russia a spese dell’Austria (evidentemente, con la Galizia); il che la dice lunga sulla carenza concettuale, nella visione donatiana del futuro assetto europeo, del necessario legame esistente fra democrazia e principio nazionale.
Scrive, dunque, il Donati (in: G. Donati, «Scritti politici» (Roma, Edizioni Cinque Lune, 1956, pp. 303-315):
«Le vittorie serbo-russe, sempre più incalzanti e decisive, sugli austro-ungheresi vogliono essere esaminate dal punto di vista italiano per via egli incalcolabili effetti che sono per produrre, forse immediatamente,nella crisi interna dell’Impero, nelle eventuali pretese del panslavismo russo e nei diversi irredentismi, italo-serbo-rumeno, scoppiettanti ormai come altrettanti focolari di rivolta lungo tutto il confine meridionale della Monarchia, dalla punta ad est nella Bucovina, fino alla punta ad ovest nel nostro Trentino.
Se è verro che l’accortezza degli uomini di stato austriaci ha giudicato essere questa guerra, e soltanto questa guerra - ma vittoriosa, l’estremo rimedio all’interno dissolvimento del regno, è chiaro che le sconfitte toccate nella Galizia e sul Jadar sono da considerare veramente come il principio della fine. Per queste sconfitte i Russi hanno ormai libero il passo attraverso la Bucovina e la Transilvania, se non potranno con marce più dirette, raggiungere senz’altro il cuore del’Impero nemico; mentre i Serbi si sono aperta la strada maestra per occupazione della Bosnia, attraverso la quale potranno finalmente toccare l’Adriatico.
Ma la Bucovina e la Transilvania appartengono geograficamente ed etnicamente alla Rumenia; e l’occupazione bosniaca da parte della Serbia porta di conseguenza l’assorbimento della Croazia e della Dalmazia nei confini del nuovo stato balcanico. Per l’irredentismo rumeno e italiano l’ora cominciata è quindi decisiva; come sarà decisiva per l’equilibrio interno dei Balcani e per l’equilibrio adriatico.
Perciò dobbiamo domandarci:
1) Dentro quali liniti l’Italia ha interesse alla liquidazione dell’Austria?
2) Quale contegno dovremo assumere di fronte al’avanzata serba bell’Adriatico, avendo specialmente riguardo alla Dalmazia, all’Istria e alla Venezia Giulia con Trieste?
3) Che importanza hanno nell’equilibrio interno dei Balcani le vittorie e gi ingrandimenti territoriali serbo-russi, e le pretese rumene sulla Bucovina e sulla Transilvania, e quelle bulgare sulle province macedoni della Serbia meridionale?
4) Quale il dovere nazionale dell’Italia verso il Trentino?
Vediamo di spiegare, modestamente, questa difficile matassa di questioni, e discutiamo ancora una volta – l’ultima forse – le soluzioni possibili dell’intrico da quel punto di vista nostro che, pur senza pretese, crediamo debba essere il punto di vista comune della democrazia italiana.
La “fine dell’Austria” sta diventando un facile luogo comune. Affiorano alla memoria degli stessi ostinati adoratori dello “statu quo” balcanico e danubiano certi presentimenti storici formulati venti o quaranta anni fa da Oriani e da Mazzini, presentimenti che ai volghi della cultura politica, ignari e tardi, sembrano oggi delle luminose profezie, anche se ieri essi medesimi le definivano, con una smorfia di superiorità, delle ubbie quarantottarde. Merito degli avvenimenti militari, che precipitano nel breve giro di poche ore delle crisi maturate e sospese anche per secoli:crisi di antagonismo etnico, con profondo substrato economico,- tra boemi e tedeschi, tra tedeschi e polacchi, tra magiari e rumeni, tra croati e italiani, tra italiani e austriaci - per cui la Monarchia Asburghese appare oramai come un vasto tino dove la guerra fa ribollire cento disperati mosti aspri e redolenti, con tanta inaspettata forza di fermento da rendere vana la secolare saldezza dei cerchi maestri – la burocrazia, il clero e l’esercito - e da far sembrare insulso espediente il classico principio del “divide et impera” in cui è riassunta tutta la sapienza e l’opera politica interna della Monarchia nell’ultimo secolo.
Non posiamo indugiarci a rilevare gli elementi sintomatici e dinamici di questa crisi, già di per sé evidentissima dopo i crescenti rovesci militari. Noi dobbiamo soltanto indagare dentro quali limiti l’Italia ha interesse alla liquidazione del’Austria.
Si va dicendo a questo proposito che l’Austria è per noi l’antemurale che arresta o almeno raffrena le precipitose valanghe pangermanista e panslavista, dirette verso l’Adriatico. Gli avvenimenti odierni starebbero proprio a significare questo compito? E la politica degli ultimi anni, culminata fatalmente con questa guerra, dimostrerebbe da parte dell’Austria l’attitudine e la tendenza a tanta missione? Francamente rispondiamo di no. Se negli ultimi 30 anni il pangermanesimo ha potuto dimostrare apertamente le sue mire e la sua tendenza ad aprirsi un varco diretto verso l’Adriatico e nella penisola Balcanica, l’ha fatto rimorchiando l’Austria all’avanguardia delle sue pretese. Nel Trentino (e lo spiegheremo meglio più avanti) l’Austria ha fatto una provincia di conquista germanica. La ferrovia del Brennero rappresenta lo schema grafico di questo fenomeno: da Trento si risale ad Innsbruck e da qui, invece di proceder come parrebbe logico, verso Vienna, si va direttamente a Monaco. Nella Balcania è successo altrettanto. Il famoso corridoio del Sangiaccato, che doveva contenere in terra austriaca la ferrovia da Serajevo a Salonicco, stava quasi più a cuore agli statisti di Berlino che a quelli di Vienna, rappresentando esso la strada maestra della Germania verso il mare di Oriente. Le maggiori opposizioni alla ferrovia Adriatico-Danubiana, che dovrebbe congiungere la rete dei traffici balcanici ai porti dell’Albania, stabilendo un movimento commerciale favorevole alle nostre coste pugliesi e liberando i popoli balcanici dalla servitù del denaro tedesco, venivano precisamente da Berlino, e Vienna se ne faceva interprete diretta. Inoltre questo fenomeno può dirsi addirittura generale, se si pensa in quante maniere la politica austriaca ha favorito l’intedescamento della Boemia contro gli czechi e della Galizia contro i polacchi. Dovunque il danaro germanico ha preteso di dominare a dispetto di ogni prevalenza etnica, la guerra condotta e vinta a furia di milioni e di compromessi commerciali ha dimostrato nell’Austria un’attitudine e una tendenza molto spiccata: favorire in tutti i modi la Germania. E questa tendenza si è dimostrata nel suo eccesso criminoso, quando l’Austria ha provocato, d’accordo con la Germania che voleva attaccare la Russia con un pretesto qualunque, la resistenza della Serbia, la resistenza della Serbia, ed ha determinato, contro tutti gli interessi propri, la guerra d’Europa. Vienna va dunque considerata pacificamente la succursale avanzata di Berlino.
E contro il panslavismo? Per noi italiani il filo slavismo dell’Austria è ormai un luogo comune. Non solo gli slavi hanno predominato sempre nella politica viennese insieme ai tedeschi, ma vi hanno predominato contro di noi. Nella Venezia Giulia, nell’Istria e nella Dalmazia, l’Austria ha sopraffatto con tutti i mezzi legali e illeciti l’elemento italiano, accanendogli contro l’elemento slavo, favorendolo artatamente nelle sue mire di predominio, sostituendolo magari con l’arbitrio sistematico all’elemento nostrano. Se il nostro irredentismo adriatico ha una storia dolorosa, l’ha precisamente in forza di questa tendenza dell’Austria a favorire dovunque le pretese slave, e gli episodi capitali di questa politica sono così gravi e in parte così recenti che possiamo dispensarci dal ricordarli.
Ma quello che più importa per distruggere ogni residuo di fede nella presunta resistenza austriaca al panslavismo consiste nella cosiddetta esistenza trialista e nella politica tenuta nel 1897 e dopo l’accordo di Mürsteg [2 ottobre 1903: accordo austro-russo per la sistemazione dei Balcani in caso di scomparsa della Turchia europea]. Si attribuiva al defunto Arciduca ereditario il proposito di cingere la terza corona della Slavia danubiana: ruteni, croati, sloveni e bosniaci sarebbero stati alla pari degli austriaci e degli ungheresi, avendo un regno autonomo proprio, un proprio parlamento e una propria amministrazione. Gli irredentismi dei vari settori orientali e meridionali invece di risolversi verso gli Stati naturali limitrofi della Romania e della Serbia, sarebbero stati assorbiti e concentrati in un unico nuovo Stato Asburghese, stato prettamente slavo, e, data la sua estensione, la densità crescente della popolazione e le sue attitudini economiche, era destinati a diventare il più forte della Monarchia, e sull’Adriatico avrebbe rappresentato l’avanguardia dello slavismo. D’altra parte, l’accordo di Mürsteg, concluso tra l’Austria e la Russia, in contrasto con le aspirazioni rivendicatrici e autonomistiche dei popoli balcanici, stabiliva la divisone della Balcania Turca in due sfere d’influenza, una russa e l’altra austriaca; metteva cioè la Russia in condizioni di poter avanzare attraverso la penisola d’accordo con l’Austria, ottenendo da questa quanto aveva domandato invano alla Bulgaria e alla Romania.
L’irruenza del’irredentismo serbo, la tenacia di quello romeno e soprattutto la guerra turco-balcanica hanno scompigliato il piano viennese e convertito in un principio irresistibile di disgregamento quel filo slavismo asburghese che doveva all’Austria il primato su tutti gli Slavi in concorrenza con la Russia e contro tutte le aspirazioni dei Balcani. Sarebbe quindi più logico ricordarsi, non già della presunta resistenza austriaca al presunto pericolo russo e germanico, ma dell’effettivo pericolo immediato del panslavismo e del pangermanismo dell’Austria. Di guisa che a noi oggi sembra coerente e legittimo il voto di quegli italiani che affrettano la liquidazione del’Austria, atteso che - e lo spiegheremo fra poco - la spartizione delle province austriache orientali e meridionali fra la Russia, la Rumenia e la Serbia si farebbe in virtù di una legge naturale d’attrazione e di equilibrio, e la fine dell’Austria attuale significherebbe un colpo mortale all’imperialismo tedesco. La monarchia dovrà limitarsi alle province astro-magiare, dopo aver restituite alla Polonia, alla Romania, alla Serbia e ala Italia le sparse membra irredente. Soltanto con questa riduzione ai propri termini naturali l’Austria potrà avere un compito benefico di equilibrio fra gli Stati danubiani, altrimenti sarà, come è al presente, il pretesto e la causa elle ire nazionali fra i cento popoli che essa ha soggiogati senza saperli dominare.
Ma l’avanzata della Serbia fino all’Adriatico quali conseguenze avrà per l’Italia? Una conseguenza immediata fatale: la conquista definitiva della costa dalmata agli Slavi. Ma appunto perché fatale è vano volerla deprecare con delle pretese di conquista. Gli Italiani in Dalmazia sono un’esigua minoranza, e dovranno cedere prima o poi alla stragrande maggioranza slava. Ma che perciò? È forse un pericolo mortale quello che ci minaccia? Non facciamo del sentimentalismo. Le leggi naturali sono santamente irresistibili. Gli slavi hanno bene il diritto di affacciarsi all’Adriatico, e ne hanno soprattutto la forza. Tocca a noi di rinunciare alle stolte pretese e di non provocare gli urti. In fondo, il bene nazionale comune dei Serbi e degli Italiani, richiede una intesa cordiale profonda. Essa è già incominciata e ha dato ottimi frutti, specialmente dopo il trattato commerciale del 1907. Il Gayda [cfr. “Gli Slavi della Venezia Giulia, Milano, 1915], studioso acuto e sereno dei problemi italiani d’oltre confine, lo ha detto chiaramente. Gli slavi devono comprendere che, fuori della difesa delle loro terre, gli italiani non hanno che un programma di cultura e di pace: nessuna guerra agli Slavi, nessuna usurpazione, ma un tranquillo accordo di idee, di energie spirituali. Gli Italiani possono essere, assicurati nel loro possesso nazionale, i collaboratori del risorgimento nazionale e della emancipazione politica degli slavi del sud. Non sta nella loro missione di far da gendarmi contro la risurrezione degli altri popoli: non è nel loro interesse, né nella loro tradizione. Vogliono solo conciliare gi interessi del loro nazionalismo con quelli del nazionalismo serbo-croato. Ciò vale per i rapporti fra gli italiani e gi slavi, in Austria, come per quelli tra il Regno d’Italia, la Serbia e la Russia”. Ammonimento prezioso in questo momento. Prezioso e nient’affatto utopistico. La nostra politica austriacante nel periodo della guerra balcanica spezzò purtroppo delle file tenaci d’accordi italo-slavi, che adesso potrebbero servirci a tessere una tela più compatta d’amicizia definitiva coi serbo-croati. Il Governo di Vienna ci ha inimicati gli slavi, e la stolta prevenzione triplicista dell’Austria necessaria per frenare gli slavi, ha compiuto il gioco velenoso. La guerra attuale può e deve sventare l’insidia. Perciò noi sostenemmo fin dal primo momento la necessità italiana di romperla con l’Austria per aiutare la Serbia nelle sue legittime aspirazioni.
Ma le basi del futuro accordo italo-serbo non saranno saldamente gettate se non si risolve lealmente da entrambe le parti il problema dell’Istria della Venezia Giulia. Per l’Istria noi abbiamo sostenuto il dovere da parte nostra di rispettare il diritto del popolo ungherese ad avervi un proprio sbocco commerciale sull’Adriatico. È una esigenza conforme alla giustizia, alla libertà e al’interesse economico e politico nostro e di quel paese. Con questa concessione potremmo facilmente trovare negli ungheresi degli alleati fedeli contro le eventuali pretese egemoniche della Serbia; e questo accordo potrebbe giovarci anche contro il pericolo di una alleanza austro-serba ai nostri danni.
Per la Venezia Giulia, cioè per la provincia triestina, riaffermiamo il concetto di Trieste porto e Stato libero, come Amburgo in Germania. Ogni egemonia politica sia italiana sia slava porterebbe con sé gli inconvenienti manifestatisi con l’egemonia tedesca. Il regime della libertà e dell’autonomia creerebbe invece fra gli elementi etnici prevalenti a Trieste il necessario equilibrio. Si garantirebbe così anche l’avvenire economico del porto dal rischio del boicottaggio tedesco.
Più facile è la risposta che concerne il quesito che concerne l’equilibrio interno balcanico. Coloro che si spaventano della preponderanza russa e che dichiarano che i popoli balcanici sono senz’altro ‘avanguardia della Russia czarista, ignorano quale vera tendenza ha la Russia rispetto ai mari europei e quale forza di resistenza hanno opposto gli Stati balcanici, la Romania specialmente, contro l’invadenza russa negli affari e nelle questioni della penisola. La Russia tende al mar Nero; quella è la sua via per l’Oriente turco e per il Mediterraneo. L’attendono laggiù le forze di tutta l’Europa in contesa. Se il pericolo russo esiste, esiste per noi, ma anche per l’Inghilterra e per la Francia, e contro una simile coalizione la Russia sarebbe impotente. Né vale insistere sulla cosiddetta affinità slava. l’affinità slava vale meno ancora dell’affinità latina. è un sentimento di ordine intellettuale e di ben scarso dinamismo politico. Intanto la storia, anche recentissima, prova all’evidenza che gli slavi balcanici sono tutt’altro che russofili. Lo slavismo è appena un sentimento religioso, vago, senza contenuto materiale. I serbi isolati e minacciati dall’Austria e dalle gelosie degli altri Stati limitrofi hanno potuto talvolta appoggiarsi alla Russia, ma non ne hanno giammai assecondate le pretese. L’accordo di Mürsteg fallì nel suo intento, intento ultimo perché la Serbia ostacolò con egual tenacia l’Imperatore e lo Czar, dando saldezza e forza alla lega balcanica contro la Turchia. E oggi la Russia fa la guerra non già in favore della Serba, ma nell’interesse proprio contro la Germania.
D’altronde, la partecipazione probabile della Romania alla guerra per l’occupazione della Transilvania viene ad arrestare la marcia russa diminuendo il peso preponderante delle sue vittorie per il giorno della pace. Una più grande Romania vuol dire una più salda diga contro le eventuali pretese della Russia. Ma l’intervento romeno, in quanto indirettamente favorisce la Serbia perché diminuisce la resistenza austriaca sul proprio settore di guerra, può decidere la Bulgaria a prendersi parte della Serbia meridionale. Eccola revisione del trattato di Bucarest, conforme ad un principio di equilibrio interno nella Balcania che dovrà senza dubbio favorire la buona armonia politica ed economica degli Stati fra cui la discordia fratricida portò motivi di rancore e di gelosie fatali. Noteremo frattanto che un più omogeneo asseto degli Stati balcanici promette maggiori garanzie di tranquillità allo stato di Albania, che l’Italia, giustamente, vuole autonomo contro qualsiasi pretesa.
Resta la questione del Trentino. Diciamo subito che in caso di sfacelo dell’Austria, il Trentino deve tornare all’Italia. Per noi rappresenta un dovere e un interesse nazionale imprescindibile. La soluzione delle sue difficoltà economiche dipendono [sic] dal’unione all’Italia. Da quella parte il nostro confine militare non è sicuro se non si porta fino alle Alpi del Brennero.
Il Trentino sotto l’Austria significa - l’abbiamo già detto - la porta settentrionale d’Italia nelle mani della Germania. Già ne abbiamo l’indice grafico nella ferrovia del Brennero. Lo sterminato numero di alberghi e di imprese tedesche che assediano il Gardese confermano la tendenza pangermanista. Il numero degli emigranti tedeschi nel Trentino cresce di anno in anno in maniera impressionante mentre l’elemento italiano è costretto per le tristi condizioni economiche a lasciare il paese natale. E come crescono di numero questi tedeschi, così aumenta il loro spirito aggressivo e gli espedienti e i mezzi più decisivi e irresistibili di germanizzazione. Di quella plaga, che ormai essi considerano come un appendice dello Stato bavarese rivolta verso le valli dei fiumi adriatici italiani. Non si può parlare di un pericolo immediato, ma certo di un sintomo dinamico evidentissimo.
Bisogna dunque scongiurarlo in tempo e energicamente. Ma per far questo non c’è che un mezzo: conquistare al’Italia la provincia Trentina. Il suo generoso e fedelissimo popolo che aspetta, e guarda con ansia tragica l’estenuata vena del suo sangue più vivo sgorgare nuovo umore per la maledetta ambizione d’una patria non sua. È verro, ancora 15.000 trentini l’Austria ha voluto immolare contro i Russi irrompenti, come se il nostro sangue potesse cementare la sua disgraziata compagine.
Non voglio fare della retorica. Ripugna al nostro senso morale, e soprattutto all’ansia invincibile che forza la volontaria rigidezza di questa attesa. Che cosa dunque attende l’Italia? Non sappiamo. Per nostro conto riteniamo che i suoi supremi interessi - morali, nazionali ed economici - la dovranno spingere fatalmente ad affrettare - con la guerra - la liquidazione dell’Austria. Che questa liquidazione sia imminente è ormai indubitabile. Ma nella nostra assenza e nel nostro disinteresse, Russia, Serbia e Romania se la spartiranno come una spoglia di conquista, senza riguardo ai terzi, che siamo noi. E questo non deve essere assolutamente. Non vogliamo la gloria delle facili conquiste., per se stesse, ma nemmeno possiamo patire lo scorno e il danno immenso della cosiddetta politica delle mani nette che ricorda proprio le mani nette di Pilato. Decidiamoci ad un civile proposito. Certo, quando tre settimane fa intuendo felicemente gli eventi, l’amico Vaina scriveva qui: la guerra necessaria - egli anticipava una conclusione che oggi devo far mia incalzando: è l’ora d’osare.»
Come si vede, la riflessione politica di Giuseppe Donati e gli argomenti coi quali sostiene la necessità dell’intervento italiano in guerra rimangono sul terreno strategico-territoriale e non investono la questione ideologica.
Egli non descrive la guerra come uno scontro fra le democrazie e le autocrazie, come fanno la maggior parte degli interventisti democratici: forse per riguardo alla natura autocratica del governo russo, forse perché vede la guerra in corso in termini classici e gli sfugge l’importanza primaria, in essa, della dimensione ideologica.
Per Donati, l’Austria-Ungheria è uno Stato dispotico e aggressivo, ma intimamente precario e poco vitale, tenuto in piedi essenzialmente dai tre pilastri tradizionali dell’esercito, della burocrazia e del clero. Gli sfugge il fatto che possedere un esercito comune, una burocrazia efficiente e un clero patriottico, per uno Stato plurinazionale di oltre 50 milioni d’anime, è già di per sé un sintomo di vitalità e di coesione non comuni.
Egli ne auspica, e ne prevede, un drastico ridimensionamento, pur senza far suo il mazziniano: «Austria delenda», «l’Austria deve essere distrutta». Così com’è, essa gli appare come una creazione innaturale, capace soltanto di creare squilibri e inimicizie fra i popoli dell’Europa centrale, sia dentro che fuori i suoi confini. Per lui, essa si regge unicamente in base alla vecchia massima del «divide et impera»; non gli viene in mente che, se è stata capace di far convivere in pace dieci popoli diversi, e di tenerli uniti nell’epoca dei nazionalismi esasperati, forse essa svolge una funzione storica naturale ed utile, e non puramente artificiale.
Nel progetto trialista del defunto Francesco Ferdinando egli non vede altro che una minaccia per l’Italia, in quanto la ventilata terza parte della Monarchia asburgica, a componente slava, sarebbe, per lui, proprio quella capace di incanalare le energie del panslavismo e dirigerle verso la Venezia Giulia e l’Adriatico. E, poiché constata - a ragione - che l’amministrazione austriaca già da anni favorisce l’elemento slavo rispetto a quello italiano a Trieste, in Istria e in Dalmazia, la situazione non potrebbe che peggiorare se gli Slavi dell’Austria si rafforzassero con la creazione di una terza corona asburgica.
Anche la sua diagnosi della politica austriaca come succursale di quella germanica appare un po’ semplicistica: se Vienna non è altro che un avamposto del pangermanismo di Berlino, possibile che egli non veda come una politica aggressiva di rivendicazioni territoriali, da parte della Serbia, della Russia, della Romania e della stessa Italia, non faccia che spingerla sempre più in quella direzione, inducendola a vederre solo nell’alleanza «nibelungica» con l’Impero tedesco una garanzia di sopravvivenza nel prossimo futuro?
Ancora.
Donati afferma che, se l’Italia non interviene in guerra, e non interviene al più presto, rischia di rimanere esclusa da ogni rivendicazione territoriale. Afferma però anche che i diritti nazionali sono evidenti, e cita ad esempio il diritto della Romania alla Transilvania e alla Bucovina (senza tener conto della composizione plurietnica di entrambe quelle province), a dispetto dell’avanzata militare russa in quel settore, dopo l’esito della duplice battaglia di Lemberg Ora, se tutto ciò per cui l’Italia deve entrare in guerra contro l’Austria è il Trentino, chi oserà negarglielo al tavolo della pace, appunto in base al principio di nazionalità?
L’argomentazione del Donati appare, insomma, contraddittoria. Da un lato dice che l’Italia non può chiedere che il Trentino e, forse, una parte dell’Istria; dall’altra, sostiene che solo entrando in guerra l’Italia potrà riceverle, indipendentemente dalla volontà di quelle popolazioni. Aggiunge che l’Austria dovrà continuare ad esistere, ma solo nella sua componente tedesca e magiara; non spiega, però, come questa parte potrà essere separata dalle altre, data la composizione etnica a mosaico di quasi tutte le province di confine della Duplice monarchia. E, soprattutto, non si chiede come questo Impero, ridotto a dimensioni assai modeste, potrà sopravvivere, senza più uno sbocco al mare; e che cosa potrà evitare che esso si getti definitivamente nelle braccia della Germania.
Donati, poi, commette un tipico errore di sopravvalutazione dei piccoli Stati che dovrebbero essere beneficiari della disgregazione austriaca, a cominciare dalla Romania. Egli pensa che una Grande Romania sarebbe un utile baluardo contro le velleità espansionistiche della Russia: ragionamento alquanto ingenuo, come i fatti si incaricheranno di dimostrare.
Della Polonia, come già osservato, non parla, tradendo così l’ispirazione democratica e mazziniana del programma punitivo nei confronti dell’Austria: giacché indebolire l’Austria assolutista e «carceriera di popoli», per ingrandire la Russia ancor più assolutista e imperialista, appare, dal punto di vista democratico, un autentico controsenso.
Quanto alla Russia, egli sostiene che la sua spinta espansionistica è diretta più verso il Mar Nero che verso il Mediterraneo; ma, di nuovo, non spende una parola sulla questione centrale: è legittima, è sostenibile la rivendicazione russa dell’annessione di Costantinopoli? E, se la Russia si insediasse sul Bosforo, davvero il deterrente di una coalizione anglo-franco-italiana potrebbe tenerla lontana dal Mediterraneo?
E si rende conto, il Donati, che una ulteriore espansione russa nel Mar Nero avrebbe portato, inevitabilmente, allo scontro con la Turchia - che, di fatto, avrà luogo in novembre - e sollevato una serie di drammatici problemi politici e strategici, culminando nella liquidazione dell’Impero Ottomano e passando per il calvario delle minoranze cristiane nel Vicino Oriente, prima fra tutte quella degli Armeni?
Sfuggono poi, all’analisi del Donati, le cause economiche della guerra, benché in altri articoli dell’epoca egli vi abbia prestato maggiore attenzione. Nulla egli dice della Francia, della Gran Bretagna, del probabile atteggiamento degli Stati Uniti d’America; in breve, gli sfugge la dimensione veramente mondiale della guerra e gli sfugge la scarsa coerenza di voler spingere l’Italia in una guerra mondiale per rivendicare una piccola provincia, e sia pure di alto valore ideale, quale il Trentino, come se si trattasse di uno dei soliti conflitti limitati dell’Ottocento.
È vero: ben pochi intellettuali, e perfino ben pochi statisti, nel settembre del 1914, prevedevano che la guerra sarebbe durata ancora più di quattro anni; che avrebbe coinvolto ogni risorsa finanziaria, industriale, commerciale, fino all’esaurimento; che gli enormi sacrifici da essa imposta a tutti, vincitori e vinti, avrebbe fatto nascere fra i popoli una diffusa aspirazione ad un ordine politico e sociale più giusto, capace di dare un senso a tanti lutti e distruzioni.
Non si può fare di questo, pertanto, un appunto al Donati; ma bensì del suo silenzio riguardo agli aspetti sociali della guerra, in un Paese ancora sostanzialmente povero come l’Italia; e, più ancora, del suo silenzio circa la dimensione etica della guerra. Lui, cristiano ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, poteva parlare della necessità dell’entrata in guerra dell’Italia con gli stessi argomenti di un interventista «laico», per il quale la religione è ininfluente in simili questioni?
Certo: non poteva sapere che la guerra avrebbe provocato 8,5 milioni di morti, dei quali oltre 600.000 sarebbero stati italiani. Ma che fosse un gigantesco bagno di sangue, le battaglie di Francia e di Galizia, in settembre, già lo avevano ampiamente mostrato.
Possibile che ciò, per un cristiano, non volesse dire proprio nulla?
È questo silenzio assordante, nell’analisi delineata dall’articolo del Donati, che lascia perplessi.