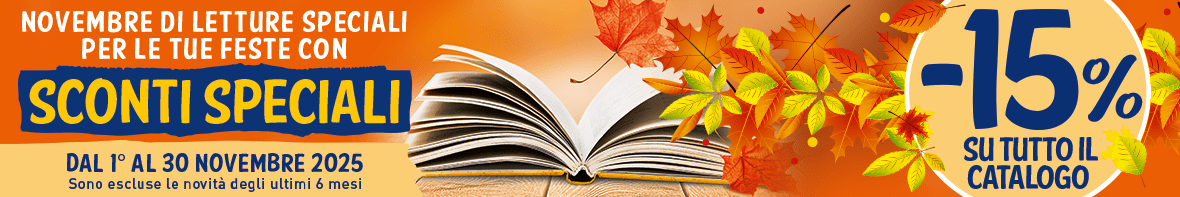La psiche dell’Iraq attraverso il prisma della Green Zone
di Anthony Shadid - 11/06/2010

Il termine è stato coniato dall’esercito americano. Ma, a differenza di altri – quali, entry control points, i posti di controllo per l’ingresso – la parola è riuscita a restare impressa nell’immaginazione comune. “Green Zone” - Zona Verde - è sempre sembrato dire molto, qui e all’estero. Era l’avamposto imperiale di un’occupazione, o la cittadella di un governo che non è mai stato davvero sovrano – bastione o camera sterile, rifugio o irrealtà.
Muwafaq al-Taei, architetto che un tempo abitava lì, pensa alla descrizione prima di scegliere la sua definizione. “ Uno stato d’animo”, lo considera Taei.
Domani l’esercito americano si ritirerà formalmente dagli ultimi nove checkpoint che ha controllato in questa trasandata distesa di territorio di cui aveva segnato i confini dopo aver rovesciato Saddam Hussein nell’aprile del 2003. La mossa, in gran parte simbolica, è l’ennesima nel corso di un anno pieno di questi eventi, mentre gli Stati Uniti si apprestano a lasciare solo 50.000 soldati, ritirando tutto il resto delle truppe entro la fine dell’estate.
“Un altro capitolo”, dice il generale Stephen Lanza, portavoce delle Forze Armate statunitensi.
Ma in questi giorni anche l’atmosfera mutevole riguardo alla Green Zone dice qualcosa sull'Iraq, dove il caldo dell’estate aumenta esponenzialmente come le frustrazioni delle persone. Il Paese è ancora privo di un governo, quasi tre mesi dopo che gli elettori si sono recati alle urne per sceglierne uno. La gente suda mentre i politici parlano (e parlano e parlano), e la Green Zone – che per lungo tempo è stata un’idea quanto un luogo effettivo - si trasforma in un altro simbolo in un Paese che non è ancora uno Stato a tutti gli effetti.
“È sempre stato il luogo del potere di qualcuno”, dice Taei.
La striscia di terra lungo il Tigri incarna l’autorità fin dai tempi in cui Re Ghazi cercava sostegno parlando ai suoi sudditi dalla sua stazione radio all’ al-Zuhur Palace, che lui stesso fece costruire nel 1936. Oggi ci sono molti più palazzi, sebbene i vecchi nomi siano caduti in disuso. Alcuni chiamano ancora la zona Karradat Mariam, in onore di una santa del posto sepolta dietro le sue barricate di cemento. Pochi ricordano il nome Quartiere legislativo, una delle sue prime incarnazioni.
Quasi tutti la conoscono con il nome che gli hanno dato gli americani.
“Benvenuti nella Green Zone”, recita un cartello scritto in inglese e tradotto in arabo.
Il posto conserva una atmosfera americana, dove gli agenti della CIA un tempo bevevano nei loro bar arredati in rattan e i bambini iracheni, con un inclinazione per i memorabilia, vendevano i ninnoli di Saddam Hussein (gli orologi con il suo ritratto nello sfondo del quadrante erano i preferiti).
Lattine vuote di bevande energetiche come Wild Tiger e TNT Liquid Dynamite ricoprono le strade. Container per le spedizioni arrugginiti si contendono lo spazio con le barricate piene di sabbia avvolte in tele ormai ridotte a brandelli. I cartelli sono ancora in inglese: “Strettamente proibito fermarsi”, recitano le onnipresenti barriere di cemento.
Green - Verde è ancora la forma abbreviata preferita per definire il luogo, anche in arabo. Che a volte crea confusione, poiché un altro quartiere di Baghdad porta lo stesso nome.
Un’inevitabile domanda che spesso segue è : “La loro verde o il nostro verde?”
Ma, come sottolineava Taei, attraversando in macchina la Green Zone negli ultimi giorni, passando davanti ad alcuni dei palazzi alla cui costruzione ha collaborato lui stesso, “ La storia dell’Iraq è qui”.
“Ogni singolo edificio ha una storia”, dice, in quanto simbolo o per altri motivi.
Taei indica dove - nel 1958 - un Primo Ministro deposto aveva cercato di sfuggire a quelli che gli stavano dando la caccia vestito da donna. Lancia uno sguardo al luogo in cui i residui della monarchia erano stati giustiziati il giorno precedente. Indica il teatro dove Hussein, consolidando il suo potere nel 1979, aveva letto ad alta voce i nomi di presunti appartenenti al una quinta colonna davanti a un’assemblea. I cospiratori sospettati erano stati rimossi uno ad uno dai posti in cui erano seduti.
Attraverso il finestrino, guardava i palazzi – Bayraq, Salam, e gli altri - ancora distrutti dai bombardamenti americani, emblemi del rovesciamento del governo, un tempo come oggi.
“Quello che ha costruito Saddam”, dice Taei.
La Green Zone resterà indelebilmente un artefatto americano dell’occupazione, ma ancora oggi porta tuttora il segno di Saddam Hussein. Le sue iniziali in arabo restano in rilievo sui muri di pietra, l’incisione di piastrelle sulle entrate maestose ad arco o le curve dei cancelli in ferro battuto. Le monumentali spade dell’Arco della Vittoria, impugnate da mani riprodotte sulla base del calco delle stesse mani di Saddam, stanno per essere demolite solo ora. Il minareto a otto facce, che Hussein considerava il suo stile personale, è ancora in piedi accanto a una moschea costruita con le forme di una lezione di geometria per bambini.
In questo, la Green Zone è forse un’altra metafora, che va oltre quel retaggio del potere americano. Gli Stati Uniti sono riusciti a fare piazza pulita del governo di Saddam. Ma quello che questo evento ha contribuito a costruire al suo posto resta appena abbozzato, disseminato dalle rovine del passato.
“In strada ci sono le tenebre, solo Dio è la nostra guida”, dice un negoziante che dice di chiamarsi Abu Hussein, in un negozio dall’altro lato della strada di uno degli ingressi alla Green Zone.
Quello che voleva dire è che nessuno sa cosa accade lì dentro.
“Non hanno sentito neanche una lamentela da parte delle persone”, aggiunge, seduto davanti a un ventilatore che manda aria calda. Nessun funzionario ha prestato la minima attenzione ai cittadini qui”.
Lui invece di lamentele ne ha più di una. Lo stesso vale per Taei e per quasi tutti quelli che sono in strada – dal traffico che si aggroviglia a causa dei checkpoint lungo gli ingressi della Green Zone, alle richieste di badge, o badjat , per avere accesso nelle strade interne che sono larghe abbastanza per una parata militare.
Alcune delle stesse rimostranze si fecero sentire nel 2003, quando arrivò l’estate e i funzionari americani cercavano maldestramente di destreggiarsi fra blackout, mancanza di acqua, crimine, e violenze, ricordando contemporaneamente agli iracheni che ora avevano una parvenza di libertà.
Questa volta le lamentele sono contro il Primo Ministro Nuri Kamal al Maliki e altri funzionari che risiedono nella Green Zone. Egoista è un insulto tipico; altri sono più pungenti. Nessuno si aspettava che avrebbero formato un governo presto. Investitori ben informati ultimamente hanno fatto capire che si potrebbe dover aspettare fino a ottobre.
“Se sei un vicino di Maliki, allora forse puoi trovare lavoro”, dice ironicamente Faruk Talal, 27enne impiegato in un negozio di cellulari. “Altrimenti non lo trovi”.
In fondo alla strada, Haider Kadhem definisce la zona “un altro Paese”.
“Siamo un unico Iraq, ma si può affermare che la Green Zone è un altro Iraq”, dice. “Un badge è un passaporto, e se non hai il passaporto, non puoi entrare in quel Paese”.
The New York Times, 31 maggio 2010
(Traduzione di Arianna Palleschi per Osservatorio Iraq)