Il Fascismo tra ignoranza storica e invettiva ideologica: prima di parlare sarebbe meglio studiare
di Fabrizio Fratus - 26/07/2025
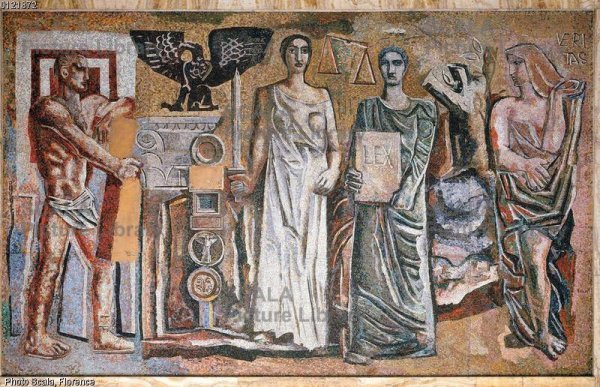
Fonte: Il Talebano
Il Fascismo tra ignoranza storica e dibattito ideologico: perché prima di parlarne bisognerebbe leggere Sternhell (e De Felice)
In un modo o nell’altro, si torna sempre lì: fascismo. Che si parli di politica estera, di dinamiche culturali, di leggi repressive, o anche solo di etichette buone per insultare l’avversario, il fascismo riemerge come spettro onnipresente del discorso pubblico italiano. L’ultima vicenda riguarda la R ussia, che ha deciso di mettere al bando il fascismo come “ideologia estremista”, scatenando un’ondata di commenti e dibattiti — alcuni legittimi, altri francamente imbarazzanti. Il problema non è tanto l’uso (o l’abuso) del termine. Il problema è che in Italia se ne continua a parlare senza conoscerlo. Peggio ancora: se ne parla male, con superficialità, retorica, approssimazione gridando di continuo al “ritorno del fascismo” per ogni forma di disaccordo politico, svuotando la parola del suo significato storico concreto. Il dibattito è viziato dalla mancanza di una base culturale solida. Il primo passo per uscire da questa confusione è rileggere chi il fascismo l’ha studiato davvero. Uno su tutti: Renzo De Felice, lo storico italiano che più di ogni altro ha dedicato la vita a studiare l’esperienza fascista nella sua complessità. Il suo lavoro monumentale su Mussolini — in otto volumi — ha segnato uno spartiacque nella storiografia mondiale, anche perché ha saputo distinguere tra fascismo movimento e fascismo regime, tra ideologia originaria e apparato di potere. Per De Felice il fascismo non è stato un semplice “male assoluto”, ma un fenomeno politico e sociale con radici moderne, legato alla crisi della democrazia liberale e al bisogno di un’alternativa totalizzante. Non giustifica, non assolve, ma spiega. E nel farlo, toglie alla discussione pubblica l’alibi dell’ignoranza. In Italia, De Felice è letto pochissimo. Ancora oggi viene liquidato da alcuni come “revisionista” (spesso senza sapere cosa significhi), mentre altri ne citano il nome senza aver mai aperto una pagina dei suoi testi. C’è poi un altro autore fondamentale, ancora meno conosciuto al grande pubblico italiano, ma essenziale per chi voglia capire da dove nasce davvero il fascismo. Si tratta di Zeev Sternhell, storico israeliano, ebreo, marxista, docente all’Università Ebraica di Gerusalemme. Sternhell ha avuto il coraggio, supportato da decenni di ricerca, di sostenere che il fascismo non è nato come reazione conservatrice, ma come eresia rivoluzionaria della sinistra. Nel suo capolavoro, Né destra né sinistra, Sternhell mostra come il fascismo sia nato nel cuore dell’Europa, non come nostalgia dell’ordine monarchico, ma come risposta moderna e totalitaria alla crisi del liberalismo e del marxismo. Il fascismo – sostiene Sternhell – ha attinto dalla sinistra il culto della mobilitazione di massa, il rifiuto dell’individualismo borghese, l’idea di palingenesi collettiva. Al tempo stesso, ha rifiutato la democrazia e l’uguaglianza, fondandosi su una nuova visione patriottica e organica della società. La sua tesi è forte, discussa e molto seria. Meriterebbe di essere letta prima di ogni polemica da talk show o da social network. Sternhell non offre semplificazioni, ma strumenti: ci invita a smettere di pensare il fascismo come un fenomeno esterno alla modernità. E ci ricorda che ogni uso improprio del termine è un passo verso la sua banalizzazione.
Perché solo in Italia il dibattito sul fascismo scivola regolarmente nel ridicolo? Perché il nostro Paese non ha mai fatto davvero i conti con la propria storia. Il risultato è un dibattito pubblico inquinato da tifoserie, dove si può dare del “fascista” a chiunque, ma dove nessuno è più in grado di spiegare cosa sia davvero il fascismo.
Se davvero vogliamo affrontare seriamente la questione del fascismo, dobbiamo smettere di usarlo come insulto generico o come feticcio ideologico. Dobbiamo cominciare a studiarlo. E per farlo dobbiamo leggere De Felice, Sternhell, Gentile, Mosse. Non perché siano infallibili, ma perché ci obbligano alla complessità. Ci ricordano che la storia non è un’arma da brandire, ma una disciplina da rispettare. Solo così potremo uscire dalla trappola in cui siamo finiti: quella di un Paese che parla sempre di fascismo senza sapere più cosa significa.

