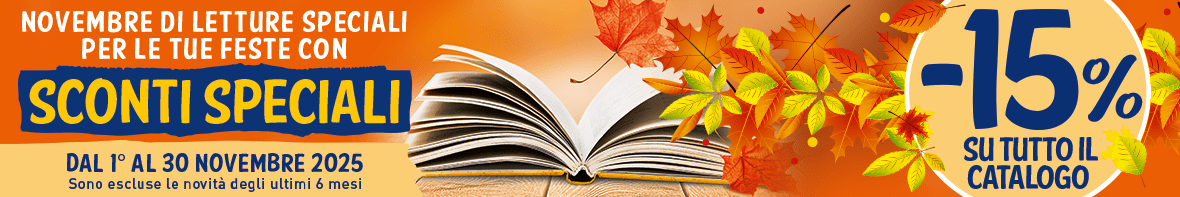Arabia Saudita: Un perfetto controesempio negli annali della geo-strategia globale
di René Naba - 04/10/2010

Ancora una volta recidiva nella diversione, l’Arabia Saudita incoraggiò Saddam Hussein ad andare in guerra con l’Iran per contenere la minaccia del fondamentalismo sciita, deviando la potenza irachena dal campo di battaglia arabo-israeliano. In un nuovo tentativo di destabilizzare la Siria, il principale alleato arabo dell’Iran, Arabia favorì una rivolta dei Fratelli Musulmani repressa brutalmente dai siriani, ad Hama, nel febbraio 1982, a quattro mesi dall’invasione israeliana del Libano, fomentata da un tandem composto da primo ministro israeliano Menachem Begin e da Bashir Gemayel, il leader della milizia cristiana libanese.
L’Arabia Saudita, il nemico più intransigente di Israele, in teoria, aveva effettuato la più grande diversione della lotta araba, sostenendo l’Iraq contro l’Iran nella guerra convenzionale più lunga della storia moderna (1979 – 1988), deviando il colpo dal campo di battaglia principale, la Palestina, dirottando i giovani musulmani e arabi dal campo di battaglia della Palestina all’Afghanistan. A colpi di dollari e di Mujahidin, spesso ex detenuti nel loro paese, combatterà non contro Israele, ma a migliaia di chilometri di distanza, a Kabul, dove migliaia di giovani arabi e musulmani si batteranno per un decennio contro le forze atee comuniste, voltando le spalle, al tempo stesso, di nuovo alla Palestina, con l’incoraggiamento degli intellettuali occidentali, troppo contenti per questa opportunità. Cinquantamila arabi e musulmani si arruolarono sotto la bandiera dell’Islam, sotto la guida di Usama bin Ladin, ufficiale di collegamento dei sauditi e degli statunitensi, combatterono in Afghanistan l’ateismo sovietico in una guerra finanziata, in parte dalle petromonarchie del Golfo, con fino a venti miliardi di dollari, una somma equivalente al bilancio annuale di un quarto dei paesi membri dell’organizzazione panaraba. In confronto, i combattenti di /Hezbollah/ libanese, con un numero di molto inferiore, stimato in duemila combattenti, e con un budget ridotto rispetto a quello impegnato a finanziare gli arabi afghani, ha causato sconvolgimenti psicologici e militare più consistenti della legione islamica, nel rapporto tra le potenze regionali (6).
L’Afghanistan ha avuto una funzione trascinante sulla gioventù saudita, e i diplomatici statunitensi non cercarono di nascondere questo aspetto del conflitto. Rispondendo alla rivoluzione islamica iraniana, che minacciava la leadership saudita, la guerra in Afghanistan ha permesso all’Arabia Saudita di deviare il malcontento dei giovani dal problema palestinese, a quello anti-comunista (7), ammise, in seguito, senza mezzi termini l’ambasciatore USA a Riad, Chass Freeman. I finanziamenti per la jihad anti-sovietica sarebbero, di per sé, andati a carico del bilancio saudita, con un importo sostanzialmente pari al finanziamento concesso dall’Arabia Saudita ai “/paesi del campo di battaglia/”, Egitto, Siria e OLP (8), come contributo allo sforzo di guerra arabo.
L’Islam wahhabita, che aggregava i leader arabi sunniti in una alleanza filo-statunitense (i principati del Golfo, la Giordania, Egitto, Marocco, Tunisia), indicati dal termine popolare colla definizione sprezzante di “Arabi d’America” (A/rab Amérika/) -l’asse della moderazione per gli occidentali- si lascerà così soppiantare sul proprio terreno, l’islam combattente, dai nazionalisti islamici, il libanese Hezbollah, Hamas e la Jihad palestinesi. Feconda, l’alleanza Arabia-USA nella guerra contro l’Unione Sovietica in Afghanistan (1980-1989), ha certamente accelerato l’implosione del blocco comunista, ma col loro allineamento incondizionato con gli Stati Uniti, sostenendo il miglior alleato strategico del loro nemico principale, Israele, (nonostante l’aggiunta del disprezzo che gli statunitensi hanno mostrato verso le loro aspirazioni, i fautori dell’Islam politico, principalmente l’Arabia Saudita, l’Iran imperiale della dinastia Pahlavi, il Marocco e l’Egitto di Sadat) hanno devastato l’area, evidenziandone la sua dipendenza e il suo ritardo tecnologico. Peggio ancora, la presa statunitense in Iraq, che l’Arabia ha incoraggiato, ha promosso la nascita del potere sciita nella ex capitale dell’impero abasside, facendo planare sull’Arabia Saudita, attraverso la sua affiliazione con l’Iran di Khomeini, il rischio di cadere in una trappola sciita.
L’alleanza esclusiva dell’Islam sunnita con gli USA, che ha assicurato la pace del trono wahabita durante un mezzo secolo tumultuoso, finora non ha garantito la sua sopravvivenza futura. L’Arabia Saudita sarebbe riuscita nell’impresa di ottenere il rispetto del mondo musulmano, senza sparare un colpo verso Israele, senza ottenere alcuna concessione da parte degli statunitensi sul problema palestinese, mentre si applicano metodicamente a distruggere le vestigia del nazionalismo arabo.
Ma il regno, che aveva lanciato due piani di pace per risolvere il conflitto arabo-israeliano (Piano Fahd, nel 1982, Piano Abdullah, 2002), senza la minima eco sia statunitense, che israeliana, non deviò mai dalla sua linea, nonostante questo rifiuto, probabilmente dovuto al fatto che, a livello subliminale, la dinastia wahhabita è stata la principale beneficiaria del sabotaggio operato per 30 anni dagli statunitensi e dagli israeliani, per ridurre la resistenza del nocciolo duro del mondo arabo-islamico: la neutralizzazione dell’Egitto da parte del trattato di pace con Israele (1979), la distruzione dell’Iraq (2003), lo strangolamento della Siria (2004), la ‘/caramellizzazione/’ della Libia (2005), l’isolamento dell’Iran (2006), al punto che Israele è, in definitiva il migliore alleato oggettivo dei wahhabiti, la rara combinazione di due regimi teocratici in tutto il mondo, no essendo lo Stato ebraico democratico che per la frazione ebraica della sua popolazione. In questo contesto, l’organizzazione clandestina al-Qaida di Usama bin Ladin e la rete transnazionale araba /Al-Jazeera/, appaiono, in retrospettiva, come delle escrescenze ribelli all’egemonia saudita sull’ordine interno Arabo, sia in politica che nei media.
L’arma del petrolio che ha brandito durante la guerra di ottobre del 1973, se ha portato un notevole prestigio nel mondo arabo musulmano e ripristinato un equo prezzo del carburante, in cambio ha indebolito le economie in particolare dell’Europa e del Giappone, alleati naturali nel mondo arabo. Il proselitismo religioso che ha schierato in Asia centrale, nelle ex repubbliche sovietiche musulmane, ha tagliato la strada per un’alleanza con la Russia, facendo spazio all’egemonia USA. Un camuffamento supplementare che riflette gli errori della strategia saudita e il suo impatto negativo sullo spazio arabo, il wahhabismo che ha lottato instancabilmente contro l’Unione Sovietica, ridiventata l’eterna Russia, vede profilare, con il pretesto della lotta contro il terrorismo, un pericoloso movimento a tenaglia, che può chiudersi con la tacita alleanza tra la Russia, Israele e gli Stati Uniti, per gli attentati commessi dai seguaci dell’Arabia Saudita, dagli islamisti di Al-Qaida in Occidente e dai separatisti ceceni in Russia e Ossezia. Colmo del cinismo che rivela comunque una grande paura: l’apertura della prima conferenza mondiale sul terrorismo, il 5 e 6 febbraio 2005, a Riad. Che una tale conferenza si tenesse in casa della Jihad Islamica, dove i finanziatori principali a livello mondiale dei movimenti islamici, quattro anni dopo il raid anti-Usa del settembre 2001, hanno ottenuto la cauzione dell’Occidente per una tale operazione di riabilitazione, da la misura della confusione dei leader wahhabiti e dei loro sponsor statunitensi.
L’Arabia Saudita è prigioniera e vittima delle sue scelte.
Umiliazione suprema è il fatto che il presidente USA George W. Bush, ex dipendente delle società Saudite, è stato il più fermo sostegno del Primo Ministro di Israele più aggressivo, in nome proprio del fondamentalismo religioso, avallando anche il confinamento di Yasser Arafat, il leader legittimo del popolo palestinese, e riconoscendo il diritto di Ariel Sharon di modificare unilateralmente il tracciato dei confini internazionali, in spregio della legalità internazionale. La risposta più lancinante a questa cecità potrebbe essere, simbolicamente, la scelta obbligata di dover rassegnarsi a denominare il proprio nuovo canale televisivo pan-arabo “Al Arabia”, un termine che aveva bandito dal suo lessico diplomatico per mezzo secolo, riprendendolo adesso a malincuore, nella speranza di essere ascoltato di fronte alla concorrenza, con tono meno sottomesso all’ordine statunitense. Questo paese che ha consacrato la maggior parte dei suoi sforzi a combattere, più di ogni altro paese, il nazionalismo arabo, fino a stabilire l’Organizzazione della Conferenza Islamica (OIC), una struttura diplomatica parallela e concorrente alla Lega Araba, che evolse, stranamente, a campione dell’arabismo a seguito della sconfitta militare israeliano in Libano, nell’estate del 2006, con grande stupore di quasi tutti gli osservatori internazionali. L’apostolo della fratellanza islamica per mezzo secolo, il paese la cui bandiera mostra il credo cardinale dell’Islam, accusò , senza vergogna, la Siria di aver fatto un patto con l’Iran, l’antica Persia, un paese musulmano ma non arabo, lasciando planare la minaccia di una nuova guerra di religione tra sunniti e sciiti, arabi e musulmani non-arabi, un comportamento che assomiglia a una mistificazione, illustrazione patetico della confusione del Regno.
*Tra la dinastia wahhabita e Bin Ladin, la battaglia nell’ordine simbolico di un conflitto di legittimità*
Il coinvolgimento di un membro della cerchia familiare del principe Bandar bin Sultan, figlio del ministro della Difesa e presidente del Consiglio nazionale di sicurezza, nella riattivazione dei simpatizzanti di Al-Qaida in Siria e nel Libano del Nord, nella regione del campo palestinese di Nahr el-Bared, ha dimostrato il grado di infiltrazione dei circoli pan-islamisti nella cerchia dei governanti sauditi, mentre mina il Regno nei confronti dei suoi interlocutori sia arabi che statunitensi. Sheikh Maher Hammoud, un muftì sunnita della moschea “/Al Quds/” di Saida (sud del Libano), ha apertamente accusato il principe Bandar, dalla rete /Jazeera/, sabato 26 giugno 2010, di finanziare i disordini in Libano, in particolare contro le aree cristiane, portando gli USA a dichiarare “/persona non grata/” Bandar, l’ex beniamino degli Stati Uniti, il “/Grande Gatsby/” dall’establishment statunitense.
Circostanza aggravante, la disgrazia di Bandar sarebbe correlata a informazioni che affermano che egli ha l’intenzione di impegnarsi in un colpo di stato contro l’establishment saudita, per infrangere la legge della primogenitura che disciplina le regole alla successione dinastica in Arabia. Ciò prevede l’accesso al potere del decano della generazione più anziana. Il gruppo dirigente saudita conta molti gerontocrati, compresi alcuni in posizioni chiave, che soffrono di malattie debilitanti: il principe ereditario Sultan, ministro della Difesa, il ministro degli esteri, principe Saud al Faisal e il Governatore di Riyadh, principe Salman, mentre novecento nipoti scalpitano con impazienza per saltare nei posti di responsabilità, in un clima di intensa concorrenza. La congiura, concepita con l’aiuto di alti ufficiali della base aerea di Riyadh, sarebbe stata alimentata dai servizi segreti russi. L’operazione doveva avvenire a fine 2008, durante la guerra di Gaza, durante la transizione di poteri tra George Bush jr e il democratico Barack Obama. Con il sostegno di neo-conservatori statunitensi, di cui il principe saudita era un amico stretto, la transizione doveva, nello spirito dei suoi promotori, ridurre il divario generazionale del paese, in cui il 75 per cento della popolazione ha meno di 25 anni anni, mentre la classe dirigente ha un numero significativo di ottantenni. Il fatto che gli Stati Uniti, che controllano il regno con una rete di circa 36 posizioni dell’FBI e della CIA, non avesse avvisato il potere, da la misura della cautela statunitense.
Yemen e Iraq, due paesi confinanti con l’Arabia Saudita, avrebbero costituito i due baluardi della difesa strategica del Regno, il primo nel sud, il secondo a nord dell’Arabia Saudita. E’ in questi due paesi che l’Arabia Saudita ha cominciato la lotta per garantire la continuità della dinastia, in due occasioni negli ultimi decenni, Lo Yemen che è servito da campo dello scontro tra repubblicani e monarchici arabi, al tempo della rivalità Faisal-Nasser negli anni ’60, e l’Iraq, teatro dello scontro tra sciiti rivoluzionari e sunniti conservatori, al tempo della rivalità Saddam Hussein- Khomeini negli anni ’80. Questi due paesi costituiscono, ormai, una fonte di pericolo, con l’eliminazione della leadership sunnita in Iraq, e con la reintroduzione di al-Qaida, nello Yemen, nel gioco regionale. L’inserimento di al-Qaida nella penisola arabica dallo Yemen, in questo contesto è una sfida di grande importanza. L’ancoraggio di una organizzazione principalmente sunnita, l’escrescenza del rigorismo wahhabita, sul fianco meridionale dell’Arabia Saudita, porta il segno di una sfida personale di bin Ladin agli ex padroni, poiché porta sul posto stesso della loro antica alleanza, la lite sulla legittimità tra la monarchia e il suo ex agente. Potrebbe avere un effetto destabilizzante sul regno, dove vive quasi un milione di lavoratori yemeniti. L’allarme è stato ritenuto abbastanza serio da condurre il re Abdullah ad impegnare le sue forze nei combattimenti in Yemen, nell’autunno del 2009, accanto alle forze governative, e ad attenuare la disputa con la Siria, incitando il suo uomo ligio in Libano, il nuovo primo ministro libanese Saad Hariri, a riprendere il cammino per Damasco.
In tutti gli aspetti, la strategia saudita, sia nei confronti del mondo musulmano che dell’Iraq è un caso esemplare di suicidio politico. La partecipazione di quindici sauditi su 19 all’incursione di al-Qaida contro gli Stati Uniti, l’11 settembre 2001, come negli attacchi mortali che hanno colpito Riyadh il 12 maggio 2003, un mese dopo la caduta di Baghdad, uccidendo 20 morti, tra cui 10 statunitensi, hanno suonato un campanello d’allarme come forma di avvertimento. Adulato all’eccesso, il regno è ora oggetto di sospetti quasi universale da parte dell’opinione pubblica occidentale, e la sua strategia è criticata in tutta l’arabo.
*Il re dell’Arabia Saudita, un pompiere incendiario *
Sponsor originale dei taliban in Afghanistan, l’Arabia Saudita si dice sia stata la finanziatrice principale del programma nucleare pakistano, in cambio dell’assistenza fornita dal Pakistan nella supervisione della forza aerea saudita, che ha fornito per 20 anni l’addestramento ai suoi piloti e la protezione del suo spazio aereo. Un buon affare, simbolicamente materializzato dal nome della terza città di Faisalabad, in Pakistan, l’ex Lyallpur, in omaggio al contributo di Re Faisal di Arabia nella composizione delle controversie tra il Pakistan, secondo più grande paese musulmano dopo l’Indonesia, e il Bangladesh, durante la secessione della sua ex provincia, sotto la guida dello sceicco Mujibur Rahman, leader della /Lega Awami/ (10). Nonostante queste forti analogie, in particolare il patrocinio congiunto del regno saudita al miliardario saudita libanese e al Pakistan, come i loro posizionamenti simili in termini di geopolitica degli Stati Uniti; Rafik Hariri avrà diritto ad un tribunale internazionale speciale, per giudicare i suoi presunti assassini, ma non Benazir Bhutto, di cui è stata decimata tutta la dinastia. In questa prospettiva, il destino di Benazir Bhutto è stranamente simile a quello dell’ex primo ministro libanese Rafik Hariri e a quello dell’ex presidente egiziano Anwar Sadat, assassinato nel 1981, e all’effimero presidente del Libano Bashir Gemayel, leader delle milizie cristiane, assassinato nel 1982. I leader più utili alla diplomazia israeliano-statunitensi, più da morti che da vivi.
Al culmine della diplomazia saudita, in seguito all’invasione dell’Iraq nel 2003, i due leader arabi, Hariri (Libano) e Ghazi al Yaour (Iraq) che si sono trovati contemporaneamente al potere nei rispettivi paesi, erano titolari della nazionalità saudita. In questo contesto, non è irrilevante notare che Rafik Hariri è stato assassinato nei quindici giorni che seguirono l’elezione di un curdo, Jalal Talabani, a capo dell’Iraq, e l’attribuzione a un sciita della presidenza del Consiglio dei Ministri, scartando un sunnita dal governo della ex capitale abasside, su cui sventolava, d’altronde, all’epoca, il nuovo emblema iracheno disegnato dal proconsole Paul Bremer, dai colori curdo-israeliani (blu-bianco e giallo-bianco). Cosa che, inoltre, innescò un’ondata senza precedenti di attacchi contro i simboli dell’invasione statunitense dell’Iraq e dei suoi alleati regionali.
Pompiere piromane, il monarca ottuagenario (86 anni), al potere da quindici anni, si trova all’epicentro di un conflitto che ha continuato ad alimentare, e con cui potè avallare l’invasione statunitense dell’Iraq, con ripercussione l’eliminazione dei sunniti del potere centrale, con il ruolo pioniere del falso testimone siriano presso gli investigatori internazionali, Zuhair Siddiq, un factotum del generale Rifa’at al-Assad, zio e rivale del presidente siriano Bashar al_Assad, e soprattutto cognato del re dell’Arabia Saudita, per destabilizzare il presidente libanese Emile Lahoud e sostituirlo con il secondo cognato del re, il deputato libanese Nassib Lahoud.
Sfidato sul fianco meridionale, nello Yemen, dalla principale organizzazione fondamentalista sunnita del mondo musulmano, dalle dimensioni planetarie, al-Qaida, escrescenza ribelle del modello wahabita, il re Abdullah è contestato dall’equazione rappresentata dalla gloriosa storia militare di /Hezbollah/, la principale organizzazione paramilitare del Terzo Mondo, di osservanza sciita. Abdullah appare come l’apprendista stregone di una questione che lo trascende, il demiurgo di questioni che lo sovrastano sia in Iraq che in Libano, prima che in Afghanistan. In questa prospettiva, l’affare del secolo concluso nel settembre 2010 tra Arabia Saudita e Stati Uniti, di circa 90 miliardi di dollari in armi, tra cui quasi trecento aerei e missili, mira ufficialmente a rafforzare il Regno nei confronti dell’Iran, non d’Israele, potenza nucleare che occupa Gerusalemme, il 3° luogo santo dell’Islam, ma anche e soprattutto a consolidare la dinastia nel suo ruolo di gendarme regionale, mentre i due paesi baluardo dell’Arabia (Yemen e Iraq) sono destabilizzati e l’arco dell’Islam, che va dalla Somalia all’Indonesia attraverso l’Asia Centrale e il Golfo, diviene il nuovo centro di gravità strategico del pianeta, con l’emergere di Cina e India e il loro accerchiamento dell’Occidente dall’Africa.
Indice complementare del suo vassallaggio, il nuovo contratto militare da 90 miliardi di dollari, firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita.
Il più grande affare d’armi nella storia mira a “rafforzare la capacità combattiva del Regno contro l’Iran”, senza porre rischi su Israele. Gli aerei sauditi saranno privati delle armi a lungo raggio, per garantire lo spazio aereo israeliano e le loro prestazioni, sia in termini di attrezzature come di maneggevolezza, saranno in ogni caso, meno potenti del nuovo velivolo che gli Stati Uniti prevedono di vendere a Israele, i 20 caccia-bombardieri F-35 /Lightning II/ (JSF-35), il super-bombardiere da superiorità tecnologica, il cui enorme costo unitario ammonta a 113.000.000 di dollari ciascuno.
Così, con un sotterfugio che gli scienziati politici statunitensi definiscono nella voce “Politica della paura”, la politica dell’intimidazione, che consiste nel presentare l’Iran come uno spauracchio, per cui l’Arabia Saudita è costretta a creare, non una difesa a tutto tondo, ma una posizione di difesa contro l’Iran, che rafforzi il regno “/contro l’Iran/”, potenza sulla soglia nucleare, e non Israele, una potenza nucleare completa e, inoltre, potenza occupante di Gerusalemme, il terzo luogo santo dell’Islam. In totale, l’ammontare degli accordi militari tra le monarchie petrolifere del Golfo e gli Stati Uniti, nel 2010-2011, sarà pari a 123 miliardi di dollari. Il resto sarà diviso tra Emirati Arabi Uniti, Kuwait e il sultanato di Oman, che sbloccheranno, nei quattro, una somma colossale per ridurre la disoccupazione negli Stati Uniti, mantenere un bacino di lavoro di 75.000 posti in cinque anni e giustificare, sotto l’apparenza di un falso equilibrio, una transazione qualitativamente superiore tra gli Stati Uniti e Israele.
Settantotto anni dopo l’indipendenza, la triade su cui è stato stabilito il regno (Islam, Petrolio e wahabismo) sembra assumere una nuova configurazione. Se l’Islam, la sua rendita di posizione, è assicurata per sempre, il petrolio è destinato a prosciugare o degradare a causa delle energie alternative, come anche la dinastia wahhabita, a meno di una sfida della sua visione monolitica dell’Islam e del mondo, dalla sua concezione dello Stato e dei suoi rapporti con i cittadini, del suo rapporto con la realtà col mondo arabo, non composto solo da musulmani, o da soli sunniti, o da soli arabi (curdi e cabili), ma anche dagli arabi sciiti spesso patrioti, e da patrioti non sempre musulmani (arabi cristiani), non sempre necessariamente in permanente stato di prostrazione davanti gli Stati Uniti d’America, e ai suoi benefici e danni.
La famiglia reale saudita ha seguito un percorso curioso per rimanere al potere, il perfetto contro-esempio negli annali della geopolitica mondiale.* *Avendo troppo manipolato i suoi alleati islamici, si è indebolita, dando loro la possibilità di rivoltarsi contro il loro ex mentore. Strumentalizzando le sue formazioni pan-islamiche in operazioni diversive (Afghanistan) o di destabilizzazione (Siria, Egitto e Algeria), senza mai rinnegarle o controllarle, l’Arabia Saudita si troverà caricata dal peso negativo della distruzione islamista dei Buddha di Bamiyan da parte dei Taliban, degli attacchi anti-USA dell’11 settembre 2001, sottoposta al sospetto dell’opinione pubblica occidentale e alla vendetta dei suoi ex protetti islamisti.
Come spiegare un simile comportamento? Che i leader abbiano potuto, in un periodo così lungo, confinarsi nel ruolo di subappaltatori, accettando di correre alla cieca in un combattimento contro dei nemici, assegnatili dai loro tutori, senza accennare a un momento di esitazione, a un lampo di orgoglio nazionale? Amputarsi consapevolmente di alleati naturali, senza sollevare la questione della compatibilità con l’interesse nazionale? Condannare l’avanguardia rivoluzionaria araba, sacrificarla per la soddisfazione degli interessi stranieri, senza entrare nel merito della fondatezza di una tale politica? A quale logica risponde un tale comportamento singolare. Follia o megalomania? Machiavellismo o cinismo servile? Incoscienza o aberrazione mentale? Postura o impostura? Quasi quaranta anni dopo i fatti, la rilevanza di una tale politica non è stata provata, ma si è rivelato un dato di fatto che “/ci sia qualcuno peggio del boia: il suo servo/”(9). Una frase su cui riflettere mentre il Regno, banca centrale del petrolio, pianifica per la prima volta nella sua storia, di mettere fine alla ricerca di idrocarburi nel suo sottosuolo, al fine di salvare la sua ricchezza, in modo da trasmetterla “/alle generazioni future/”(10), mentre la sua ricchezza rischia di prosciugarsi, e di conseguenza la sua impunità, proprio mentre la Cina è pronta a sfidare la leadership globale degli USA.
*Riferimenti *
7 – Precisazioni di Chass Freeman, ex ambasciatore statunitense in Arabia Saudita (1989-1993) basato sulla funzione deviante della guerra in Afghanistan verso la gioventù saudita dal problema palestinese, al centro del documentario di Jihane Tahri
8 – “/Una Guerra Empia. La CIA e l’estremismo islamico (1950-2001)/” di John Cooley, un ex corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano di Boston Christian Science Monitor e ABC News. Edizioni Eleuthera, 2001.
9 – Definzione del conte Honoré Gabriel de Mirabeau (1749-1791), uno degli oratori più brillanti della Rivoluzione francese, autore di «/Essai sur les lettres de cachet et les prisons d’état/».
10– Cfr. Le Monde 7 luglio 2010 «/Le roi Abdallah annonce l’arrêt de l’exploration pétrolière en Arabie Saoudite/». Un freno in più (e notevole) per rallentare il declino della produzione mondiale.
L’Arabia Saudita, primo produttore mondiale di petrolio, avrebbe messo fine alla esplorazione sul suo suolo, al fine di salvare la sua ricchezza e trasmetterla alle generazioni future, secondo una dichiarazione da re Abdullah in data 1° luglio. L’annuncio è stato dato a Washington davanti a degli studenti sauditi, dice l’agenzia di stampa ufficiale saudita. Pronunciato due giorni dopo un incontro tra il re saudita e il presidente Barack Obama, suona come un avvertimento. L’arresto dello sviluppo di nuovi campi petroliferi in Arabia Saudita, rischia di complicare ulteriormente il futuro della produzione mondiale di petrolio, di fronte all’aumento della domanda. Infatti, l’Arabia Saudita da sola detiene il 20% delle riserve mondiali di oro nero. Temperando il disagio innescato dal bando, un ufficiale del ministero saudita del Petrolio ha detto all’agenzia /Dow Jone/s, che la dichiarazione dell’organismo non significa una decisione definitiva, “/ma in realtà voleva dire che le esplorazioni future dovrebbero essere condotte con saggezza/”, dice il Financial Times. Il quotidiano economico londinese ha detto che la compagnia petrolifera nazionale saudita Aramco, dovrebbe compiere oggi delle prospezioni nel Mar Rosso e nel Golfo Persico.
Traduzione di Alessandro Lattanzio