La sinistra e l’Illuminismo: la fine di una storia
di Denis Collin - 28/11/2025
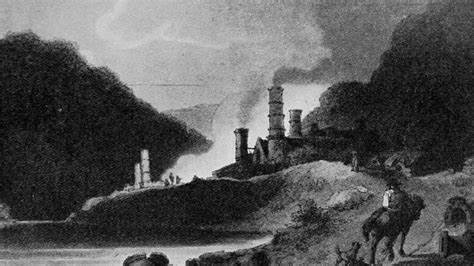
Fonte: GRECE Italia
Il delirio ideologico che ha colpito gran parte della sinistra porta alcuni filosofi – ad esempio Henri Pena-Ruiz o Stéphanie Roza – a rivendicare contro questo delirio una sorta di ritorno all’Illuminismo e alla sinistra «storica», ovvero una sinistra che difendeva innanzitutto l’universalismo, mentre oggi si affermano rumorosamente e talvolta violentemente ogni sorta di identitarismo e comunitarismo. Non è detto che questa risposta in stile «ritorno a…» sia davvero convincente. L’Illuminismo, infatti, non costituisce un blocco unico e il regno della ragione che esso invocava ha generato mostri secondo una logica già ben analizzata da Adorno e Horkheimer nella loro Dialettica dell’Illuminismo (Dialectique de la raison, Gallimard, 1974), che mostra invece come la ragione si ritorca contro se stessa. Infine, la «sinistra» è giunta al termine di un percorso tortuoso e, da un certo punto di vista, il passaggio dalla «sinistra sociale» alla «sinistra societaria» è inevitabile se si ha un’idea precisa di cosa sia la sinistra.
È abbastanza evidente che l’Illuminismo non costituisce un blocco unico. Come Jonathan Israel, possiamo distinguere tra Illuminismo radicale e Illuminismo moderato. La corrente dell’Illuminismo radicale, rappresentata dalla linea di Spinoza, Diderot e dai loro eredi, è una corrente al tempo stesso antireligiosa e atea – non c’è posto per un Dio trascendente o un «disegno intelligente» – e antimonarchica. L’Illuminismo moderato è piuttosto dalla parte della religione naturale, sostiene la libertà di commercio e la difesa della proprietà privata contro l’arbitrarietà e tende verso un certo conservatorismo politico legato all’odio per il «popolaccio» così caratteristico di Voltaire. Questo clivage non è del tutto soddisfacente e si potrebbe facilmente dimostrare che esistono molte altre linee di demarcazione. In ogni caso, se ci si richiama all’Illuminismo, bisognerebbe specificare a quale: a quello di Rousseau e al suo radicalismo politico o a quello di Voltaire, sostenitore del dispotismo illuminato? Dell’ateismo di Diderot o della religiosità naturale di molti altri pensatori, come Locke, il cui radicalismo politico è inseparabile dal suo radicamento religioso? È possibile che l’Illuminismo sia più un termine che una corrente precisa sulla quale rifondare un pensiero politico coerente. Si potrebbe tentare di definire l’Illuminismo in contrapposizione all’anti-Illuminismo, alla maniera di Zeev Sternhell, il cui libro Contro l’Illuminismo: dal XVIII secolo alla guerra fredda (2007) è un concentrato delle assurdità a cui conduce una certa riduzione della storia alla cosiddetta «storia delle idee». Alcuni dei pensatori classificati come «anti-Lumi» da Sternhell, come Vico, sono in realtà molto più avanzati nella riflessione sulla società e sulla cultura umana rispetto a molte delle grandi stelle dell’Illuminismo. Herder, un altro «anti-Illuminismo» secondo Sternhell, cerca di ripensare l’universale non in modo astratto, ma nella sua espressione nei diversi popoli, sapendo che siamo tutti sulla stessa barca.
Se si riduce l’Illuminismo al regno della Ragione, si incontrano grandi difficoltà. La Ragione divinizzata non vale più degli altri dei e dovremmo attenerci alla ragione umana, semplicemente umana. Ma allora tutto dipende da ciò che si intende per ragione. Si potrebbe, come Kant, distinguere tra ragione pura e ragione pratica, la ragione come facoltà di conoscere e la ragione come espressione della volontà. Si può anche opporre la ragione alla razionalità strumentale; quest’ultima è semplicemente la capacità di mettere in atto i mezzi razionali più adeguati per raggiungere determinati fini, qualunque essi siano; la prima è invece in grado di determinare i principi universali che dovrebbero prevalere e i fini che dovremmo perseguire.
L’intera storia del «mondo moderno» ha visto il trionfo della conoscenza scientifica, ovvero della conoscenza sperimentale guidata dalla matematica. Questa conoscenza scientifica pura non è poi così pura: si è sviluppata secondo linee di interesse pragmatico e le esigenze dell’industria e del profitto hanno finito per fornirle il suo programma di ricerca e renderla un sistema di legittimazione sociale e politica perfettamente ideologico, come ha dimostrato Jürgen Habermas (Scienza e tecnologia come ideologia, 1967). Lungi dall’essere il trionfo della ragione, il nostro mondo è soprattutto quello in cui la razionalità strumentale viene messa al servizio degli scopi più assurdi o abominevoli.
L’Illuminismo non si conclude con un percorso chiaramente tracciato, ma con un’alternativa che potremmo riassumere così: Kant o Sade! Sottomettersi ai principi morali, che sono gli unici assoluti (mentre la conoscenza scientifica è solo relativa e condizionata), o considerare che tali principi morali non sono altro che gli ultimi pregiudizi inculcati dalla religione e che bisogna semplicemente seguire la natura, che ci impone di ricercare il piacere con ogni mezzo – vedasi Sade nel suo saggio La filosofia nel boudoir. Per sintetizzare, diciamo che lo sviluppo del capitale, guidato dalla mano del mercato divino (vedasi D.-R. Dufour), ha seguito la via sadiana! Sade è davvero il lato oscuro del liberalismo e della scienza che abbiamo ereditato, e i principi sadiani sono al centro stesso del liberalismo in quanto regolano l’intera vita sociale. Sarebbe sbagliato vedere nel fascismo e nel nazismo del XX secolo un «ritorno alla barbarie», nonostante alcune manifestazioni assurde. Il fascismo e il nazismo sono correnti rivoluzionarie che mirano a liberare il potere umano, a spezzare le catene morali che ancora imprigionano i potenti e a fare tutto ciò che la tecnoscienza può fare. Rimodellare l’essere umano secondo un piano scientifico e sottomettere l’intera società sono possibilità aperte dall’Illuminismo e dal progresso. Il fascismo e il nazismo nelle forme storiche che abbiamo conosciuto nel secolo scorso non sono più all’ordine del giorno. Ma il loro fondamento «teorico» è esattamente quello della società in cui viviamo. Gli sviluppi dell’eugenetica «liberale» (GPA, PMA) e del controllo sociale attraverso le tecnologie più avanzate consentono di realizzare il programma totalitario del XX secolo in modo più rigoroso e senza ricorrere a quei massacri sanguinosi che macchiano il meraviglioso mondo del progresso.
La sinistra è l’erede dell’Illuminismo e di tutta la sua ambiguità. La sinistra è storicamente radicata nel movimento di emancipazione della borghesia, mentre il movimento operaio è nato in reazione al regno della ragione calcolatrice all’opera nell’industria del capitalismo nascente. Le prime organizzazioni operaie nascono dalla rivolta degli artigiani privati dei loro strumenti di lavoro, dei contadini cacciati dalla loro terra e che hanno perso ogni indipendenza. Si sono abituati alla disciplina della fabbrica, che Lenin vedeva come la scuola della disciplina rivoluzionaria, e sono stati portati a cercare alleanze nella borghesia «progressista». Ma gli operai non sono diventati borghesi illuminati! Attraverso le loro organizzazioni, hanno rivendicato i benefici dell’istruzione e della cultura borghese come armi nella lotta contro la borghesia. Unendo operai e borghesi, o almeno una parte della borghesia, la sinistra nascondeva una contraddizione fondamentale che è esplosa nei brevi periodi dei «fronti popolari», quando i governi portati al potere dal movimento delle classi popolari hanno rivolto le loro armi contro i lavoratori non appena è stata messa in discussione la proprietà capitalista. La sinistra è stata la copertura di questo antagonismo persistente dietro gli accordi al vertice. La sinistra era un’alleanza, un blocco, ma il blocco di un cavaliere e del suo cavallo.
Il degrado intellettuale e politico della sinistra non è altro che l’espressione del suo carattere borghese. Con l’aiuto del surrealismo, si è potuto credere che la critica sociale e la critica artistica fossero una sola e stessa critica. Non è così. Il borghese bohémien, il piccolo borghese intellettuale che è di sinistra perché vorrebbe essere un vero borghese e comandare, l’artista rivoluzionario che sostituisce l’opera con il video e la performance, conservano sempre un certo disprezzo per «il materialismo volgare delle masse», la loro mancanza di gusto per le novità più stravaganti: «queste persone sono così comuni! », ovvero Il borghese cosmopolita, il fanatico di un mondo senza frontiere è «di sinistra» e, può persino credersi internazionalista, criticando questi bifolchi rinchiusi nella loro «casa».
I vertici dei partiti operai erano stati conquistati da tempo dalla borghesia, con la quale avevano stretto compromessi keynesiani che garantivano loro il sostegno della loro clientela senza mettere in discussione l’ordine esistente. Con la fine dei compromessi keynesiani e l’offensiva neoliberista, i leader di questi partiti sono caduti dalla parte verso cui propendevano e la sinistra si è convertita a tutte le nuove stravaganze che contribuiscono a disgregare ogni comunità politica a vantaggio delle più strane rivendicazioni individualistiche, rifiutando ogni decenza e perdendo così la fiducia degli operai e delle classi popolari in generale. I gruppuscoli comunitaristi, alimentati dalla sinistra, ora la stanno divorando. E alla fine non c’è nulla da rimpiangere in tutto questo. Non si può passare la vita ad amare certe cause per poi maledirne gli effetti quando ti colpiscono in pieno.
Se non vogliamo perdere ogni speranza alle soglie del «mondo che verrà», bisogna cominciare con l’abbattere l’idolo del progresso e chiedersi seriamente «quale progresso, verso cosa?», sapendo che le illusioni di una crescita illimitata delle forze produttive devono essere gettate nella pattumiera della storia e che sarà necessario ridimensionare le nostre ambizioni e pianificare le nostre spese, pena la trasformazione di questo mondo in un inferno. Il rinnovamento di un socialismo popolare, patriottico e internazionalista (che presuppone il riconoscimento delle nazioni) ha questo prezzo.
