Contro l'illusione: Carl Schmitt e la realtà del potere
di Chad Crowley - 25/09/2025
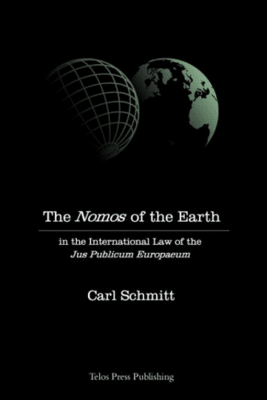
Fonte: Giubbe rosse
Carl Schmitt è uno dei pochi giuristi del secolo scorso ad aver osato affermare la più elementare delle verità: diritto e politica sono inseparabili, poiché ogni costituzione non si fonda su principi ma sul potere, e il potere, in ultima analisi, è forza, capacità di comandare e, se necessario, di esercitare la violenza. Nessun ordinamento giuridico si regge solo su pergamena e procedura; sussiste solo finché esiste un’autorità disposta a difenderlo. Non leggiamo Schmitt per curiosità antiquaria, ma perché le falsità da lui smascherate governano ancora il nostro mondo. I regimi liberali predicano neutralità, equilibrio e dibattito, eppure rifuggono dal fatto che la politica non è mai neutrale, che ogni popolo ha nemici oltre che amici, e che negare questa verità significa preparare la strada alla violenza nella sua forma più barbara. Schmitt diede a questo concetto la sua espressione più acuta in quello che chiamò lo stato di eccezione, il momento in cui la sovranità emerge da dietro la procedura e svela i fondamenti su cui poggia ogni ordine politico.
Questo riconoscimento squarcia la vanagloria delle democrazie moderne, che promettono sicurezza mentre si traducono in paralisi. Lo vediamo ogni volta che scoppiano crisi e istituzioni concepite per la procedura si dimostrano incapaci di decidere. I tribunali moltiplicano le ingiunzioni, i legislatori si dissolvono in litigi, gli esecutivi rinviano le responsabilità e lo Stato stesso vacilla mentre rivali, partiti, lobby, burocrazie e persino potenze straniere prendono l’iniziativa. Schmitt capì che un regime che si rifiuta di affrontare la dura verità della sovranità crea un vuoto che altri si affretteranno a colmare. Iniziare con lui, quindi, non significa indulgere nella teoria, ma recuperare una severa chiarezza: che la politica, spogliata di illusioni, è una lotta su chi comanda, chi obbedisce e chi possiede la volontà di decidere quando la legge non basta più.
Leggere Schmitt oggi significa provare il dolore del riconoscimento, poiché i mali da lui diagnosticati nella sua epoca persistono ancora nella nostra. Le sue parole sono state plasmate dalle tempeste del suo tempo, eppure i dilemmi che ha descritto si estendono ben oltre. Viviamo in sistemi che scambiano la procedura per sostanza e la debolezza per virtù, che estendono i diritti proclamandoli mentre dissolvono il potere che solo può garantirli. I governi invocano la democrazia senza definire il popolo in nome del quale pretendono di governare, proclamano la pace mentre si invischiano in guerre all’estero ed esaltano l’uguaglianza mentre cede l’autorità a oligarchie mascherate da istituzioni neutrali. La lezione di Schmitt è che tali contraddizioni non possono durare. Culminano, come sempre, nei momenti in cui il fondamento elementare del potere si riafferma e la sovranità passa a chi ha la volontà di impossessarsene.
Per Schmitt, il sogno febbrile del liberalismo, di una politica ridotta ad amministrazione, di un ordine senza forza e di un’unità senza decisione, non era un segno di progresso, ma di decadenza e una negazione della realtà. Le camere parlamentari parlavano all’infinito di diritti, libertà e umanità, eppure nella pratica neutralizzavano la capacità dello Stato di difendere il suo popolo. Scambiando la debolezza per virtù e il compromesso per saggezza, trasformavano le decisioni reali in procedure vuote. La sua diagnosi, letta oggi, spiega la paralisi delle nostre presunte democrazie di fronte a una successione sempre crescente di crisi. Le istituzioni che professano di incarnare principi che esistono solo come astrazioni si rivelano incapaci di un’azione decisiva, mentre partiti parassitari e interessi finanziari cedono terreno a forze etniche che si affrettano a occupare lo spazio abbandonato dalla sovranità in ritirata. Ciò che egli offrì non fu né un invito a ripristinare il passato né una richiesta di rovesciare il presente, ma il sobrio riconoscimento che la politica, nella sua essenza, è conflitto e che nessun popolo può resistere alla prova del tempo se si rifiuta di conoscere i propri nemici, interni o esterni, e di affermare la propria unità agendo contro di essi.

Da questa consapevolezza scaturisce la prima lezione di Schmitt: il conflitto non è un incidente della storia, ma l’orizzonte costante della vita collettiva.
“La distinzione politica specifica a cui si possono ridurre le azioni e le motivazioni politiche è quella tra amico e nemico”. Il concetto di politico
Con ciò intendeva la distinzione amico-nemico, così spesso citata, così raramente compresa e più spesso ancora caricaturata: la linea che un popolo traccia per riconoscere coloro che mettono a repentaglio la sua esistenza e affermare la propria esistenza contro di loro. Questa non era una celebrazione della violenza fine a se stessa, né un’esaltazione della guerra come ideale. Era il riconoscimento che l’inimicizia è sempre possibile, che è insita nella struttura della vita umana, poiché la vita tra gli uomini è sempre conflitto e lotta. Si possono concludere trattati, si possono perfezionare istituzioni, eppure i popoli scopriranno sempre differenze che ritengono essenziali e le difenderanno, se necessario, con il sangue. L’ordine stesso dipende da questo riconoscimento. Negarlo significa preparare il terreno alla rovina. La nostra epoca, tuttavia, è definita proprio da tale negazione. I governanti proclamano che i confini sono obsoleti, che le nazioni possono dissolversi in un’umanità informe e senza limiti, che l’inclusione ha estinto il ricordo stesso dell’antagonismo. La conseguenza è sempre la stessa: le divisioni represse ritornano con maggiore ferocia, perché il tentativo di cancellare il conflitto non fa che accentuarne la ricomparsa.
La seconda lezione di Schmitt riguarda il significato di sovranità. In Teologia politica, egli fornì la definizione che è diventata la sua più celebre:
“Sovrano è colui che decide sull’eccezione”.
Questa definizione non era un artificio retorico, ma un condensato della realtà politica: la legge dipende dall’autorità e nessuna regola si sostiene da sola. Ogni ordine si fonda sulla disponibilità a esercitare la forza, poiché senza la possibilità della violenza l’autorità si dissolve nell’illusione. Schmitt ha approfondito ulteriormente il punto con un’osservazione più approfondita:
“Tutti i concetti significativi della moderna teoria dello Stato sono concetti teologici secolarizzati”.
Qui ha messo a nudo la struttura nascosta della politica moderna: la sovranità trae il suo peso da origini teologiche trasposte in forma secolare. Ciò che un tempo apparteneva a Dio e alla rivelazione divina ora appartiene allo Stato e alla decisione. A prima vista può sembrare un’astrazione, eppure la sua forza sta nello spogliare la politica fino al suo nucleo. La sovranità si rivela non nell’applicazione quotidiana delle regole, né nella silenziosa routine dell’amministrazione, ma nel momento in cui l’ordine vacilla, quando la legge non basta più e quando la sopravvivenza esige una decisione. Il sovrano non è un mero funzionario vincolato da regole, ma la figura che proclama che è giunta un’eccezione e che agisce per preservare la comunità politica di fronte a essa.
Questa intuizione nasceva dall’esperienza. Schmitt visse in un’epoca in cui le costituzioni erano venerate come testi sacri, invocate come se la loro autorità fosse autosufficiente e svincolata dalle contingenze della storia. Eppure, ogni crisi autentica rivelava il contrario. La carta non può difendersi da sola, i tribunali non possono reggere, le formule legali non servono a nulla quando l’esistenza stessa dello Stato è in pericolo. In tali momenti la sovranità appare nella sua forma più cruda, non nella procedura ma nella decisione, non nelle regole ma nell’atto che ristabilisce l’ordine. Decidere sull’eccezione significa mettere a nudo il fondamento della vita politica, dimostrare che il diritto presuppone l’autorità e che senza la volontà di imporlo e difenderlo nessun ordine può sussistere.

Il liberalismo si ritraeva da questa verità perché contraddiceva la sua illusione centrale: che la legalità fosse autonoma, che le norme si sostenessero da sole, che la pace fosse resa permanente. Per Schmitt questa era la più pericolosa delle illusioni, perché incoraggiava gli stati a negare il potere stesso da cui dipendevano le loro leggi. Ogni legge richiede un esecutore, ogni costituzione presuppone un difensore. Neutralità e indugio non evitano il conflitto; lo acuiscono. Uno stato che si rifiuta di decidere, che abdica alla propria sovranità, invita altri a impadronirsene, siano essi partigiani all’interno dei suoi confini o nemici al di là di essi.
La sovranità, quindi, per Schmitt non era una questione di volontà arbitraria, ma di forza politica, di capacità di riconoscere quando le norme hanno fallito e di agire al di là di esse in difesa della comunità. Lungi dall’essere una licenza per la tirannia, era il sobrio riconoscimento che la sopravvivenza stessa dipende dalla disponibilità dell’autorità a sospendere le regole quando la necessità lo richiede. Nascondere questo fatto sotto la patina della legalità significa scommettere la vita di un popolo sulla finzione che la legge si sostenga da sola. Affrontarla significa accettare che ogni ordine si basi sulla volontà di difenderlo e che il destino di una nazione possa dipendere dal coraggio di un atto sovrano. Questo, per Schmitt, era lo scandalo che la teoria liberale non poteva sopportare, ma che la realtà politica non cesserà mai di dimostrare.
La sua terza lezione riguardava il parlamentarismo. In “La crisi della democrazia parlamentare”, sosteneva che le istituzioni rappresentative un tempo possedevano una vera forza, ma solo perché poggiavano su una più profonda unità sociale. Laddove un popolo condivideva razza, lingua, fede e costumi, il dibattito poteva essere condotto apertamente senza mettere a repentaglio la coesione. La Camera poteva fungere da forum in cui affinare le convinzioni comuni e il dibattito poteva affinare la lealtà anziché dissolverla. Una volta venuta meno questa omogeneità, il parlamento divenne vuoto, non più ancorato alla realtà dell’esistenza ma sostenuto da astrazioni tratte da fantasie utopiche. Il dibattito non cercava più la verità o il bene comune, ma si trasformava in una contrattazione tra interessi rivali e contraddittori, con la retorica che nascondeva il fatto che le decisioni erano già state determinate altrove. Quello che un tempo era stato un organo di deliberazione si ridusse a teatro, i cui rituali mascheravano la scomparsa della vera autorità.
“La democrazia richiede, in primo luogo, omogeneità e, in secondo luogo, se necessario, l’eliminazione o lo sradicamento dell’eterogeneità”. La crisi della democrazia parlamentare
Schmitt smascherò la contraddizione al centro dell’imparzialità liberale. I parlamenti si vantavano della loro apertura, della loro capacità di dare ascolto a ogni voce, eppure questa moltiplicazione di prospettive distruggeva la possibilità stessa della persuasione. Laddove non rimaneva alcun terreno comune, il compromesso diventava l’unica via per raggiungere un accordo, e il compromesso significava che quel principio cedeva il passo all’opportunismo. Con il moltiplicarsi delle fazioni, aumentava anche il peso del denaro e dell’influenza, poiché in un’infinita lotta di voci solo la ricchezza e il potere potevano garantire un risultato. La pretesa del parlamento di incarnare il popolo si invertì: non articolava più l’unità, ma la dissolveva, non affinava più le decisioni, ma nascondeva il fatto che le decisioni erano già state prese da poteri esterni alle sue mura: burocrazie, lobby, tribunali e oligarchi che esercitavano un’influenza senza renderne conto.
Questo declino non fu un caso fortuito, ma la verità più profonda del liberalismo stesso. Scambiando la trasparenza procedurale per forza, la teoria liberale celebrava proprio ciò che erodeva la capacità dello Stato di ispirare lealtà e imporre sacrifici. Con il declino dell’autorità del parlamento, il cinismo si diffuse tra il popolo, che si rese conto che i suoi rappresentanti dichiarati non erano né sovrani né decisivi, ma attori su un palcoscenico vuoto. Schmitt avvertì che un simile Stato, incapace di affermare l’unità, favorisce l’ascesa di forze che definiranno nemici e amici al suo posto. La politica non svanisce nella camera neutrale; riappare al di fuori di essa, spesso in forme più acute e distruttive. Il rifiuto dello Stato di affermare la sostanza lascia un vuoto che sarà inevitabilmente colmato, non dalla persuasione ragionata, ma dal potere nudo e crudo.
Da questo punto Schmitt passò a un principio più ampio: lo Stato non esiste per arbitrare le preferenze dei consumatori o per massimizzare il benessere, ma per incarnare l’unità di un popolo. È il contenitore della sua storia, il custode della sua continuità e la forma in cui si rende visibile la sua disponibilità a sacrificarsi gli uni per gli altri. Tale unità si fonda sull’eredità etnoculturale, sui legami di razza, lingua e fede, senza i quali non può sorgere alcuna solidarietà duratura. Un regime che abdica a questo ruolo non abolisce la politica; le consente semplicemente di infiltrarsi in altri ambiti, dove viene impossessata da fazioni, movimenti o poteri privati desiderosi di definire nemici e amici in assenza dello Stato. Per questo motivo Schmitt considerava la neutralità liberale una frode. Un governo che si rifiuta di nominare i propri nemici non è più umano o illuminato; cede semplicemente il passo ad altri che lo faranno con meno ritegno. Il vuoto creato dal rifiuto non rimane mai vuoto a lungo. Il potere si impone e coloro che affermano di essere al di sopra del conflitto scoprono di aver semplicemente ceduto la propria autorità a rivali che non riconoscono tali illusioni.
Schmitt comprese che nessuna comunità può essere sostenuta solo dal calcolo razionale. Regole e procedure possono ordinare la vita quotidiana, ma non possono forgiare la lealtà più profonda senza la quale nessuna società può sopravvivere. Al di là della legge e dell’amministrazione deve esistere una forza vincolante: un’eredità etnoculturale, una visione del destino e un mito vivente che trascenda il mero interesse. Le società liberali, abbandonate allo scetticismo e consumate dal relativismo, si dimostrarono incapaci di fornire tutto ciò. I loro appelli all'”umanità” e alla “pace universale” mascheravano l’imperialismo economico all’estero e l’esaurimento demografico in patria, un esaurimento che era al tempo stesso materiale e spirituale. La loro retorica disfaceva le lealtà anziché dar loro forma, e al posto di un mito vivente offrivano astrazioni che non suscitavano alcuna devozione.

Al contrario, anche un mito nazionale imperfetto possiede un potere che l’universalismo liberale non può eguagliare. Lega un popolo alla sua terra, ai suoi morti, alla sua eredità e alla sua posterità. Gli ricorda che non è un insieme di individui solitari, ma un popolo legato attraverso le generazioni. Spinge gli uomini a rischiare la vita non per astrazioni, ma per ciò che li unisce ai loro antenati e li obbliga ai loro discendenti. Schmitt comprese che tali miti non erano inutili ornamenti, bensì il fondamento stesso della sopravvivenza politica. Senza di essi, lo Stato diventa poco più di una macchina amministrativa, che presiede una popolazione di anime atomizzate che non si considerano più un popolo. E un tale Stato, privato del suo principio unificante, si dissolve nella massa informe del commercio globale e dell’illusione pacifista.
Le società che rifiutano di coltivare queste fonti di unità sprofondano nella debolezza: le loro popolazioni si frammentano, i loro governanti perdono la capacità di decidere e il loro destino è consegnato a poteri che non esitano a nominare amici e nemici al loro posto. L’importanza di Schmitt risiede nel costringerci a comprendere che senza un principio unificante di lealtà e sacrificio nessuno Stato può resistere alle forze di dissoluzione che lo circondano.
Questo era il significato più profondo del monito di Schmitt riguardo al declino dell’Europa. Nel Nomos della Terra descrisse lo jus publicum Europaeum, il diritto europeo delle genti, che per secoli ha limitato la guerra tra stati sovrani e ha confinato la violenza entro limiti. Non si trattava di pace in senso liberale, ma di un ordine disciplinato che riconosceva la legittimità degli stati come attori e impediva al conflitto di sfociare nella distruzione totale. Quella struttura iniziò a disgregarsi nel XX secolo con l’ascesa dell’ordine post-1945, che riformulò il mondo in termini morali piuttosto che politici. L’umanitarismo liberale prometteva di trascendere la sovranità e abolire il conflitto nel linguaggio dei diritti universali; eppure, in pratica, dissolse proprio i vincoli che avevano sostenuto l’equilibrio geopolitico dell’Europa. Le guerre non venivano più combattute tra potenze riconosciute all’interno di un insieme fisso di regole civili, ma ridefinite come crociate contro la disumanità, conflitti in cui il nemico non era più un avversario legittimo ma un criminale da punire o una bestemmia da epurare.
“Confiscare la parola ‘umanità’ significa tentare di negare al nemico la qualità di essere umano. Questa disumanizzazione trasforma la guerra in una guerra di annientamento assoluto“. Il Nomos della Terra
Qui Schmitt intravide l’ascesa di una nuova e più pericolosa barbarie. Quando la guerra viene condotta in nome dell’umanità, cessa di conoscere limiti. Considerare il nemico non un rivale, ma l’incarnazione del male significa privarlo dello status giuridico e porlo al di là di ogni confine dell’ordine. Il linguaggio umanitario professava di abolire il conflitto, ma in realtà rendeva la guerra più frequente, più moralizzata e più distruttiva. Non aboliva l’inimicizia; la consacrava. La guerra cessò di essere una contesa tra potenze e divenne un’azione penale in nome della moralità, condotta nel linguaggio del bene e del male, senza limiti di portata e senza limiti di mezzi. La sostituzione dell’ordine politico con l’astrazione morale non era una via verso la pace, ma una discesa nella guerra totale, l’esatto opposto della concordia che pretendeva di conferire.

L’Europa, agli occhi di Schmitt, aveva abbandonato la saggezza duramente conquistata della sua tradizione politica. Aveva accantonato il disciplinato equilibrio della sovranità e dell’arte di governare in favore delle infantili illusioni di un progresso illimitato e di una pace senza conflitti. Aveva barattato un sistema che riconosceva i limiti con una vuota retorica che li negava, e così facendo aveva scatenato una violenza sfrenata, resa ancora più nociva dal fervore di una nuova fede laica. La lezione che egli sottolineava era immediata: sostituire la politica con la moralità non significa trascendere il conflitto, ma scatenarlo nella sua forma più assoluta. Quando l’ordine si fonda su rivendicazioni universali, ogni guerra diventa una guerra santa, ogni uso della forza una crociata, ogni avversario un eretico da distruggere.
Il peso costante dell’intuizione di Schmitt è questo: la politica non può essere abolita, poiché il conflitto permane inseparabilmente nella vita dell’uomo. Negarla è l’utopia nata dalle dottrine rivoluzionarie scatenate per la prima volta nella Rivoluzione francese e rinnovate in ogni sconvolgimento successivo, ciascuna delle quali presume di rimodellare l’uomo senza conflitti, senza nemici, senza storia. Questo sogno, riapparso in nuove forme durante l’età moderna, è stato il seme della paralisi e del decadimento che ora ci circondano. Il conflitto può essere velato o represso, eppure ritorna sempre, e dopo la negazione riemerge con maggiore ferocia. Il liberalismo si sforzò di dissolvere il politico nel commercio e nel diritto, nelle astrazioni esangui di un’umanità informe; e in questa irrealtà forgiò un ordine indebolito e abbattuto dalla propria instabilità. Gli Stati persero la volontà di difendersi, i parlamenti degenerarono in teatri e i popoli cessarono di credere nel loro diritto all’unità e con esso alla continuità generazionale, quei due requisiti senza i quali nessuna nazione sopravvive. Schmitt ci costringe a considerare che il conflitto non svanisce mai, che la sovranità non può essere sepolta sotto la procedura e che una nazione che rinuncia al principio che la sostiene accumula la legna da ardere sulla propria pira funeraria. Leggerlo oggi significa spogliarsi dell’illusione e affrontare la questione da cui nessun ordine sfugge: chi decide e chi ha la volontà di preservare la vita di un popolo.
chadcrowley.substack.com — Traduzione a cura di Old Hunter

