Carl Gustav Jung, il grande sciamano
di Giovanni Sessa - 19/10/2025
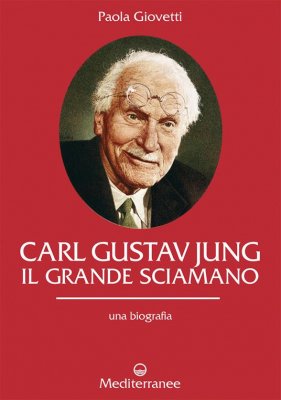
Fonte: Barbadillo
Paola Giovetti è autrice prolifica, specializzata in tematiche afferenti alla ricerca psichica. Dirige la storica rivista, Luce e Ombra, organo della Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni di Bologna. Non poteva, pertanto, mancare, nella vasta bibliografia a sua firma, un volume dedicato a C. G. Jung. È da poco nelle librerie per i tipi delle Edizioni Mediterranee la sua ultima fatica, Carl Gustav Jung, il grande sciamano. Una biografia (per ordini: ordinipv@edizionimediterranne.net, 06/3235433). Si tratta di un lavoro organico, esaustivo, che concede al lettore proficuo accesso, non semplicemente alla biografia esteriore dello psicanalista svizzero, ma rivela i tratti salienti della sua vita interiore e del suo iter “realizzativo”. Giovetti mostra una non comune conoscenza della bibliografia critica dedicata a Jung, la cui esegesi è condotta dall’autrice con pertinenza argomentativa e persuasività d’accenti. Giovetti si sofferma, peraltro, questo il pregio maggiore del volume, su aspetti sinora sottaciuti della personalità di Jung, esposta, fin dall’infanzia, al misterium vitae. La ricostruzione biografica è minuziosa, sostanziata da vasta documentazione e da una prosa affabulatoria che rende gradevole la lettura, come accade in genere nella storiografia biografica anglosassone. Jung, per dirla con Prezzolini, fu davvero “un figlio del secolo” XX (1875-1961), del quale visse le tragedie e gli slanci intellettuali. A parere di chi scrive, per entrare nelle vive cose della trattazione, è bene muovere dal racconto di un sogno infantile del grande intellettuale, riportato dall’autrice. Jung vide, in tale esperienza onirica, un prato verde nel quale: «si apriva una fossa oscura molto profonda […] scese la ripida scala […] in fondo trovò un drappo verde a mo’ di tenda» (p. 27) oltre il quale, in una sala, v’era un trono dorato sormontato da un tronco di carne e pelle, con un grande occhio nella parte superiore. Si trattava del: «fallo rituale, simbolo di vita e potenza, che troviamo all’origine di tante religioni dell’antichità» (pp. 27-28). Fin da bambino Jung, quindi, ebbe sentore della propria missione “sciamanica”: conoscere, attraverso la risoluzione dell’ombra, il Sé, cui si perviene in forza dell’integrazione della personalità. Gli Sciamani, lo rileva Eliade, operarono sempre, nei loro pericolosi viaggi nei “molteplici stati dell’essere”, a beneficio dei loro simili, svelando che, nella physis, tutto è animato, in perpetua relazione, in una prospettiva per dirla con Evola, di trascendenza immanente. Medesimo compito si pose Jung nei confronti della disorientata umanità del Novecento . Non casualmente, Giovetti rileva la possibile discendenza familiare dello svizzero da J. W. Goethe, per il quale Carl mostrò, fin dalla giovinezza, evidente sintonia di visione, in particolare, per le opere scientifiche del poeta (apprezzate, tra gli altri, da Rudolf Steiner). Jung avrebbe voluto laurearsi in archeologia ma, ragioni familiari, lo indussero a studiare medicina e ad occuparsi di psichiatria. Spinto dal professor Bleuler, dedicò la sua tesi di laurea a, Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti. Jung partecipò, sul campo, alle esperienze medianiche della cugina, H. Preiswerk. Egli stesso, del resto, visse esperienze paranormali nelle case in cui abitò: udì “scoppi” provenire dalle librerie e vide un coltello spezzarsi misteriosamente in quattro parti. Questo oggetto fu conservato gelosamente dallo studioso fino alla fine dei suoi giorni. Lo svizzero fu alieno a qualsivoglia dogmatismo, in particolare, rispetto ai fenomeni su indicati, al pregiudizio positivista, negante la possibilità dell’impossibile. Conobbe Freud, che lo elesse al ruolo di allievo prediletto e di possibile successore. Giovetti ricostruisce i rapporti tra i due, rilevando come la causa del loro dissidio non sia imputabile solo a ragioni teoriche. Jung non accettava il dogmatico pansessualismo del padre della psicanalisi che leggeva quale excamotage compensativo della dimensione religiosa rigettata dall’ateo Freud, ma nella rottura un ruolo di rilievo lo svolsero anche le diverse “equazioni personali” dei due uomini. Fu “l’assassinio del Padre” Freud a porre Jung a diretto confronto con l’inconscio. Quel frangente storico fu assai difficile per lo psicologo archetipale che riuscì a superare la crisi grazie a una figura femminile di grande importanza per la sua vita, Tony Wolff. Jung, con questa paziente e allieva, intrattenne una liaison coinvolgente che la moglie Emma riuscì a tollerare in forza dell’amore sincero che la legava a Carl. Del resto, il confronto con l’ “eterno femminino” goethiano ebbe sempre ruolo dirimente per Jung, come testimoniato dalla relazione con Sabine Spielrein, discussa da Giovetti. L’animus maschile e l’anima femminile devono integrarsi per pervenire alla coincidentia oppositorum alchemica. L’interesse junghiano per l’alchimia, sviluppato a seguito della lettura del Mistero del fiore d’oro, è essenziale per la comprensione della psicologia analitica: «La nigredo degli alchimisti corrisponde al confronto con l’Ombra […] L’albedo […] corrisponde all’incontro con l’archetipo dell’anima per il maschio e dell’animus per la femmina […] la rubedo rappresenta l’incontro con l’archetipo del Sé» (p. 125). La lettura del Libro rosso, composto di testi scritti con grafia goticheggiante e disegni, tra i quali molti mandala, chiarisce il tratto immaginale, niente affatto logo-centrico, del pensiero junghiano ed è simbolo del percorso esistenziale-spirituale dello psicoterapeuta. Jung rese evidente tutto ciò nella costruzione della Torre di Bollingen, a cui lavorò in prima persona, architettonica testimonianza del suo universo di riferimento. Un cosmo muto all’approccio casualistico, atto, di contro, a rivelarsi all’approccio analogico e sincronico: «Il concetto di sincronicità […] indica la corrispondenza significativa di eventi senza relazione causale tra loro» (p. 157). Jung fu homo religiosus: in forza dell’integrazione conseguita, poté asserire a conclusione di un’intervista, concessa nell’ultimo periodo della sua vita: «Non ho bisogno di credere, io so!» (p. 207).
Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, il grande sciamano. Una biografia, Edizioni Mediterranee, pp. 210, euro 19,50.
