Il Creato. Parola di Dio
di Valerio Pignatta - 24/11/2025
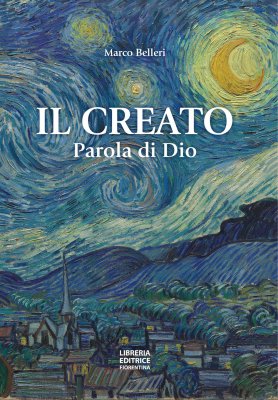
Fonte: Arianna editrice
Nella primavera di quest’anno ha visto la luce un libro che è davvero insolito nel panorama delle opere teologiche del cristianesimo contemporaneo. L’autore, don Marco Belleri, sacerdote e ingegnere, ha condensato in un testo di scorrevole lettura, una vita di riflessioni e pratiche legate al mondo naturale, all’agricoltura, alle piante medicinali e alla salvezza e tutela della creazione. Don Marco è stato coinvolto in tutte queste attività con grande partecipazione e per tanti decenni dall’inizio della sua gioventù sino al grave incidente di qualche anno fa in cui è rimasto completamente paralizzato. Con il suo libro tra le mani è però chiaro che parlare di “completa paralisi” in questo caso sia assolutamente fuori luogo, visti i risultati così importanti di questa riflessione che egli porta nel mondo, mondo in cui tanti esseri umani, molto più giovani e dinamici di lui dal punto di vista muscolo-scheletrico, sono però completamente refrattari al grido disperato di una natura sofferente e in lotta per la sopravvivenza. Infatti, è proprio da questa constatazione vissuta sul campo che si manifesta l’intento del lavoro in questione, ossia sensibilizzare sia e soprattutto l’ambito ecclesiastico, del pari insensibile o quasi sul tema, sia ovviamente tutti gli uomini e donne di buona volontà che volessero comprendere cosa sta accadendo ed essere disponibili al cambiamento per salvare se stessi e il pianeta. Queste ultime possono sembrare parole grosse, ma chi studia i cambiamenti climatici sa benissimo che sono anche troppo miti. Eppure, come ricorda don Marco «Di fronte alla distruzione ambientale gli uomini di Chiesa concentrano le loro analisi più sulle deviazioni dell’attuale sviluppo, ritenuto di per sé buono, che sulle radici di un modo di vivere che provoca tanti mali non per errori di esecuzione dei principi e delle regole, ma proprio per la loro corretta applicazione» (p. 38). La prima parte del libro, infatti, partendo dall’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, cerca di fare un excursus storico sul concetto di natura e il dominio dell’uomo su di essa così come è stato vissuto all’interno della Chiesa nei secoli. Ben pochi personaggi sono coloro che hanno avuto l’intuito di identificare Creato e Verbo di Dio, natura e intimità umana, aspetti pratici di vita materiale e spirituale e teologia morale applicata alla quotidianità. Come recita invece il titolo, l’invito dell’opera è quello di realizzare che la Parola di Dio, o anche la sua azione nel cosmo, è costituita proprio dalla Creazione, che ogni umano ha la gioia di poter esperire in tutta la sua meravigliosa bellezza ed efficienza. Asserendo finalmente la realtà spirituale del mondo materiale si può affermare che «Non bastano dottrine: ci vuole una mistica […] la spiritualità non è disgiunta dal corpo, dalla natura, dal mondo ma vive con essi e in essi […]» (p. 9). Ma da dove parte la situazione disperata in cui vive oggi il pianeta e tutte le sue creature, umani compresi? Come siamo arrivati al punto per cui la società lavora alla distruzione di se stessa e della natura? Una società senza etica e senza direzione morale, dove non si è più nemmeno in grado di afferrare la differenza tra aspetti essenziali dell’esistere e bisogni indotti e superficiali che hanno come conseguenza devastazioni ambientali e guerre di ogni genere. Secondo l’autore la gran parte delle tecnologie che più influenzano la nostra vita e modificano l’alimentazione (base della salute) sono la televisione, il computer, il cellulare, i concimi chimici, le manipolazioni genetiche, i diserbanti e i pesticidi. Queste sono tutte “tecniche” che non sono state precedute da una riflessione e un dialogo morale e nemmeno limitate dal principio di precauzione, con le derive che stiamo vedendo. Il problema, come afferma don Marco, è che «Tante innovazioni tecnologiche decidono esse stesse come dobbiamo comportarci facendo muovere la gente secondo le loro logiche» (p. 16). Ciò perché «Il metodo scientifico già di per sé è una tecnica di dominio; è difficile utilizzare le sue risorse senza essere dominati dalla sua logica» (p. 39). Infatti «La scienza in se stessa non è neutrale, non diventa buona o cattiva solo per il modo in cui viene usata, perché Dio indica ad Adamo l’illiceità di un tipo specifico di conoscenza indipendentemente dal modo in cui la userà e dal perché lo farà» (p. 49). In sintesi, riprendendo un testo di Lynn White jr. le radici storiche della nostra crisi ecologica sono riassumibili in tre punti: «l’atteggiamento di dominio e sfruttamento della terra derivato dal comando di Dio di soggiogare e dominare le altre creature; la desacralizzazione della natura operata dal cristianesimo che la riduce a materiale per soddisfare gli scopi dell’uomo; il ruolo svolto dalla religione giudaico cristiana nello sviluppo della scienza e della tecnica» (p. 56). E va ricordato che, come precisa la Laudato si’ (paragrafo 107): «I prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà sono scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare». Che fare dunque? Oggi l’«unica via per arrestare o arginare il degrado è ridurre i consumi» (p. 113) e i desideri più folli e instillati nelle menti umane da un liberismo del benessere che di benefico non ha assolutamente nulla. È tutto produzione di merci che devono trovare un acquirente; in tutti gli ambiti, anche quelli più delicati come la sanità. Come rileva l’autore infatti «il sistema sanitario crea incessantemente nuovi bisogni terapeutici. E via via che l’offerta di sanità aumenta, la gente risponde adducendo più problemi, bisogni, malattie. Nei paesi sviluppati l’ossessione della salute perfetta è diventata il fattore patogeno predominante» (p. 136). Ciò solo perché i soliti noti si possano arricchire. Ma sappiamo bene che «Se alcuni sono poveri è perché altri hanno accumulato» (p. 150). Queste griglie di interpretazione della società care a don Marco sono antiche nel cristianesimo e si possono far risalire a grandi Padri della Chiesa come Basilio, Ambrogio o Giovanni Crisostomo. Seppure citare costoro faccia oggi pensare a modalità “rigide” di vita cristiana, è anche vero che persino le forme più autentiche e profonde di ascetismo dei primi secoli non avevano nulla a che fare col disprezzo della creazione e della miseria umana che vediamo oggigiorno (p. 71). In questa società, osserva don Marco, ci troviamo di fronte a milioni di persone che letteralmente non sanno più fare nulla (p. 130) se non digitare tastiere, incoscienti (o infischiandosene) delle conseguenze delle loro azioni sul resto del mondo vivente. Nondimeno «La fede, la fraternità e la giustizia non si fermano all’ambito umano ma si [devono estendere] a tutta la natura» (p. 167) se vogliamo che ci sia ancora un mondo per le generazioni future. Se gli umani non sono più in grado di comunicare tra loro, divisi dalle grandi distanze della comunicazione elettronica e degli schermi, e non sono più capaci di ripensare una società armonica, erede della visione di Dio per questa terra, è anche perché non ci si ferma nel bel mezzo della propria esistenza a meditare su ciò che siamo, facciamo e che potremmo realizzare. Via, traditi dalla velocità di una fuga esistenziale che pare più che altro avidità inappagata di tempo, successo e denaro. Eppure non ci vorrebbe molto per adempiere e sperimentare la gioia che nasce quando di unisce l’operare in sintonia con la creazione con i dettami della coscienza: «La difficoltà di rapporti fra persone è sempre più chiara perché sono da inventare tutti i livelli di relazione, distrutti da una mancanza di spazio comunitario, sparito assieme all’ambiente vitale-locale, da curare come ricchezza da cui la comunità dipende. Per superare questo dramma occorre ricostituire tanti piccoli popoli fondati su un’economia locale che trae il suo sostentamento fondamentale dalla terra e dall’artigianato. La globalizzazione non è unità, ma servitù collettiva» (p. 153). Il pensiero qui va subito alla proposta gandhiana di villaggio autonomo che forse ha ancora tanto da offrire all’uomo contemporaneo, così come le tradizioni culturali delle comunità aborigene, indicate anche dall’autore come modelli di civiltà e orientamenti da seguire (p. 170) (come ha del resto sottolineato papa Francesco nella Laudato si’ al paragrafo 146 a esse dedicato).
Marco Belleri, Il Creato. Parola di Dio, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2025
