Il mito dei diritti
di Marco Spada - 26/10/2025
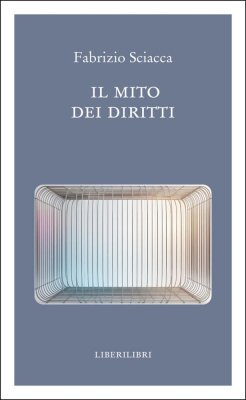
Fonte: Barbadillo
Con rigore filosofico, il professore Fabrizio Sciacca (ordinario di Filosofia politica – Università di Catania) indaga la genesi mitica dei diritti moderni e ne svela la trasformazione in una nuova teologia civile dell’Occidente.
V’è nei diritti moderni una promessa di redenzione che ha finito per assumere i tratti rassicuranti della liturgia: la forza salvifica di parole che, a furia di ripetersi, hanno obliato la loro genealogia. Il merito decisivo del libro diFabrizio Sciacca, Il mito dei diritti (Liberilibri, 2025), è di spezzare questa ipnosi, restituendo alla questione dei diritti la gravità del pensiero e la concretezza della storia. L’itinerario proposto, che si snoda dallo sguardo storico alle radici filosofiche, fino alla tensione tra libertà e proprietà e alla torsione odierna dei “diritti di gruppo”, si sviluppa con rigore e coerenza che raramente trovano eguali nel dibattito odierno: non v’è compiacimento demolitorio né iconoclastia a buon mercato, ma un paziente démontage delle narrazioni dominanti e, al tempo stesso, la profilatura di un’alternativa: rifondare i diritti all’individuo concreto, alla responsabilità, alla proprietà, a limiti chiari posti al potere. Il punto di partenza è esattamente quello che la nostra epoca rimuove: i linguaggi non sono strumenti neutri, ma conservano mitologie e sedimentazioni simboliche che orientano ciò che riteniamo visibile, dicibile, legittimo. In questa chiave, la modernità politica — a partire dal tornante rivoluzionario francese — ha trasferito la sacralità dall’altare alla norma, convertendo i luoghi antichi in templi civili e investendo l’idea di diritto di una nuova aura. Tuttavia, la sacralizzazione secolare non basta a garantire verità: ciò che si presenta come universale nasce in contesti storici determinati, risponde a conflitti concreti, inaugura inclusioni ed esclusioni che la retorica tende a occultare.
La modernità come nuova sacralità
È qui che il dialogo con Nietzsche diventa fecondo: una genealogia dei diritti mostra come la morale dell’eguaglianza non sia una vetta etica inattingibile, bensì un esito storico di forze e risentimenti, una “umanità addomesticata” che pretende di assolutizzare ciò che è nato come strumento. Sciacca non indulge a una caricatura nichilista; piuttosto, assume la lezione nietzschiana come avvertenza metodologica: ogni pretesa di universalità va interrogata nelle sue funzioni, nei suoi costi, nei suoi effetti di potere. In questa luce, il libro mette a fuoco un paradosso: i diritti che proclamano la massima emancipazione si rovesciano spesso in rituali dell’obbedienza, nell’amministrazione degli stili di vita, nella tutela paternalistica di soggetti che vengono riconosciuti solo nella misura in cui si conformano a categorie astratte o a gruppi “bersaglio”. La comparsa dei target groups e dei target rights è letta, con acume, come un segno di stanchezza teorica: invece di pensare la persona e le sue spettanze, si moltiplicano identità giuridiche parziali che chiedono protezione politica e ottengono, in cambio, dipendenza.
La genealogia della libertà
La diagnosi si precisa quando Sciacca attraversa i classici della filosofia pratica moderna. Con Locke il baricentro si sposta sull’atto volitivo e sul lavoro come fonte della proprietà: qui il diritto non è invenzione della legge, ma presidio delle facoltà originarie dell’individuo. Tuttavia — ed è un punto che la modernità ha spesso sottaciuto — il fondamento proprietario può generare disuguaglianze legittime, una dinamica che la mano pubblica tende ciclicamente a moralizzare, dimenticando la differenza tra principio e risultato. Kant ricolloca i diritti nello spazio dell’autonomia: lo «ius connatum», radicato nella personalità, è la prima parola di un ordine che vincola prima di persuadere. Hegel sottrae la materia sia all’astrazione sia al moralismo: diritto e Stato si fanno storia, Sittlichkeit, intreccio di eticità e istituzione in cui il singolo non è annientato ma situato. Sciacca non tratta questi autori come emblemi da manuale: li obbliga a misurarsi con il nervo scoperto del presente. Così Mandeville riemerge non come apologeta dell’egoismo, ma come pensatore dell’inevitabile frizione tra motivazioni private ed esiti pubblici: là dove l’ordine cresce dai vizi ordinari, l’enfasi redentiva dei diritti mostra la sua impotenza; e nel lungo arco che da Mandeville conduce all’idea di ordine spontaneo, il libro intuisce la possibilità di una genealogia diversa della libertà, fatta di scambi, responsabilità, limiti all’ingerenza. A questo asse liberale-classico si aggancia l’analisi di Sciacca su libertà e proprietà, fino al confronto con la critica radicale di Hoppe ai diritti sociali, intesi come espropriazione mascherata: anche qui non si tratta di anatemi, ma di chiedere conto dei costi reali e degli incentivi prodotti da ogni estensione “salvifica” del lessico dei diritti. La sezione dedicata alle filosofie dei diritti affronta con rara chiarezza la disputa tra teorie dell’interesse e della volontà, evitando sia il formalismo sia l’impressionismo: la domanda non è quale definizione suoni meglio al senso comune, ma quale struttura concettuale protegga davvero beni e scelte dell’individuo senza consegnarlo a una pedagogia statale infinita. In tal senso, l’analisi di Kramer e il richiamo ai “modelli” di Williams si saldano a una riconsiderazione sobria della tolleranza: non strumento di verità, ma condizione di pace tra visioni rivali, come suggerisce Gray; non adesione edificante a valori comuni, ma dispositivo politico che accetta la conflittualità senza demonizzarla. È su questo crinale che la comparazione con Schmitt diventa illuminante: l’universalizzazione dei diritti tende a mascherare la dimensione del politico come distinzione amico-nemico, de-politicizzando i conflitti reali sotto il velo della neutralità morale. In realtà, i diritti universalizzati trasformano la decisione in amministrazione, la sovranità in procedura; ma quando l’eccezione irrompe — crisi migratorie, emergenze sanitarie, choc energetici — riappare l’originario: chi decide sullo stato d’eccezione? Sciacca non arruola Schmitt a sostegno di un autoritarismo d’antan; ne assume la domanda radicale, mostrando che un ordine di diritti che non sa dove risieda l’ultima decisione è fragile, e che la fragilità è amplificata quando l’universalismo si fa ideologia. A questa linea si intreccia la meditazione heideggeriana sul linguaggio e sull’epoca della tecnica: se il linguaggio è la casa dell’Essere, la retorica dei diritti può diventare, nell’età del Gestell, un dispositivo che calcola e dispone, riducendo la persona a portatore di pretese standardizzate.
Dal cosmos al caos: il destino dell’Occidente
La cura di Sciacca per il lessico — dal rifiuto di una confusione tra morale e diritto nell’odierno uso inflazionato di “discriminazione”, fino alla distinzione tra fatti e valori nel terreno della tolleranza — indica un lavoro di igiene concettuale che manca spesso nelle nostre polemiche. Il percorso storico-concettuale non dimentica, significativamente, la lunga architettura romana: prima ancora che nella filosofia, il diritto si plasma in forme, atti, performatività che custodiscono il senso dell’appropriazione, del vincolo, del trasferimento. È un richiamo prezioso: i diritti non nascono come astrazioni generose, ma come forme precise della vita giuridica, e ogni forzatura moralistica che pretenda di piegarle all’emozione del giorno corrompe il patto tra persone e istituzioni. Quando il libro affronta contrattualismo, minimalismo statale, pluralismo, comunitarismo, mostra come molte grandi teorie del Novecento, da Rawls a Nozick, da Walzer a Sandel e MacIntyre, possano essere riattraversate per misurare i confini di un lessico che ha promesso troppo e presidiato poco. In filigrana si staglia una tesi impegnativa: i diritti vanno salvati dal loro stesso mito. Ciò implica ripensare l’universalità non come proiezione di una morale generica, ma come architettura di garanzie per individui situati; implica riconoscere che l’egualitarismo senza misura genera cattiva politica e cattivo diritto; implica, infine, accettare che una società libera non è una società che cura paternalisticamente ogni vulnerabilità, ma una che regola il conflitto, protegge la proprietà, esige responsabilità, limita l’intervento pubblico alle sue funzioni essenziali. Nel finale, la diagnosi si fa austera: l’identità occidentale sembra vivere una torsione che conduce dal cosmo al caos, cioè dalla forma alla dismisura; e proprio per questo un libro come questo si impone come un gesto controcorrente. Il mito dei diritti non è un pamphlet; è un invito a dismettere i motti, a guardare dentro le parole e dentro le istituzioni, a ricondurre i diritti alla loro ragione d’essere: garantire la libertà di persone reali in ordinamenti finiti. In un’epoca dominata dai calembours moralistici e dai decreti performativi dell’indignazione, la sua voce suona più necessaria che mai: severa, misurata, chiarissima.
