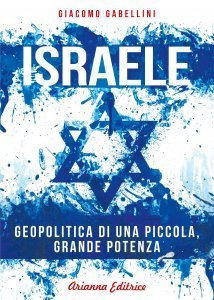Israele: di false flag in false flag?
di Giacomo Gabellini - 04/07/2025

Fonte: Strategic Culture
Il 26 giugno, il «Tehran Times» ha riferito di un’operazione sotto falsa bandiera (false flag) che Israele avrebbe organizzato sul suolo statunitense con l’obiettivo di attribuirne la responsabilità all’Iran e trascinare così Washington in una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica.
Il piano, scrive il quotidiano iraniano, contemplava l’innesco di un ordigno esplosivo all’interno degli Stati Uniti, la fabbricazione di prove a carico di Teheran e lo scatenamento di una imponente campagna propagandistica atta a costruire consenso popolare attorno all’opzione relativa all’intervento militare diretto contro l’Iran. Un non specificato Paese amico avrebbe comunicato il contenuto delle pianificazioni israeliane al governo Pezeshkian e al Vevak, i quali avrebbero a loro volta allertato con il dovuto tempismo le autorità statunitensi prevenendo la consumazione dell’atto.
La notizia riportata dal «Tehran Times», di cui è al momento impossibile appurare la fondatezza, ha trovato scarsissima eco in Occidente, sebbene Israele abbia alle spalle una consolidata tradizione di operazioni sotto falsa bandiera. La prima risale al 1954, quando in cima alla scala delle priorità del governo di Tel Aviv figurava il rovesciamento del presidente Gamaal Nasser. Vale a dire il vivacissimo leader degli “ufficiali liberi” che nel 1952 avevano conquistato il potere deponendo re Faruk. Come rileva lo storico Eugene Rogan: «dal 1954 fino alla sua morte nel 1970, Nasser fu presidente dell’Egitto e supremo comandante del mondo arabo. Nessun leader arabo, né prima né dopo di lui, ha mai esercitato un’influenza paragonabile e pochi possono essere collocati al suo livello per rilievo sulla scena mondiale. Per l’Egitto era l’inizio di un’incredibile avventura, anni di pura adrenalina nei quali tutto sembrò possibile […]. La tensione era alta lungo i fragili confini tra l’Egitto e lo Stato ebraico. Il primo ministro Ben-Gurion aveva compiuto una serie di tentativi per saggiare le intenzioni degli “ufficiali liberi”, ma Nasser e i suoi avevano evitato ogni contatto diretto con gli israeliani (ci furono scambi segreti nel 1953 a Parigi, peraltro senza risultati). Il premier israeliano arrivò alla conclusione che l’Egitto, con il suo nuovo governo militare, poteva diventare la Prussia del mondo arabo e, in quanto tale, rappresentava per Israele un pericolo presente e reale».
Sulla base di valutazioni di questo tenore, il governo israeliano elaborò l’Operazione Soshanna, nel cui ambito un manipolo di ebrei egiziani reclutati dal Mossad organizzarono una catena di attentati dinamitardi contro sedi istituzionali sia inglesi che statunitensi situate al Cairo e ad Alessandria, facendone ricadere la responsabilità sui Fratelli Musulmani e sulle forze comuniste locali. L’obiettivo consisteva nell’alimentare la conflittualità sociale interna all’Egitto. La destabilizzazione violenta del Paese che ne sarebbe scaturita avrebbe indotto Washington a invalidare l’accordo precedentemente sottoscritto da Londra e dal Cairo implicante l’evacuazione dei contingenti militari stranieri dall’Egitto. Si trattava, in altri termini, di ottenere dall’amministrazione Eisenhower l’appoggio politico necessario per prolungare lo stazionamento delle truppe britanniche di occupazione nell’area circostante al Canale di Suez, di cui Nasser aveva già messo in cantiere la nazionalizzazione. Una combinazione di scarsa pianificazione, mancato coordinamento tra le forze in campo e palese impreparazione degli attentatori, alcuni arrestati in flagrante mentre gli altri rimasero vittime degli ordigni che avevano piazzato, pose le autorità egiziane nelle condizioni di smascherare agevolmente i mandanti, spingendo il ministro della Difesa israeliano Pinhas Lavon alle dimissioni. Il governo Tel Aviv parlò di “sfortunato incidente” negando seccamente qualsiasi coinvolgimento. Solo nel 2005, a 51 anni di distanza, le autorità israeliane decisero di riconoscere la paternità dell’Operazione Soshanna decorando gli agenti sopravvissuti, i quali ricevettero anche attestati di stima da parte del presidente israeliano Moshe Katsav.
La più nota operazione sotto falsa bandiera realizzata da Israele è tuttavia rappresentata dal caso della Uss Liberty, una delle pagine più oscure della storia della marina statunitense e più in generale del peculiare rapporto intercorrente tra Washington e Tel Aviv. L’8 giugno 1967, durante la Guerra dei Sei Giorni, la nave spia statunitense Uss Liberty, operante per conto della National Security Agency e inquadrata nella VI Flotta, fu bersagliata per circa due mentre incrociava in acque internazionali al largo delle coste del Sinai da colpi di cannone da 30 mm, missili, bombe al napalm e proiettili di mitragliatrice lanciati da un gruppo di fuoco composto da motosiluranti e velivoli Mirage-3 senza bandiera. In quello che a tutt’oggi si configura come il più grave attacco mai subito da una nave della Marina statunitense in tempo di pace, 34 tra marinai e personale civile persero la vita e altri 171 rimasero feriti.
L’affondamento della nave e la morte dell’intero equipaggio fu sventata soltanto dall’intervento di Terry Halbardier, marinaio ventitreenne che, sotto il fuoco israeliano, uscì su ponte per collegare un cavo di comunicazione e consentire alla Uss Liberty di inviare un segnale d’allarme. Gli israeliani intercettarono il messaggio e posero fine all’attacco, prevedendo l’imminente intervento della VI Flotta. Il governo di Tel Aviv cercò immediatamente di giustificarsi asserendo di aver “scambiato” la Uss Liberty per un naviglio egiziano, nonostante velivoli dello Stato ebraico avessero ripetutamente identificato la nave statunitense sul cui ponte torreggiava in bella vista la bandiera a stelle e strisce. La versione israeliana non spiega inoltre perché nessuna delle componenti del gruppo di fuoco recasse alcun simbolo identificativo, tanto più necessario in quanto Israele era in guerra con l’Egitto.
Senonché, gli otto caccia che erano decollati dalla portaerei Uss Saratoga subito dopo il rilevamento del Sos inviato dalla Uss Liberty furono richiamati a pochi minuti di distanza dal vice-ammiraglio William Martin. Di fronte all’insistenza dell’ammiraglio Lawrence Geiss, comandante della VI Flotta, che continuava a chiedere l’autorizzazione a inviare uno stormo di velivoli a protezione della nave sotto attacco israeliano, il segretario alla Difesa Robert McNamara rispose laconicamente che «il presidente Johnson non intende entrare in guerra o mettere in imbarazzo un Paese alleato per una questione che riguarda pochi marinai».
La successiva decisione del presidente Lyndon Johnson di imporre ai testimoni oculari sopravvissuti di mantenere il silenzio sulla vicenda dietro minaccia della corte marziale risulta perfettamente in linea con la sbalorditiva reazione opposta a caldo. Da alcuni documenti israeliani successivamente desecretati e visionati da «al-Jazeera» emerge che la leadership dello Stato ebraico aveva intimato a Johnson di insabbiare la vicenda, pena la sospensione dei finanziamenti da parte della Israel Lobby e l’attivazione dell’efficacissima “macchina del fango” nei suoi confronti – benché Johnson venga ancora oggi annoverato come uno dei presidenti più filo-israeliani della storia degli Stati Uniti.
Un accoglimento delle richieste israeliane, viceversa, sarebbe stato premiato con la discesa in campo del potentissimo American Israel Public Affairs Committee (Aipac), il quale avrebbe messo tutte le proprie risorse a disposizione di una campagna mediatica atta a nobilitare la Guerra del Vietnam in vista delle elezioni che si sarebbero tenute l’anno successivo. Ma non è tutto. Secondo quanto rivelato da Bobby Ray Inman, ex direttore della National Security Agency ed ex alto funzionario della Cia, nei giorni successivi all’attacco israeliano alla Uss Liberty un ufficiale israeliano si sarebbe recato all’ambasciata statunitense a Tel Aviv per informare i diplomatici Usa che i missili terra-aria di fabbricazione sovietica che l’esercito israeliano aveva sequestrato alle forze egiziane erano gli stessi che i guerriglieri al comando del generale Giap impiegavano per abbattere i velivoli statunitensi in Vietnam. Nel caso in cui Johnson avesse rifornito lo Stato ebraico dei mezzi militari necessari a ripianare le perdute subite durante la Guerra dei Sei Giorni e ordinato agli investigatori del Pentagono e del Dipartimento di Stato di interrompere le indagini sull’accaduto bollando l’episodio come uno spiacevole incidente, gli israeliani avrebbero immediatamente messo i missili e i relativi lanciatori (oltre al manuale operativo) a disposizione degli esperti statunitensi. Cosa che avrebbe consentito a Johnson di ridurre le perdite tra le fila delle forze armate statunitensi e mitigare così le ricadute negative che la morte di migliaia di soldati americani – ben documentata dai media – stava producendo sulla sua popolarità. Per Inman, il ricatto israeliano nei confronti di Johnson puntava a costringere gli Stati Uniti a mantenere celata la reale natura dell’attacco alla Uss Liberty, vale a dire un’operazione concepita dal governo israeliano guidato da Levi Eshkol con l’obiettivo di trascinare gli Stati Uniti in un conflitto possibilmente risolutivo con l’Egitto di Nasser.
Resta da vedere se, a settantun anni dal “Lavon affaire” e a cinquantotto dal caso Uss Liberty, Israele abbia seriamente ventilato la possibilità di ricorrere ai “vecchi trucchi” per forzare la mano agli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. E, soprattutto, se abbia dato concretamente seguito a simili intendimenti.