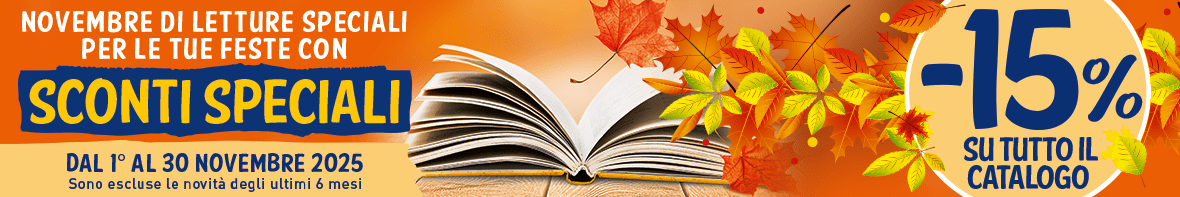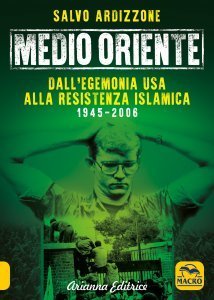Medioceano e Medio Oriente: appunti per un teatro geopolitico cruciale
di Salvo Ardizzone - 05/02/2023

Fonte: Italicum
L’Asse della Resistenza, rappresenta la proiezione di una dottrina di liberazione dei popoli mediorientali. L’Italia deve cogliere le opportunità offerte dalla nostra posizione nel “Medioceano”, facendo tesoro della lezione di Mattei.
Inquadramento e rilevanza dell’area
Il Medioceano, e il Medio Oriente che vi insiste attorno e lo contorna, è scenario cruciale, irrinunciabile per l’Europa, che vi si affaccia, e per l’Italia, che vi è protesa. Il Mediterraneo è sempre stato area di scambi, mare di commerci e traffici per eccellenza ma, da alcuni anni, è evoluto a Medioceano, bacino allargato alle coste atlantiche del Maghreb e della Penisola Iberica a Occidente, fino al Corno d’Africa attraverso il Mar Rosso a sud-est, connessione fra l’area indo-pacifica e l’Atlantico. Di recente amputato del Mar Nero e delle crescenti connessioni con la Russia e l’Asia Centrale dal conflitto ucraino ma, a seguito di esso, elevato ad area di confronto-scontro fra Unipolarismo egemonico e Multipolarismo.
Malgrado rappresenti il 2% dei mari, è attraversato da oltre il 25% dei traffici globali; un flusso di petrolio, gas liquefatto, materie prime, semilavorati e prodotti finiti in rapida crescita, a seguito dell’ampliamento del canale di Suez, a cui si aggiunge il più massiccio sistema di cavi Internet al mondo, che connette area indo-pacifica e area atlantica passando a ridosso delle coste siciliane.
A incrementare la sua rilevanza, il suo bacino orientale ha rivelato una colossale concentrazione di giacimenti gasieri – più che mai preziosi nelle condizioni attuali – su cui si appuntano mire, interessi e aspettative di attori rivieraschi e più lontani coinvolti a vario titolo nel grande risiko delle forniture energetiche (o aspiranti tali).
L’intera costa sud e quella orientale di questo bacino cruciale è il MENA (Middle East – North Africa); l’imbocco orientale, Suez, e il bacino del Mar Rosso fino all’Oceano Indiano lo è pure, come anche la parte sud dell’accesso occidentale, Gibilterra, e i paesi rivieraschi vi gravitano sempre più assertivi (Turchia ma anche Algeria su tutti). Basterebbe questo a rendere il Medio Oriente rilevante, ma c’è molto di più.
Il MENA ha un cuore energetico; limitandoci all’Italia, da Algeria (Transmed) e Libia (Greenstream) provengono gasdotti indispensabili e dalla Turchia arriva il Trans Adriatic Pipeline (TAP); a essi bisogna aggiungere gli altri che arrivano in Spagna e quelli (assai più rilevanti) che risalgono i Balcani alimentati da Turkish Stream e Blue Stream che portano (e nel futuro ne porteranno assai più) gas dall’Asia Centrale e dalla Russia per interposta Turchia.
Ma non c’è solo il gas: a parte i terminal petroliferi della Cirenaica e algerini, che danno sbocco alle produzioni del Sahara, il Golfo Persico – fulcro del Medio Oriente – ha un’enorme produzione di greggio e, in epoca più recente, di gas. È questo il punto che ha reso le vicende geopolitiche di quell’area assai più vicine a noi di quanto s’immagini.
Un po’ di Storia per inquadrare le dinamiche
Che dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale l’Europa sia stata spaccata in due e sottoposta a due sudditanze è cosa più che nota, lo è meno che Roosevelt, tornando da Yalta, in quel febbraio del 1945 si sia fermato nel Mar Rosso, accogliendo il re saudita Abdulaziz bin Saud sull’incrociatore USS Quincy per stipulare un felice accordo d’interessi: le riserve petrolifere saudite chiuse nel forziere americano in cambio di una garanzia di sicurezza data al trono saudita e alle altre monarchie del Golfo che presto si sarebbero accodate. In questo modo, il fresco Egemone si garantiva le risorse (e in ogni caso le toglieva alla disposizione degli altri) per il suo progetto di primazia globale. Come da copione, poi reiterato infinite volte, offrì sicurezza e dollari che, da rivoli iniziali, presero a scorrere a fiumi sulle sabbie (beninteso: destinati ai regnanti non allo sviluppo delle popolazioni, tacitate con regalie e sussidi).
In pochi anni, espulse le residue influenze inglesi, nell’area del Golfo fu instaurato un sistema di egemonia che puntellava regni allora vassalli (col tempo, e l’arma del petrolio che impararono a usare – quantomeno dal 1973 – ascesi a partner) con gli USA come riferimento e l’Iran dello Shah come guardiano. Un quadro consolidato che attraversò i decenni senza che la sua sostanza mutasse molto, malgrado gli sconvolgimenti della “Guerra Fredda” (che, col senno del poi, meglio sarebbe chiamare “Pace Calda”). Nel frattempo, nel Mediterraneo la VI^ Flotta, più che mai presente, si confrontava con la V^ Eskadra russa, in un gioco di equilibri che, comunque, vedevano l’Egemone al centro, attento che poco o nulla mutasse.
Ma le cose cambiarono, e radicalmente, dove gli USA meno se lo aspettavano, in Iran, con ciò confermando ancora una volta la loro incapacità di percezione delle potenzialità rivoluzionarie espresse da realtà diverse dai canoni liberali e liberisti (lezioni ce n’erano già state, sia nel loro cortile di casa, a Cuba, sia in Medio Oriente, sia nel Sud-Est Asiatico, dove l’umiliazione del Vietnam era fresca); in pratica, a rilevare è la strutturale mancanza di comprensione del sentire profondo di popoli “altri” che non s’allineano al pensiero mainstream. Il successo della Rivoluzione Islamica per il Medio Oriente segnò una cesura fra il prima e il dopo per le implicazioni che portò e porta nell’area, piaccia o no, influenzandone in modo determinante le dinamiche principali.
E per inciso, una conseguenza di cruciale rilevanza geopolitica fu il radicale cambiamento del ruolo attribuito a Israele: contrariamente a una vulgata superficiale quanto diffusa, all’origine l’entità israeliana fu percepita dall’establishment americano come un potenziale fattore di disordine e tensione in un’area delicata di cui reggeva gli equilibri; attese il 1970, in occasione del “Settembre Nero” giordano, per includerla nel suo schema di potere, inserendola fra i suoi possibili attori.
Fu solo con la caduta dello Shah che la elevò a suo pilastro irrinunciabile nella regione, con conseguenze difficilmente calcolabili ma successivamente spiegabili con la sostanziale assonanza fra le Dottrine Bernard Lewis e Odet Yinon, che si diffusero fra gli establishment americano e israeliano pochi anni dopo, dando giustificazione teorica sia alle successive “imprese” dei neocon statunitensi (avvio della “Guerra al Terrore”, la creazione del “Nemico” islamico e invasioni in Afghanistan, Golfo, etc.), sia a quelle sioniste in Palestina e Libano.
Tralasciando la Storia di quegli anni – assai interessante ma ci porterebbe troppo lontano – si coglie tuttavia un parallelo, quanto meno temporale, tra il sistema di dominio imposto dagli USA sul Medio Oriente e quello che essi stesero sull’Europa e esercitarono quale potenza talassocratica sul Mediterraneo e sulle acque a esso collegate. Una differenza rilevante è che, malgrado ogni tipo di aggressioni politiche, economiche e militari, in quell’area si è comunque sviluppata una dottrina di frontale contrapposizione all’egemonismo americano e al progetto sionista in Palestina, alla (pseudo)cultura liberale e al modello di sviluppo liberista.
Un movimento rivoluzionario che trae valori e principi dal sentire profondo delle popolazioni, contrariamente alla vulgata mainstream a prescindere dal credo religioso (a quei gruppi appartengono sciiti, sunniti, cristiani, yazidi, curdi, drusi ed elementi di tutti i credi e le etnie dell’area) e che si articola nei vari paesi in cui si instaura, definendosi in funzione delle specifiche caratteristiche culturali, sociali ed economiche dei vari luoghi.
Insomma, la Dottrina della Resistenza, portata avanti dai vari movimenti rivoluzionari che vi si riconoscono e che compongono l’Asse della Resistenza, rappresenta la proiezione di una dottrina di liberazione dei popoli mediorientali.
Il cozzo fra tale dottrina e i regimi instaurati nell’ambito del sistema egemonico USA rappresenta la dinamica principale e dirimente che si sviluppa in Medio Oriente e si riverbera, inevitabilmente, fino al Medioceano e alle acque collegate.
È da rimarcare come tale movimento, malgrado sotto attacco da 44 anni, sottoposto a guerre d’aggressione, sanzioni estreme, atti di terrorismo e sistematici tentativi di sovversione, non solo non sia stato soffocato ma sia stato capace d’irradiarsi e radicarsi in un crescente numero di paesi, con ciò testimoniando:
– di essere l’interpretazione delle culture e valori profondi di quei popoli;
– di essere l’unico vasto movimento capace d’opporsi con efficacia crescente all’Unipolarismo egemonico americano, ai (pseudo)valori della società globalista, ai modelli di sviluppo liberisti (ed è per questo che è ossessivamente demonizzato dalla vulgata mainstream.
Per tali caratteristiche è perciò una realtà da studiare, a cui tributare quantomeno rispetto.
Ciò detto, la situazione nel MENA non mutò e, scomparsa l’URSS e dimidiata la caratura della Russia (per anni alle prese con la stessa sopravvivenza), si diradò la presenza americana nel Mediterraneo da cui, tuttavia, l’Egemone non allontanò occhi e presa. Fu in anni più recenti, al tempo delle Presidenze Obama, che la regione ebbe un sussulto capace di sovvertire i suoi equilibri: la stagione delle cosiddette “primavere arabe”, vetrine posticce costruite dal mainstream mediatico occidentale. In realtà, dietro al supposto “scontro di civiltà” c’era la voglia di rovesciare governi “scomodi” per sostituirli con altri più “funzionali”.
Per l’Egemone il risultato non fu affatto quello sperato: talvolta si cambiò tutto perché tutto rimanesse come prima (Tunisia), altre accadde che, distrutto un regime, andasse in pezzi anche lo stato (Libia), altre ancora che, abbattuto un “Rais”, chi fu chiamato a sostituirlo si dimostrasse talmente inadeguato da essere subito rovesciato da un altro despota (Egitto). Anche i tentativi reiterati di destabilizzare del tutto l’Iraq e rovesciare il governo in Siria, smembrando il paese, fallirono. Nel complesso, per gli Stati Uniti (e per l’Amministrazione Obama che, stando ai documenti successivamente desecretati, molto si era spesa) l’operazione si rivelò un fallimento ma le conseguenze gravano ancora sulla regione.
Tuttavia, malgrado le pretese di egemonia sull’intero pianeta che gli USA continuavano ad avanzare, la Storia non si era fermata e il mondo cominciava ad avviarsi a un multipolarismo, quantomeno commerciale ed economico, con l’affacciarsi di nuovi paesi alla ribalta, spostando il baricentro del globo verso l’Oriente. Una tendenza che indusse lo stesso Obama (per interposta Hillary Clinton) a inaugurare la politica del “Pivot Asia”, il “Perno Asiatico” che, nelle intenzioni americane, era destinato a contenere la Cina, “colpevole” di crescere troppo e “chiedere” un posto commisurato al suo sviluppo.
La dinamica che ha portato all’ascesa della Cina, unico aspirante egemone globale in tempi recenti a non appartenere alla sfera occidentale, per la novità, le caratteristiche del tutto diverse e la cultura “altra” di cui è intrisa, meriterebbe per la rilevanza una trattazione a parte che ne analizzi specificità e tendenze. Tuttavia, tornando al teatro qui esaminato, essa ha innescato almeno due processi:
– il progressivo allontanamento degli interessi (e risorse) americani da un’area ritenuta non più cruciale verso l’Asia-Pacifico (divenuto presto Indo-Pacifico);
– la graduale trasformazione del Mediterraneo in Medioceano, da mare chiuso a collettore tra area atlantica e area indopacifica, le più rilevanti del pianeta.
Lo scoppio della “Guerra Grande” e le conseguenze generali
L’anno che è trascorso ha visto lo scoppio ufficiale della “Guerra Grande”, in realtà in corso già da tempo. La “Guerra Grande” è una felice allocuzione, coniata dalla rivista Limes, per denominare il cozzo fra l’Unipolarismo egemone americano e il resto del mondo, 1 Mrd di persone v/s altri 7, per mantenere il predominio globale. Nel suo complesso non è affatto uno scontro fra due blocchi; una tale visione, mutuata dalla Guerra Fredda, è accreditata dalla narrazione ufficiale americana per dipingere il conflitto in atto come la lotta del “Mondo libero” contro le autocrazie.
Per comprendere le dinamiche in corso, è opportuno formulare alcune riflessioni:
1): L’Egemone è in crisi, spaccato fra due anime, concentrato sul suo sfidante asiatico stenta a mantenere il controllo su un mondo riottoso ad accettare ancora un assoggettamento. Al suo interno, i contrasti fra due visioni inconciliabili si radicalizzano; all’esterno, anche partner antichi cercano nuovi rapporti (vedi nel Golfo). Unico dominio incontrastato (riacquisito) resta l’Europa.
Con la guerra in Ucraina gli USA hanno conseguito i loro obiettivi (riaffermare il controllo sull’Europa, isolare e ridimensionare la Germania, allontanare Mosca dall’Europa e indebolirla), ora non hanno interesse a distruggere la Russia e non vogliono rischiare uno scontro nucleare; il dibattito all’interno del loro establishment è sul quando e come troncare il conflitto, non sul se. Per questo è prevedibile (ed è già emersa) una crescente divaricazione con l’attuale governo di Kiev, il cui unico risultato utile sta nella prosecuzione e allargamento del conflitto.
Ma, come detto, Washington ha gravi problemi interni derivanti dalla spaccatura fra due “Americhe” inconciliabili, semplificando Coste e Heartland, la cui portata e dimensione va aldilà di quanto mostrato alle recenti elezioni di Midterm ed è scarsamente percepita fuori dagli USA. Non si tratta solo di una divisione fra “trumpiani” e “liberal” o fra “rossi” repubblicani e “azzurri” democratici, è assai più complessa; d’altronde Trump è solo un soggetto che ha catalizzato una dinamica cruciale della società americana intestandosela e, una volta “sdoganata”, nell’orizzonte politico statunitense oggi sono in molti a farsi largo per cavalcarla.
È in questa situazione di fragilità interna che gli USA devono concentrarsi sull’Indo-Pacifico, tentando di non perdere troppe posizioni nel resto del mondo. Impresa proibitiva per un Egemone in affanno, oberato di sfide e nuovi sfidanti, con l’opinione pubblica sempre più riottosa ad accollarsi costi e fatiche di un Impero che comprende sempre meno, verticalmente divisa su tutto, impegnata a distruggere le basi su cui si regge.
2): Il resto del mondo non è blocco monolitico né, tantomeno, sottoposto ad altro attore; la contrapposizione agli USA nasce dal rifiuto di un numero crescente di paesi d’essere egemonizzati, è il principale motivo di loro convergenza; essi vogliono perseguire i propri interessi nazionali al di là da “blocchi”. Infatti, nei vari format cui danno vita per associarsi, vedi BRICS, convivono realtà assai diverse, fino all’antagonismo (come India e Cina).
3): l’Unipolarismo è in crisi evidente ma il passaggio al Multipolarismo è tutt’altro che avvenuto, da un canto per l’ovvia opposizione degli USA, ma dall’altro, ed è a mio avviso più rilevante, non potrà dirsi compiuto finché i soggetti che emergono conservano i medesimi modelli liberisti dell’Egemone generando sfruttamento e diseguaglianze. Senza un mutamento in tal senso, che può avvenire solo col tempo, a un unico soggetto egemonico se ne sostituirebbero una pluralità di minori. Tuttavia, l’avvio di un meccanismo multipolare è un primo – necessario – passo per l’affrancamento dei popoli dalla pretesa egemonica americana.
4): La dinamica in atto è un apparente paradosso: gli Stati Uniti hanno affermato il proprio potere attraverso i meccanismi della globalizzazione; oggi, per difendere la propria egemonia dal sorgere di altre realtà, spezzano quelle vie con sanzioni, guerre commerciali e il potere della finanza, suscitando le resistenze di chi ha usato quegli stessi meccanismi – introdotti dagli USA – per emergere.
Tuttavia, in un mondo di fatto orientato al multipolarismo, quantomeno economico e commerciale, le sanzioni e le guerre finanziarie scatenate da Washington, agli occhi delle nazioni che si stanno affermando nel mondo, stanno rendendo sempre più conveniente, e in prospettiva sicuro, l’apertura di canali economici e finanziari alternativi e indipendenti dagli Stati Uniti, con ciò accelerando la de-dollarizzazione dell’economia mondiale che è già in atto (negli ultimi vent’anni le riserve globali espresse in dollari sono passate da ben oltre il 70% al 57%, una tendenza in rapida e crescente accelerazione negli ultimi tempi) con ciò minando la principale arma di pressione dell’Egemone.
Per quanto attiene il Continente europeo, le principali conseguenze della crisi ucraina sono al momento tre:
1) Come già accennato, gli USA hanno ripreso il controllo sul Continente (anche se, col dilungarsi della guerra e la crisi economica conseguente, l’Europa ora rischia di sfarinarsi fra le loro mani).
2) La Germania è con le spalle al muro: troncati i rapporti con la Russia (energia a basso costo), messi in dubbio i rapporti con la Cina (suo massimo mercato), isolata in Europa (con l’affermarsi a Est della Nuova Europa – Polonia in testa – quale pilastro degli USA e le divergenze con la Francia).
3) Frantumazione complessiva della UE (succube degli USA fino all’autolesionismo e inadeguata ai tempi nella sua visione economicista), destinata alla crisi economica, sociale e politica all’interno dei suoi membri, alla totale irrilevanza all’esterno.
Il costo spropositato dell’energia (per gli acquisti di materie prime energetiche effettuati a qualsiasi prezzo nel resto del mondo), e le conseguenze delle fratture commerciali imposte da Washington (e avallate ciecamente da Bruxelles), stanno spingendo le strutture produttive europee fuori dal mercato globale, ponendo le premesse per una rapida de-industrializzazione del Continente, in primis delle due maggiori potenze manifatturiere: Germania e Italia.
Per quanto attiene al resto del mondo, le conseguenze della “Guerra Grande”:
1) Stanno mettendo in discussione rapporti commerciali e “supply chain” create nei decenni (già provate dalle conseguenze della pandemia) determinando le condizioni di una durevole crisi economica.
2) Impediscono il riequilibrio dei mercati energetici, con pesanti conseguenze economiche e il rallentamento (più realisticamente, il fermo) dei tentativi di conversione “green”, velleitari in un simile contesto.
3) Infrangono equilibri esistenti e rimescolano intese fra stati, acuendo le tensioni in tutti i punti di crisi; ciò determina un generale aumento dell’instabilità e un prossimo proliferare di conflitti.
4) Le conseguenze della “Guerra Grande” impatteranno sulle entità statali più fragili del Sud del mondo, ciò potrà determinare due ordini di conseguenze:
– l’esacerbarsi di criticità endemiche in vari stati, in particolare in Africa, potrà portare a migrazioni di portata imprevedibile e alla totale destabilizzazione di entità statali assai fragili, con conseguenze politico-economiche di vasto respiro;
– la crescita di un sentimento di ostilità verso l’Occidente, visto come causa della crisi e accaparratore di risorse, cui corrisponde una percezione positiva di paesi come Russia e Cina, disponibili a fornire energia a costi accessibili e collaborazione economica.
Esempio paradigmatico di questa crescente insofferenza è stata la dichiarazione di Subrahmanyam Jaishankar, Ministro degli Esteri indiano, durante un forum tenutosi in Slovacchia nel giugno 2022; irritato dalla pretesa di acritica adesione alle posizioni “politicamente corrette” espresse da una supposta “civiltà superiore” occidentale in merito alla crisi ucraina, ha bruscamente sostenuto che “l’Europa deve abbandonare la prospettiva mentale secondo la quale i problemi europei sono i problemi del mondo, mentre i problemi del mondo non sono i problemi europei (con ciò riferendosi all’Occidente a guida USA)”. Una convinzione – quella del Ministro indiano – assai diffusa negli establishment del Sud del globo.
Le dinamiche della “Guerra Grande” nel MENA e Mediterraneo-Medioceano
Le conseguenze della “Guerra Grande” hanno accelerato alcune tendenze preesistenti e ormai consolidate; il deflagrare della crisi ucraina ha semmai influenzato, molto, postura e azioni degli attori dell’area, anche dei principali. Una tendenza di fondo rimane il già ricordato disimpegno americano da questo teatro per focalizzarsi altrove; il progressivo vuoto (necessariamente) lasciato ha spinto altri a riempirlo, provocando un forte rimescolamento di posizioni.
È altresì necessario ribadire ancora che chi osserva le vicende del quadrante in maniera isolata, non considerandole in un insieme, manca di cogliere la dinamica primaria dell’area: lo scontro fra l’Asse della Resistenza e ciò che con un neologismo ho definito Fronte dell’oppressione, ovvero fra forze rivoluzionarie e i regimi che intendono mantenere l’assoggettamento della regione a beneficio proprio e di Stati Uniti e Israele, avendo il loro determinante appoggio.
Ciò detto, i principali aspetti o, più precisamente, prospettive che si rilevano nell’area sono quattro: ascesa della Turchia, sfarinamento interno di Israele, torsione della politica estera saudita, affermazione dell’Iran, meglio, dell’Asse della Resistenza, al netto di sovversioni e attacchi condotti per frenarlo dai suoi avversari.
a) Il primo aspetto che rileva è la crescita dell’influenza turca; facendo perno sul controllo dell’accesso al Mar Nero (vitale per Mosca) e sul tradizionale ruolo di contenimento della Russia in ambito NATO, Ankara ha operato con spregiudicata ambiguità per realizzare i propri interessi, sfruttando al massimo le opportunità conseguenti agli sconvolgimenti della crisi ucraina:
– in Libia, radicandosi nella Tripolitania, allargandosi nell’Africa sub-sahariana e proiettandosi verso il Corno d’Africa dove, in Somalia, la Turchia ha la maggiore propria base all’estero;
– nel Mediterraneo Orientale (assai ricco di crescenti potenzialità gasiere);
– nel Caucaso (attraverso la crisi del Nagorno-Karabakh, la soggezione dell’Armenia – storicamente avversa – e gli stretti legami intessuti con l’Azerbaijan, aprendosi, tramite quest’ultimo, all’afflusso di idrocarburi e gas dall’Asia Centrale);
– nel Siraq, con le mire sulle aree curde, finalizzate sia in chiave di politica interna che estera; tuttavia, una dinamica condizionata dalla presenza di altri attori “pesanti”. Non mi riferisco alla presenza USA (che hanno già “venduto” più volte i curdi) né della Russia (che con la Turchia ha aperti altri dossier più rilevanti), ma alla proiezione dell’Asse della Resistenza (sistematicamente trascurata dal mainstream mediatico ma estremamente incisiva nell’area);
– operando un riavvicinamento a Israele (in cerca di nuovi appoggi, stante la sua situazione di crisi interna e la minaccia percepita dall’esterno).
Tali assi di sviluppo, che si proiettano anche nei Balcani (area che esula da questa analisi ma che meriterebbe un esame approfondito per la sua rilevanza nell’estero-vicino dell’Italia), ricalcano le tradizionali vie di espansione dell’antico Impero Ottomano che Erdogan, ripudiando la tradizione kemalista, sogna di ricalcare in una riedizione imperiale. Con una sostanziale variante: la “Mavi Vatan”, la “Patria Blu”, la dottrina di espansione marittima turca nel Mediterraneo, meglio, nel Medioceano, concepita da Cem Gurdeniz. Una dottrina che Ankara sta applicando e che i paesi europei rivieraschi (Italia in primis) mostrano colpevolmente di non voler comprendere.
Tuttavia, a mio parere, questa espansione è assai più dovuta a distrazione o debolezza altrui (in Libia, nel Mediterraneo e nel Caucaso) che a forza propria ed è minata dalla mancanza di risorse (a causa di un’economia quantomeno vulnerabile), negli ultimi anni fornite dal Qatar e promesse da chi intende affiancarsi alla sua influenza o indirizzarla (Emirati, Russia, etc.).
La fase espansiva potrà durare fino a quando:
– le diverse priorità degli altri attori della “Guerra Grande” le lasceranno spazio;
– la sua economia reggerà;
– supererà le turbolenze interne che nasceranno dalle elezioni presidenziali (giugno 2023), difficile referendum per Erdogan (e per inciso, paesi come Russia e Iran considerano il Presidente turco un cinico inaffidabile, ma lo preferiscono al prodotto di una “Rivoluzione colorata” etero diretta, che installerebbe ad Ankara una marionetta di Washington; per questo propendono per lui).
b) Continua lo sfarinamento della società israeliana; il quadro presenta due aspetti speculari, confermati dalle ultime elezioni e dai crescenti disordini interni:
– la società israeliana è spaccata e avviata a una deriva estremista e razzista;
– il compattamento del fronte palestinese nella Resistenza.
Le dinamiche interne israeliane stanno provocando la crescente – e inedita – convergenza degli arabi israeliani, pressati dall’apartheid cui sono sottoposti legalizzata dal Nation Act-Bill del 2018, verso il blocco palestinese.
Lo stesso stato maggiore di Tsahal si percepisce vulnerabile (e lo dichiara diffusamente alla stampa israeliana) per:
– la fragilità del fronte interno, sperimentata già nella crisi del maggio 2021 e ora accresciuta;
– l’incremento della coesione e forza della Resistenza Islamica – interna ed esterna – mai così unita e preparata a un confronto ibrido e asimmetrico sui territori della Palestina nella sua interezza (in cui Tsahal non può far valere i propri mezzi);
– il decrescente interesse dell’establishment americano alla regione e la sua crescente insofferenza per la deriva estremista israeliana;
– la generale progressione dell’Asse della Resistenza, malgrado contromisure d’ogni tipo.
Ciò induce Israele a fare apertamente blocco con i paesi del Golfo (come Arabia Saudita ed Emirati) e ad avvicinarsi alla Turchia.
c) Progressivo smarcamento saudita (e di altre monarchie del Golfo) dall’orbita nordamericana: lo spostamento degli interessi statunitensi a oriente (con il conseguente vuoto) e il trauma prodotto dal repentino abbandono dell’Afghanistan, sono stati percepiti dalla leadership saudita come evidente rottura dell’antica garanzia securitaria (in vigore dal 1945).
Per questo il cambiamento di posizione di Riyadh, manifestatosi in più circostanze su temi energetici, finanziari e di politica estera, ha cause assai più profonde dell’insofferenza fra l’Amministrazione americana e Mohammed bin Salman: è figlio della crisi del sistema di potere instaurato sulla regione fra USA e stati del Golfo; Riyadh non si sente più garantita da Washington e cerca altre sponde.
L’avvicinamento dell’Arabia Saudita (ma anche degli Emirati) alla Cina reca con sé altre conseguenze incisive: si tratta di economie esportatrici nette per volumi enormi e la prevista denominazione dei reciproci scambi in yuan comporterebbe un’ulteriore e consistente accelerazione del già rapido processo di de-dollarizzazione dell’economia globale, assicurato dal più che sicuro effetto domino di tale decisione.
d) Affermazione dell’Asse della Resistenza malgrado sovversioni, attacchi d’ogni tipo e le mistificazioni dei media; la campagna mediatica condotta da mesi per rappresentare l’Iran sull’orlo di un regime change sotto la spinta popolare è, come detto, una mistificazione che non deve fuorviare. L’ondata di disordini e atti terroristici si è scatenata dopo che Teheran:
– si è rifiutata di cedere al ricatto degli USA e rinegoziare dalle fondamenta il JCPOA senza garanzie né che le sanzioni primarie e secondarie sarebbero state sollevate dagli Stati Uniti, né che essi si sarebbero ritirati nuovamente dall’accordo una volta che l’Iran si fosse uniformato alle clausole dell’intesa (come già avvenuto);
– ha intensificato la collaborazione con Mosca (in campo economico e militare);
– ha stretto i rapporti con Pechino (in campo politico ed economico).
Quello in atto – e fallito checché ne dicano i media – in pratica è un ennesimo tentativo di “rivoluzione colorata” indotta dall’esterno per sovvertire dall’interno un paese che non è disposto ad assoggettarsi. Tentativi più volte sperimentati – e falliti – come nel caso della “Rivoluzione Verde” del 2009, stavolta associati all’azione di terroristi “importati” dall’Afghanistan e dalla Regione Autonoma del Kurdistan iracheno per commettere omicidi e stragi in una sorta di “strategia della tensione”.
La carta dei disordini per destabilizzare i paesi dell’Asse della Resistenza è stata recentemente giocata – senza successo – anche in Iraq (per provare a impedire la formazione del governo) e tentata (inutilmente) in Siria e Libano, con un tempismo assai più che sospetto, che si spiega ampiamente come un tentativo di frenare la progressione dell’Asse nella regione.
Nei fatti, la politica della “massima pressione” sull’Iran, per distruggere la sua economia, è stata un fallimento riconosciuto da Washington (che l’ha varata), mentre la proiezione dell’Asse della Resistenza sul quadrante è in crescita, facendo sentire la sua pressione anche ad Israele (e non è un caso se l’ondata di tentate sovversioni si siano registrate proprio a questo punto).
D’altronde, se l’Iran fosse fragile come dipinto, i suoi avversari nella regione – israeliani e sauditi in primis – non avrebbero motivazioni di inedite torsioni nelle alleanze, né blandirebbero l’Iran (vedi Emirati e la stessa Arabia).
Le conseguenze della “Guerra Grande” in Medio Oriente finiranno per semplificare il quadro:
a) offrendo all’Asse della Resistenza solide sponde per la convergenza di interessi con grandi attori nel contenere l’Egemone americano;
1.b) facendo emergere l’intero “Fronte dell’oppressione” che, per la minaccia alla sua sopravvivenza, si stringerà per contrapporsi all’Asse.
In questo scenario, non interpretabile col metro economicista ma valoriale ed esistenziale, è assai probabile che il livello del conflitto, che – ribadiamo – è unico, crescerà giungendo ad investire direttamente Israele, nel momento della sua massima debolezza interna. Dall’osservazione degli eventi, e dalla progressione delle dinamiche, mi sento di avanzare una previsione: se nella regione non dovesse scoppiare un evento realmente grande e traumatico, tale da costringere su di esso l’attenzione (e il Fronte dell’oppressione sta puntando a questo in ogni modo), la prossima deflagrazione avverrà in Palestina perché i tempi s’avvicinano ormai a maturazione.
E l’Italia?
L’Italia non è messa bene; per pochezza, impreparazione e sudditanza della sua classe dirigente, da oltre trent’anni (dalla fine dell’URSS e l’ingresso nella II Repubblica):
– non ha sovranità politica (e mostra di non volerla, come più volte dimostrato anche dal presente Governo) né economica (le dichiarazioni in tal senso, nei confronti di Bruxelles, sono deludenti, improvvisate e velleitarie);
– non ha definito i suoi interessi nazionali (e non se ne cura);
– non ha neanche una politica estera (appaltata ad aziende come ENI, Leonardo o Fincantieri, esatto contrario di una nazione normale che fa strumento dei suoi “campioni” nazionali);
– non ha un ruolo né un’idea di sé, si limita ad andare a rimorchio nel peggiore dei modi, finendo per gettare bombe sui propri interessi favorendo gli interessi altrui (come accaduto in Serbia e Libia), incapace di muoversi per i propri (come ha dimostrato ignorando le suppliche del governo da lei insediato a Tripoli che, disperato, si è consegnato alla Turchia, oppure quando ha lasciato che la Marina turca scacciasse l’ENI da un’area di prospezione nelle acque di Cipro su cui la mayor italiana aveva pieno diritto);
– è incapace di scelte strategiche, temi forti come l’energia o grandi nodi economici e infrastrutturali sono affrontati (meglio, accantonati) con superficialità e spirito di bottega;
– si muove solo sulla scia di diktat che vengono dall’estero (Washington o Bruxelles a secondo dei temi), il famigerato “vincolo esterno” invocato dall’establishment nostrano per motivare ogni scelta.
Ripiegata su se stessa, senza una bussola propria, l’Italia si ritrae; penisola immersa in un mare cruciale lo rifiuta, lo considera fonte di pericoli e non di opportunità (che altri colgono); spera che l’Egemone (a cui non si stanca di mostrarsi servile) o l’ONU risolvano i suoi problemi (fantasia prima che irrealismo).
È realistico, invece, aspettarsi una crisi economica e poi politica di inusuale portata perché i rimedi che si pretende di usare sono tarati (semmai lo sono) per un mondo che non c’è più.
Nel mondo della “Guerra Grande” non è permesso astenersi, tenere la testa sotto la sabbia e sperare; occorre scegliere secondo schemi inusuali. Impresa inedita per l’establishment italiano, da decenni impegnato ad autoperpetuarsi, a lasciare tutto com’è o fingere di cambiarlo.
Una strategia possibile per l’Italia
L’attuale struttura produttiva italiana gravita verso la Germania, ciò comporta conseguenze:
– la dipendenza da un altro paese che ha interessi e visioni diverse (e in questo momento di crisi lo sta dimostrando), in pratica l’Italia è sua “contoterzista” con tutto ciò che ne consegue (stupefacente come ciò sia totalmente trascurato da chi si sostiene “sovranista”);
– la spaccatura – permanente e, nei fatti, crescente – del Sistema Italia, che dalla dorsale gotica è legato alla catena del valore tedesca dedicando a essa la parte migliore di risorse ed energie produttive del paese, lasciando il resto ad annaspare.
Ritengo si debba riorientare questa stortura manifesta, naturalmente con gradualità, cogliendo le opportunità offerte dalla nostra posizione nel “Medioceano” e facendo tesoro della lezione di Mattei, vedi caso affossata dagli spessi epigoni dell’Egemone, successivi strenui sostenitori del liberismo.
È un tema che meriterebbe un vasto approfondimento, qui mi limito ad andare per capi, azzardando delle ipotesi per procedere su questa via:
– attenzionare la questione della Zona Economica Esclusiva delle nostre acque rivierasche: abbiamo permesso all’Algeria di spingere la sua fino a ridosso della Sardegna e alla Turchia di chiudere del tutto il Mediterraneo Orientale e di sospingerci nei pressi delle nostre coste. Unico accordo abbozzato è con la Grecia, perché era essa a premere per salvaguardarsi dalla proiezione turca in Albania;
– incentivare la rete portuale:
a nord, incentrata su Trieste e Genova, come vie d’accesso al Continente (sviluppando le infrastrutture viarie e logistiche soprattutto nell’area ligure, dove sono ancora deficitarie); un’ovvietà confermata dall’estremo interesse di cinesi e tedeschi per quei porti (in primis Trieste, porta della Mitteleuropa);
a sud, con porti di scambio del flusso di merci che attraversano il Mediterraneo, attorno a cui costituire aree di libero scambio per impiantare iniziative manifatturiere e di trasformazione, sul modello di quella di Trieste;
– costituire, o meglio, potenziare una rete infrastrutturale che faccia dell’Italia un “hub” per l’accesso di gas in Europa: è vero che oggi è di moda pensare solo al gas liquefatto, ma nel complesso sconta maggiori costi e, in ogni caso, necessita di approdi e di tubi per essere reindirizzato. Tolta (ciecamente) la Russia, il gas nei tubi può venire solo da sud o sud-est e l’Italia è il suo approdo naturale;
– la rete di collegamento Internet che collega il mondo passa a ridosso delle coste siciliane e in più punti vi approda: incentivare centri e servizi di comunicazione – attività altamente strategica – nel cui campo l’Italia conta alcune eccellenze (a cominciare da Sparkle, settimo operatore mondiale del suo settore e secondo europeo);
– intraprendere una seria politica di cooperazione bilaterale con i paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo e, più giù, lungo il bacino del Medioceano: sarebbe tornare alla logica di Mattei, per uno sviluppo reciproco di sistemi paese, nell’ottica dei rispettivi interessi nazionali (definiti e non affogati nell’inconcludente “politically correct” di Bruxelles);
– tale cooperazione, e tale proiezione sul mare, darebbe all’Italia “leve” per negoziare, con i paesi rivieraschi e quelli dietro, il governo dei movimenti migratori (che, verosimilmente, sono destinati ad aumentare considerevolmente).
Si potrebbe continuare a lungo perché le opportunità sono molteplici (e vaste) ma, prima d’ogni cosa, sarebbe necessario definire indirizzi e interessi nazionali (finora non tracciati). E imparare a tutelarli. In ogni caso, essi non si trovavano in Afghanistan e non si trovano in Iraq.