Tutto il resto è noia
di Marcello Veneziani - 28/09/2025
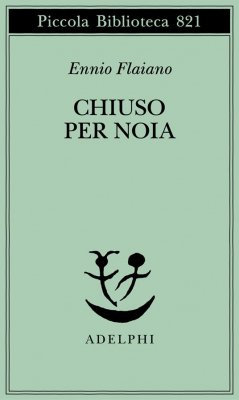
Fonte: Marcello Veneziani
Ennio Flaiano non amava Totò. Lo trattava con evidente fastidio, storpiando addirittura il suo cognome, chiamandolo Antonio De Cupis, anziché de Curtis. Giudicava le sue battute sciocche, troppo facili, lo paragonava a Pulcinella, con una comicità “cristallizzata, addirittura arida”, vittima di se stesso. Totò rimaneva per lui un macchiettista, incapace di essere attore; un narcisista con la pretesa di trasferire nel cinema “il bagaglio superfluo del palcoscenico”. Infine il verdetto: Totò annoia. Era il 1939, il giudizio era prematuro. Infatti col tempo muterà; la svolta sarà con Napoli milionaria di Eduardo de Filippo che secondo Flaiano riscatterà Totò dopo una serie di brutti film. Ma la piena riabilitazione avverrà solo alla morte del comico, nel 1967, partendo da un’esperienza personale. “Conobbi Totò e, nei limiti delle nostre due timidezze, diventammo quasi amici”. Allora Totò apparve a Flaiano “un signore”, meridionale, calmo, tollerante, cortese, che si levava il cappello per salutare, sorridente, con un tratto d’ironia indefinibile. Flaiano, ormai soggettista e sceneggiatore famoso, aveva scritto per lui alcune battute e in brevissimo tempo Totò era in grado di farle sue nel migliore dei modi. Flaiano lo definisce metafisico, “una pura astrazione comica” e si definisce a sua volta “ammiratore fervente” non dei suoi film, che comunque a suo dire resteranno, ma di quel che non sarebbe rimasto di lui, perché affidato alla labile memoria del palcoscenico.
Erano trascorsi nel mezzo trent’anni tra i due giudizi, Flaiano e Totò erano molto “cresciuti” e avevano espresso in quegli anni il meglio del loro talento. Ma come si poteva definire noioso Totò? Era l’aggettivo meno appropriato ai suoi film. La noia, in realtà, era negli occhi disincantati di chi l’osservava, nello sguardo tediato di Ennio Flaiano.
La noia è una chiave di lettura che Flaiano usa spesso per giudicare vite, opere e film, perché in realtà la noia lo accompagnò come un’ombra molesta nella sua vita. “Chiuso per noia” è stata giustamente intitolata la raccolta di scritti e recensioni di film edita in questi giorni da Adelphi a cura di Anna Longoni. Quante volte fa capolino la noia nei suoi scritti pur dedicati a un’arte come il cinema, nato soprattutto per ammazzare la noia, o per sospenderla e distrarsi. Flaiano in queste pagine rimpiange la gioventù come il tempo in cui non si annoiava; ammette di andare al cinema “per fare tardi” o per compiacere qualche amico. Trova noioso il cinema italiano in tempo di guerra, e anche dopo, nell’elegia del passato ritrova traccia della noia del presente, che non ha più illusioni e non riesce a crearne di nuove. Eppure, dice, il pubblico chiede al cinema di “essere aiutato a uccidere la noia, questo mostro quotidiano che i filosofi e i cani non conoscono ma che affligge tutti gli altri esseri viventi”. Che i filosofi non conoscano la noia è una generosa esenzione di Flaiano; Schopenhauer certo conosceva la noia, al punto di pensare che la vita è un pendolo che oscilla tra la noia e il dolore. E dei cani poi che ne sapeva? Io ne ho visti alcuni, e li ho sentiti guaire, e il loro sguardo quanto il loro lamento sapeva di noia e sbadiglio. Ma in un altro scritto qui incluso Flaiano riscatta la noia e la definisce “il più elegante dei sentimenti”. La noia avanza con l’età, col benessere, con la vita al riparo da ogni incertezza e da ogni pericolo, sicura e ripetitiva, priva di aspettative, vuota. Flaiano ne fu afflitto, pur navigando in ambiti tutt’altro che noiosi, come la letteratura, il giornalismo, il cinema, la compagnia di artisti e scrittori vivaci. Ma colse i risvolti noiosi della dolce vita romana, le serate infinite e vacue nei salotti e ai tavoli dei caffè e delle trattorie. La noia era per lui il risvolto umorale dell’esistenzialismo, che passando dalla filosofia alla vita s’incupiva di spleen, indossando “dolcevita” neri; la noia e il niente.
Eppure Flaiano non visse a lungo, morì a sessantadue anni, non visse cioè gli anni lunghi della vecchiaia, non fece in tempo a provare la noia proverbiale del pensionato. Visse la noia dell’uomo di mezz’età, come avrebbe detto un suo affine, Marcello Marchesi. Di noia, in quel tempo, scriveva anche Alberto Moravia, che a lei dedicò sin dal titolo un romanzo famoso, nel 1960; riprendeva il malessere esistenziale di trent’anni prima, quando da ragazzo aveva scritto Gli Indifferenti. A dimostrazione che la noia attraversava epoche e regimi, dal fascismo agli anni del miracolo economico e della Romanità fascio-epica alla Roma godereccia e vitazzuola. Anche per Moravia lo sfondo della noia era Roma, ma la sua noia attaccava i giovani, e nell’autobiografia dell’autore la noia risaliva anzi alla sua infanzia cagionevole.
Tempo di uccidere fu il titolo che Flaiano dette al romanzo che gli pubblicò Leo Longanesi e vinse la prima edizione del premio Strega. La noia fu per lui il tempo che uccide, che corrode la vita giorno dopo giorno e ruba ogni impeto di vitalità e di allegria. Malattia benestante, piuttosto senile, ai suoi occhi cerchiati di nero dalla montatura dei suoi occhiali “malinconici”, per dirla con Ceronetti.
Le pagine di Flaiano navigano tra il neorealismo del cinema italiano e alcuni capolavori del cinema americano e francese; tra Visconti, Rossellini e De Sica (meno citato il suo sodale Fellini) e Renoir, Ford e Charlot, “la sola invenzione letteraria” del primo mezzo secolo di vita del cinema. Tutto il resto è noia. Al cinema come nella vita.

