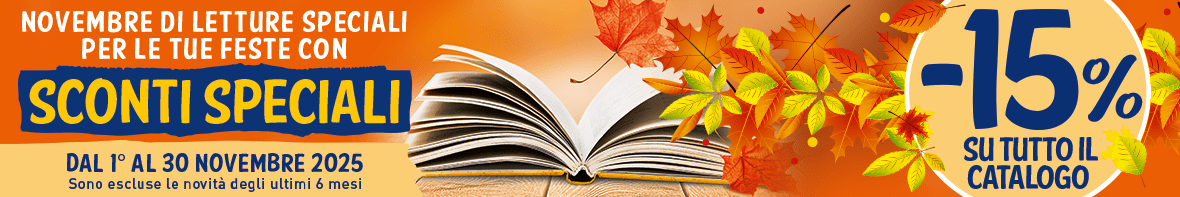Tareq Aziz espia lo scontro di civiltà
di Roberto Zavaglia - 30/10/2010

La condanna a morte di Tareq Aziz significa, prima di ogni altra cosa, che l’Iraq, a oltre sette anni dall’invasione statunitense, è ancora immerso in un clima di odio e di vendetta. Il parziale ritiro delle truppe di occupazione non è affatto la dimostrazione che la guerra, soprattutto la guerra civile, sia finita. I piccoli segnali di normalità che gli Usa, i responsabili della tragedia irachena, si sforzano di enfatizzare non possono nascondere come, allo stato attuale, la pacificazione e la ricostruzione siano mete ancora lontane.
Sono passati quasi otto mesi dalle elezioni, ma a Baghdad ancora non c’è un governo. Sembra però si vada verso la formazione di un “monocolore sciita”, con l’alleanza tra il primo ministro uscente al-Maliki e il radicale al Sadr, contrariamente alle indicazioni delle urne che avevano assegnato la maggioranza relativa alla lista “trasversale” di Allawi. Se così fosse, per la minoranza sunnita e anche per quel che rimane dei cristiani le cose potrebbero perfino peggiorare. La forca a Baghdad lavora a pieno regime e non c’è da stupirsi che presto ne possa fare le spese anche colui che fu uno dei principali collaboratori di Saddam. Dipinto dalla stampa internazionale come il “volto umano” del regime, Aziz fu, innanzitutto, un abile diplomatico che, fino all’ultimo, tentò di scongiurare l’attacco statunitense.
In Occidente suscitava sorpresa che il ministro degli Esteri di un regime giudicato una “dittatura sunnita” fosse un cristiano, cattolico caldeo per la precisione. Uno stupore immotivato perché il Baath era un partito laico che della polemica contro i regimi arabi fondati sul “conservatorismo religioso”, additato come lo strumento per perpetuare il potere delle vecchie classi dominanti, faceva il suo cavallo di battaglia. Del resto, il Baath siriano che, inizialmente, ispirò il “partito fratello” iracheno, venne fondato dal cristiano Michel Afleq. E’ comprensibile che, in un Paese a grande maggioranza islamica, il giovane Aziz, come molti altri suoi correligionari, aderisse e poi percorresse il cursus honorum in un partito che predicava il socialismo nazionale e il panarabismo al di là di tutte le differenze confessionali. Sebbene i sunniti, di fatto, fossero in maggioranza nella classe dirigente, sotto Saddam i cristiani, al contrario di oggi, non se la passavano male, godendo di piena libertà di culto, senza che nessuno si permettesse di minacciarli a causa della loro fede.
Aziz è stato condannato alla pena capitale per avere genericamente partecipato alla “persecuzione dei partiti religiosi”. Probabilmente, si tratta dei fatti che seguirono al fallito attentato del 1980 contro lo stesso ministro degli Esteri, ad opera, sembra, di un agente iraniano. Il regime reagì condannando a morte molti militanti del partito sciita Dawa, al quale apparteneva anche al –Maliki, e facendo impiccare l’ayatollah Mohammed Baqer Sadr, zio di al-Sadr. Oggi sembra arrivato il momento della vendetta, sotto il velo trasparente di un formale processo. E’ difficile indicare l’entità delle persecuzioni politiche ordinate da Saddam, essendo materia di contesa fra la propaganda dei nostalgici del regime e quella dei suoi nemici. Ancora più arduo è stabilire le concrete responsabilità di Aziz che, secondo alcuni esponenti della diplomazia internazionale, sarebbero pressoché nulle.
In ogni caso, il nuovo regime iracheno, continuando a epurare sanguinosamente i vinti, dimostra di non credere alle parole di riconciliazione nazionale che pronuncia nei discorsi ufficiali. Anche perché i tribunali non concedono alcuna garanzia agli imputati. “E’ stato un processo fasullo, con un giudice fasullo”, ha dichiarato Giovanni di Stefano, uno degli avvocati di Aziz: “Il tribunale non mi ha permesso di fare neppure una domanda ai testimoni”. I vescovi cristiani in Iraq hanno protestato per la condanna a morte nella quale, probabilmente, vedono l’indizio di un ulteriore accanimento contro la propria comunità. Che la situazione dei cristiani sia sempre più difficile l’ha scritto, qualche giorno fa su “The Indipendent”, anche Robert Fisk, un giornalista di grande valore, con un’enorme esperienza delle vicende mediorientali: uno che bisogna ascoltare sempre attentamente, anche quando occasionalmente non si è d’accordo, per la sua qualità morale di testimone super partes e per il suo coraggio, dimostrati in decenni di attività.
Scrive Fisk che “quasi la metà dei cristiani iracheni sono fuggiti dal loro Paese, dopo la Prima guerra del Golfo del 1991 e, soprattutto, dopo l’invasione del 2004 ( strano omaggio alle sedicente fede cristiana dei due presidenti Bush che scatenarono le guerre contro l’Iraq)”. La progressiva scomparsa delle comunità cristiane riguarda comunque tutto il Medio Oriente: “Più della metà dei cristiani libanesi vive fuori dal loro Paese: un tempo maggioranza, il milione e mezzo di cristiani, in gran parte maroniti, costituisce oggi forse il 35% dei libanesi”. La drastica riduzione del numero dei cristiani, aggiunge il giornalista inglese, riguarda anche altri Paesi, come l’Egitto, dove forte era il loro radicamento. Questa è la situazione alla fine (?) dell’epoca delle guerre umanitarie che, nel delirante progetto dei neocon Usa, avrebbero dovuto “rifare il Medio Oriente”, portando democrazia e diritti umani per tutte le minoranze.
E’ ovvio che i problemi per i cristiani della regione non dipendono solo dalle spedizioni militari di Washington, ma certamente ne sono stati acuiti. In un oceano musulmano, essi vengono sempre più identificati come i rappresentanti di un Occidente aggressivo e anti-islamico, anche in quei Paesi dove non solo erano tollerati ma, da secoli, godevano di piena cittadinanza. Il recente sinodo del Medio Oriente ha messo in luce questo pericolo, oltre a sottolineare come l’eterna questione palestinese contribuisca a peggiorare i rapporti fra le varie comunità religiose. Il governo israeliano ha reagito con rabbia alle prese di posizione espresse, in quella sede, dai vescovi che vivono nella regione, arrivando a minacciare ripercussioni nei rapporti tra lo Stato ebraico e il Vaticano.
Il vice ministro degli Esteri, Danny Ayalon, ha dichiarato che “i governi israeliani non si sono mai serviti della Bibbia”, in risposta alle affermazioni del Sinodo in cui si sosteneva che non è lecito giustificare le ingiustizie e l’occupazione di terre altrui sulla base di posizioni teologiche e di letture bibliche. Forse nei documenti ufficiali gli israeliani sono più prudenti, ma i politici al governo che difendono i coloni in Cisgiordania non hanno timore di riferirsi alla Terra Promessa. In quanto poi alla pretesa che Israele non faccia discendere la sua legittimità dai testi sacri, per demolirla basta pensare alla nuova legge sulla cittadinanza. Quella per la quale i cittadini dovranno giurare lealtà allo Stato di Israele “in quanto Stato ebraico e democratico”. Una norma davvero laica e, soprattutto, democratica…