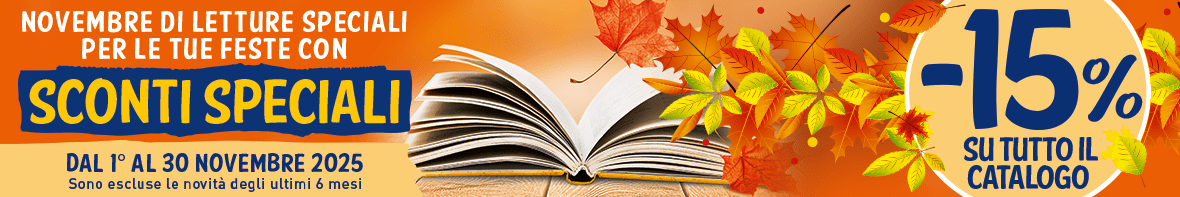In collina, le città
di Gianluca Freda - 13/12/2011
|
"Lo Stato, in quanto tale, è macchina: è un’opera approntata dagli uomini, nella quale materia e artefice, materia e artifex, macchina e costruttore, sono la stessa cosa, sono cioè uomini.” (Carl Schmitt, Scritti su Thomas Hobbes)
Per chiunque lo abbia letto, ormai quasi trent’anni fa, il racconto di Clive Barker “In the hills, the cities” (In collina, le città), contenuto in “Infernalia”, il primo volume dei “Books of Blood”, è difficile da dimenticare. Sarebbe potuto diventare un assoluto capolavoro dell’horror politico anglosassone, considerata la genialità dell’idea che ne sta alla base e il periodo, assai significativo, in cui è stato scritto: la prima metà degli anni ’80, quando in Inghilterra si era già messa in moto, con effetti dirompenti, la macchina del liberismo folle di Margaret Thatcher, foriera dei disastri che il mondo intero ha potuto poi degustare nel corso dei decenni. “Infernalia” venne pubblicato in Inghilterra nel 1984, anno significativo non solo perché “orwelliano”, ma anche perché fu il penultimo della vita di Carl Schmitt, il teorico dello stato nazionalsocialista tedesco al cui pensiero politico “In the hills, the cities” sembra liberamente ispirato.
Se l’occasione del capolavoro è stata – a mio avviso - mancata, lo si deve a motivazioni di carattere puramente stilistico. Letterariamente, Barker non è certo un virtuoso dello stile. La sua narrazione indulge in modo eccessivo sui cliché espressivi dell’horror (i fiumi di sangue, la moltitudine di cadaveri straziati, gli improvvisi cazzotti allo stomaco del lettore, perfino l’antico “topos” cinematografico della contadina mitteleuropea sinistra ma ospitale), riuscendo quasi a sprecare (quasi) ciò che di veramente agghiacciante è presente nel racconto, comunque indimenticabile. E cioè il terribile vaticinio - “terribile” per l’immaginario politico delle masse odierne, che tale lo reputano - sull’imminente decomposizione della chimera individualista, perno dell’ideologia democratica occidentale; e sulla resurrezione di dottrine sociali collettiviste che si credevano (e ancora si credono) scomparse dall’Europa “americanizzata” con l’eclissi della prima metà del Novecento.
Rovinerò, qui di seguito, il piacere della lettura a tutti coloro che non conoscono il racconto, riassumendone la trama.
Due giovani gay americani di San Francisco, in vacanza in Jugoslavia (che all’epoca non era ancora “ex”), si ritrovano involontari spettatori di una singolare quanto raccapricciante disfida che oppone tra loro, ogni dieci anni, due cittadine dell’entroterra, Popolac e Podujevo. Le loro popolazioni si ritrovano ogni due lustri sulle colline e qui costruiscono due smisurati giganti di forma umana, ciascuno dei quali è composto dai corpi di tutti gli abitanti di ciascuna città, intrecciati tra loro con cavi, funi e tiranti in un folle lavoro d’ingegneria. I due giganti, che riproducono un essere umano non solo nell’aspetto esteriore, ma anche in ogni dettaglio dell’anatomia (sistema nervoso, apparato digerente, ecc.), dovranno poi affrontarsi in leale combattimento. Qualcosa però va storto. Il gigante di Podujevo, a causa di un difetto di costruzione, collassa su se stesso prima che la lotta inizi. Nel crollo, l’intera popolazione di Podujevo rimane uccisa, straziata e mutilata. Ai due protagonisti, sopraggiunti per caso sul luogo della tragedia, si presenta l’infernale spettacolo di decine di migliaia di corpi umani, ancora agganciati tra loro, devastati e schiacciati, in un terrificante intrico di membra. L’altro gigante, quello di Popolac, fugge via, sopraffatto dall’orrore. La terribile esperienza lo trasforma in una creatura autonoma, dotata di pensiero indipendente rispetto alla moltitudine degli individui che lo compongono e che ne costituiscono le “cellule”. Nell’incontro finale col gigante sopravvissuto, uno dei due protagonisti resterà ucciso, l’altro si unirà gioiosamente alle “cellule” che compongono la leviatanica creatura.
Ovviamente non saprei dire se Barker, scrivendo il suo racconto, avesse in mente il Leviatano di Hobbes o la rielaborazione politica di Schmitt (o magari entrambe le cose o nessuna delle due). Fatto sta che l’anatomia dei due leviatani del racconto è squisitamente schmittiana, e non hobbesiana.
Come è noto, nel modello di Hobbes i cittadini sono le membra del corpo dello Stato, ma non partecipano della forza politica che lo anima. In Hobbes, la politica è qualcosa che sta al di fuori dell’individuo: nasce con la rinuncia dei cittadini alle loro prerogative e con la delega di esse ad un sovrano, che dovrà utilizzare i poteri conferitigli per il bene comune.
Nel modello di Schmitt, invece, la politica vive in interiore homine. Lo sviluppo dell’individuo avviene in perfetta simbiosi con quello della collettività ed è dalla “scintilla” dell’intelletto, scaturita in un dato momento nel corpo comune della moltitudine, che consegue spontaneamente la costituzione dello Stato. I poteri dello Stato e quelli della collettività sono la stessa cosa, appartengono ad un medesimo organismo, politicamente vivo in ogni sua parte.
Il modello di Hobbes venne elaborato per giustificare la dittatura di Cromwell, con la quale si doveva implementare il sistema giuridico liberale in grado di assicurare l’espansione della classe borghese mercantile.
All’opposto, il modello di Schmitt nasce dalla profonda crisi dello Stato liberale (incarnato dalla Repubblica di Weimar) e dalla volontà di restituire allo Stato la piena sovranità che esso ha finito per perdere a tutto vantaggio di una pluralità di centri di potere, competitivi ed in conflitto fra loro. E’ naturalmente il Partito Nazionalsocialista tedesco la componente cui Schmitt guarda per la realizzazione di questa unificazione dell’ordinamento, in virtù della quale la titolarità del politico torni ad appartenere solo ed esclusivamente allo Stato.
Il modello di Hobbes è conflittuale e pluralista, elaborato su misura per favorire lo sviluppo del dinamismo borghese: ciò che lo Stato hobbesiano garantisce è che tutti i cittadini abbiano uguale capacità di nuocersi a vicenda.
Il modello di Schmitt aborre la conflittualità. “Lo Stato serve proprio” - afferma Schmitt nei suoi Scritti su Thomas Hobbes - “a porre fine alla guerra civile; ciò che non pone fine alla guerra civile non è Stato”. Non è dunque tollerata alcuna forma di pluralismo d’interessi, competitività o confronto dialettico. L’unica guerra civile legittima è quella in cui sia lo Stato stesso a indicare il gruppo di individui che minaccia la sua esistenza. Se invece ogni singolo gruppo adotta una propria distinzione “amico-nemico”, allora lo Stato viene esautorato e cessa semplicemente di essere Stato.
Il modello di Hobbes attribuiva alla costituzione dello Stato una giustificazione di razionalità e una finalità di tipo prettamente sociale. Attraverso il “contratto”, i cittadini decidono, con scelta razionale, di rinunciare alle proprie prerogative, per conferirle ad un sovrano che utilizzi i poteri così acquisiti per porre fine al caos e alla violenza dello “stato di natura”.
In Schmitt non vi è nessuna giustificazione razionale, salvo quella di restituire allo Stato la sovranità usurpatagli dalla dialettica sociale. E la finalità dello Stato così reintegrato nel suo potere è totale: non ha la mera funzione di disciplinare il pluralismo esistente allo stato di natura, ma va ben oltre, attribuendo alla politica il compito di sovrintendere a tutte le questioni inerenti alla vita associata, all’etica, ai limiti morali e giuridici di ogni singolo individuo, alle relazioni sociali di tipo semplice e complesso, alla stessa forma giuridica di cui lo Stato dovrà rivestirsi. Lo Stato non ha dunque una genesi razionalistica, ma è l’espressione storica di un’esigenza filosofica umanistica che vive nell’individuo e nella comunità di cui egli partecipa. Delle tre “serie” schmittiane di cui si presenta composta l’unità della vita pubblica (Stato, Movimento, Popolo), è il Movimento (cioè il Partito come espressione del dinamismo collettivo) quella che conduce le altre due, non un “sovrano” esterno alla moltitudine.
Immagino sia dunque il timore di una reviviscenza del modello schmittiano/hitleriano, e non di quello hobbesiano, ciò che alligna nel racconto di Barker, alimentato dal clima della politica thatcheriana che iniziava a fare a pezzi, come una macchina devastatrice e inarrestabile, tutte le illusioni di dialettica sociale su cui l’Inghilterra e l’Europa si erano cullate nei precedenti decenni. Il timore era ampiamente giustificato, come si è poi visto dai risultati. La domanda che mi pongo è: lo è ancora? Il modello schmittiano-nazionalsocialista è qualcosa da temere o invece da auspicare nella presente situazione politica?
Personalmente ritengo sia da auspicare. E lo dico ben sapendo di quanti incubi il babau coi baffetti popoli ancor oggi i sonni dell’uomo della strada, con tutte le scorpacciate di propaganda antinazista impostegli a pranzo e a cena da chi versa il pastone nel suo trogolo. Prima che inizino i soliti berci contro il mio ennesimo articolo “rossobruno”, farcito di indecente apologia del nazismo, vorrei che si riflettesse sui seguenti punti:
1) Il nazismo e i suoi artefici sono morti e sepolti da una settantina d’anni. Non torneranno mai più, nemmeno ad evocarli col tavolino a tre gambe, perché è morta e sepolta anche la contingenza politico/strategica che li aveva generati. Ciò di cui si sta discutendo è della possibilità di restituire ad alcuni stati la sovranità che hanno completamente perduto, esattamente come la Germania aveva perso la sua con l’avvento dell’incubo di Weimar. A questa possibilità lo stesso Schmitt imparò, col tempo, a credere poco, delineando nei suoi ultimi scritti il quadro di una progressiva decomposizione dell’idea di Stato, sostituito dal potere della finanza e dal culto del tecnicismo. In ogni caso, tale riappropriazione della sovranità, quand’anche fosse possibile, non assumerebbe certo le fattezze di crucchi coi baffetti o le forme del passo dell’oca. La storia si ripete sempre, ma mai allo stesso modo;
2) Non esistono forme politiche che siano buone o cattive per definizione. Ogni modello politico è buono o cattivo in base alla sua capacità di confrontarsi con i problemi che lo scenario politico nazionale e internazionale di una data epoca porta con sé. Il nazionalsocialismo fu un modello di straordinaria efficacia per la Germania degli anni ’30, che le consentì di ritornare in pochi anni allo status di superpotenza dopo il disastro seguito alla sconfitta nel primo conflitto mondiale. In altri momenti storici e in altri luoghi, sarebbe ovviamente stato deleterio (e in effetti, lo fu). La democrazia, che per qualche decennio ha avuto in Europa un suo ruolo nel fornire i parametri organizzativi di base su cui innestare le prospettive di crescita e di benessere del corpo sociale, è oggi un rottame della storia, utile solo a giustificare guerre, massacri, assoggettamenti finanziari di intere aree geopolitiche alla prepotenza dell’ideologia statunitense. Un rottame pernicioso, di cui sbarazzarsi al più presto. La stessa paura per la resurrezione del Leviatano, che impregna di sé il racconto di Barker, era pienamente giustificata nei primi anni ’80, lo è molto meno oggi, in un panorama in cui ciò che devasta le nazioni è l’impazzare delle orde banditesche di mostriciattoli della politica degenerata, del sindacalismo venduto, dell’industria parassitaria e della finanza senza regole; non certo i colossi torreggianti, il cui corpo è pur sempre costituito dall’insieme dei cittadini e che potrebbero schiacciare, senza neppure vederle, queste bande rivali di scarafaggi in lotta tra loro per accaparrarsi un brandello di carogna;
3) Chi desiderasse gettare la croce addosso a Schmitt per la sua originaria adesione al nazionalsocialismo, farebbe bene a darsi prima un’occhiata approfondita allo specchio. La frase che sentiamo ripetere spesso sui tram e nelle osterie è quella che recita “Lo Stato siamo noi”, una vieta banalità nella quale, tuttavia, il cittadino medio (soprattutto quello “di sinistra”, che a chiacchiere proclama orgogliosamente il proprio “antifascismo”) tende a sintetizzare il senso della propria appartenenza ad una comunità politica. Ebbene, questa frase esprime un’idea di Stato squisitamente schmittiana. L’uomo comune sente “a pelle”, ed esplicita nei suoi aforismi, che l’esistenza di una collettività politica risponde a criteri schmittiani di partecipazione e condivisione di obiettivi, non ad una hobbesiana delega di poteri ad un saggio o ad un gruppo di saggi (ammesso e non concesso che poi i “saggi” siano effettivamente tali). Perchè mai, nell’istintiva consapevolezza di ciò, accetti poi chetamente di permettere alla “democrazia” di esautorarlo per delega da ogni potere partecipato, è un enigma che potrebbero svelarci soltanto lui, il padreterno e il meccanismo orwelliano del bipensiero; cioè quel gaudioso mistero mediatico che costringe la gente non solo e non tanto a pensare ciò che i mezzi di comunicazione gli ordinano di pensare, ma a convincersi che ciò che i media gli stanno ordinando di pensare corrisponda esattamente alla sua weltanschauung, anche se basterebbe mezzo minuto di riflessione razionale per rendersi conto che non è così.
4) La “democrazia” impostaci dagli Stati Uniti dopo la nostra vergognosa e disastrosa sconfitta nel 1945 non permette di configurare nessuna forma di Stato, né schmittiana, né hobbesiana, né di altro tipo. Non è schmittiana perché delega i poteri ad una rappresentanza; la quale, oltretutto, nei fatti non rappresenta un bel niente ed utilizza quei poteri per scopi esattamente antitetici a quelli per cui la delega le è stata conferita. Non è hobbesiana perché i poteri delegati non svolgono più neppure la loro funzione legittimante, che sarebbe quella di impedire la “guerra di tutti contro tutti”. All’opposto, la “democrazia” e i volgarissimi intellettuali che la propugnano alimentano l’individualismo più radicale, fino alla completa atomizzazione della società. Non soltanto i molteplici gruppi d’interesse, ma addirittura i singoli individui vengono incentivati ad adottare una condotta autonoma rispetto al resto del corpo sociale, perseguendo utilità strettamente individuali ed elaborando la propria microlista degli amici e dei nemici. La democrazia è stata progettata con lo scopo specifico di esasperare la conflittualità, fino a rendere ingestibile e caotica la vita aggregata, cioè la stessa nascita o la sopravvivenza di uno Stato.
5) Nei primi quarant’anni del dopoguerra, la forza disgregatrice della democrazia è stata temperata, in molti paesi europei, dal perdurare di poteri a carattere nazionale (grandi interessi industriali ed energetici, aziende di Stato, un certo modo di pensare la politica ancora legato alla gestione d’inizio Novecento), grazie anche all’esistenza di un bipolarismo geopolitico che non consentiva ad un unico centro di potere di garantirsi un predominio senza controllo. Dopo la caduta dell’URSS, il modello democratico si è rivelato nella sua intrinseca funzionalità come mero strumento di colonizzazione, che indebolisce e poi distrugge ogni pulsione nazionale per sostituirla con la completa disarticolazione di ogni finalità unificante. In questo, la democrazia è perfettamente rappresentata, nel racconto di Barker – a prescindere dalla volontà dell’autore – dal groviglio scomposto ed orrendo dei cadaveri dei cittadini di Podujevo dopo la caduta del gigante. Non più un Leviatano, ma un corpo morto, in cui ogni cellula inizia ad interagire con gli elementi chimici circostanti secondo criteri propri, senza più un centro direttivo o un’aspirazione comune. L’unico elemento che accomuna tra loro le membra del colosso frantumato è a questo punto lo sciamare su di esse degli insetti in cerca di carne putrefatta, cioè delle bande di politici, amministratori, sindacalisti e finanzieri corrotti che strisciano su ciò che resta delle vestigia umane del Leviatano per cibarsene in privato. Proprio come nel terribile finale del racconto di Barker, in cui il corpo di Judd si muove ancora, ma mosso soltanto dai nugoli di insetti che lo divorano dall’interno e dagli animali selvatici che lo dilaniano; genera ancora, ma solo le larve dei parassiti che nei suoi intestini depongono le uova. Mentre, allo stesso tempo, la vita propriamente detta si risveglia potente nel gigante di Popolac, le cui componenti umane accettano di agire in sincrono come cellule, di vivere come cellule, di morire come cellule di una costruzione più grande, con l’entusiastico apporto del protagonista sopravvissuto.
6) L’immaginario comune, opportunamente rinfocolato dai media, tende ormai a distinguere, con demenziale semplificazione, le forme di Stato in due grandi e rozze categorie: democrazia e dittatura. Non si ripeterà mai a sufficienza quanto questa visione delle cose sia sciocca e fuorviante. E non solo per il moralismo abietto da cui è sottesa, che vede sempre nella dittatura il “male” e nella democrazia il “bene”; ma anche perchè muove da una serie di presupposti ingannevoli – anch’essi inculcati nelle coscienze a suon di propaganda – che trasformano la realtà osservabile in una costruzione narrativa puerile, una favola della buonanotte raccontata a bambini in tenera età per evitare che rimangano svegli. Si immagina che esista un’entità chiamata “popolo”, della quale il cittadino senza potere si convince di essere parte per il semplice fatto di essere privo di potere, senza chiedersi se per caso la definizione di una categoria di tale ampiezza non necessiti di specifiche meno dozzinali; si fantastica che gli appartenenti a tale evanescente categoria possiedano le conoscenze, le competenze e le doti politiche per guidare al meglio una nazione; si teorizza infine che la “democrazia” sia l’habitat ideale in cui questo ircocervo può esplicitare le proprie elette prerogative, laddove la “dittatura”, al contrario, le reprime. Nè la realtà miserrima delle cose, in cui i senza potere sono tartassati in democrazia perfino più che altrove, è sufficiente ad allontanare questa chimera perniciosa. Personalmente, l’unica distinzione che mi interessa in questo momento non è quella tra democrazia e non democrazia, ma quella tra forme politiche (di qualunque tipo) che garantiscono sovranità alle proprie nazioni e forme politiche che, all’inverso, hanno il solo scopo di svendere tale sovranità a potentati stranieri. La democrazia di stampo americano è di questo secondo tipo ed è perciò da rigettare in toto. Non dico che lo sia sempre stata o che sempre debba esserlo; ma in questo momento lo è. E’ un’arma micidiale messa a punto dai think-tank di Washington e il suo scopo, come dovrebbe ormai essere evidente, è quello di indebolire le nazioni (frammentando la loro forza politica in una pletora di partitini che sgomitano per un seggio parlamentare), ricattarle (con il colpo in canna dei diritti umani) e infine ridurle in macerie con il pretesto che la loro “democrazia” non era sufficiente. Una sorta di strozzinaggio morale applicato alla strategia geopolitica.
Per questo motivo quello che negli anni ’80 era l’incubo di Barker, mi appare – così come al protagonista del racconto rimasto in vita - una via di fuga per il secondo decennio del ventunesimo secolo. Non una rivoluzione di “popolo”, ma un’avvicendarsi di elite dirigenti che porti a definitiva liquidazione il laissez faire, ridotto ormai ad una guerra tra bande in continua e caotica scissione, una mitosi senza fine che non consente un progetto comune, non lascia sussistere pietra su pietra. Mi interessa il sorgere di una forma della politica che restituisca una parvenza d’unità al corpo collettivo, abolisca la tolleranza verso la miriade di centri di potere in conflitto tra loro, ma tutti d’accordo nel togliere legittimità al potere dello Stato.
Schmitt sognava uno Stato che coincidesse con la società intera, un Leviatano che debellasse il Behemoth rappresentato da Weimar. Io mi accontenterei, a questo punto, di uno Stato che si identificasse con un’elite coesa negli obiettivi da perseguire, con o senza l’appoggio spontaneo che scaturisce dall’”illuminazione” con cui le masse si costituiscono in corpo comune. Una testa pensante che costruisca, poco alla volta, atomo dopo atomo, cellula dopo cellula, il corpo del gigante da portare a lottare sulla collina. Perché la lotta è forse luttuosa, ma senza il passaggio per quella mulattiera di dolore che porta sulle alture non c’è rinascita, non c’è scintilla di coscienza, non c’è vita. |