Non accettiamo gli altri per quello che sono, ma proiettiamo su di essi le nostre aspettative
di Francesco Lamendola - 24/08/2012
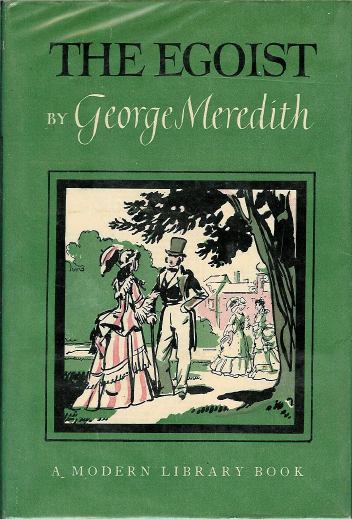
Noi non vediamo gli altri per quello che sono, non li accettiamo per quello che sono, non li accogliamo così come son, ma li vediamo attraverso il filtro delle nostre aspettative, dei nostri timori, delle nostre speranze, delle quali, in genere, essi non sanno assolutamente nulla; li sovraccarichiamo del peso enorme delle nostre proiezioni mentali e poi, quando essi ci “deludono” perché non rispettano i nostri schemi, ci arrabbiamo con loro, ne rimaniamo offesi e disgustati, li espelliamo rudemente e li cancelliamo dalla nostra vita.
Certo, potremmo cavillare, pirandellianamente, sulla pretesa di stabilire chi siamo noi e chi è l’altro, quando invece, a ben guardare, forse non c’è alcun “io” dietro le maschere che nascondono ciascuno di noi, allo sguardo altrui non meno che al nostro; ma si tratta di una questione che, per quanto sia importante sul piano speculativo, non cambia gran che nella dimensione della vita quotidiana: nella quale, di norma, il vero problema non è l’assenza di un “io”, ma l’ostinata, radicale incapacità di molte persone ad accettare l’altro per come è, per come si presenta, per come si offre e anche, talvolta, per come si nasconde o cerca di sfuggire.
Tale incapacità non deriva da un difetto dell’osservazione, dell’intelligenza o della sensibilità, ma della volontà; quando si è pieni del proprio ego, quando ci si specchia solo in se stessi, si pretende di conformare anche gli altri ai propri bisogni, si proietta su di loro quel che si ha bisogno di vedere e di credere; e si rifiuta di riconoscere tutto quello che non rientra nel quadro così raffigurato, semplicemente ignorandolo.
È un fatto che la nostra attenzione è selettiva: noi non vediamo tutte le migliaia e migliaia di cose che ci stanno attorno, ma solo quelle che, per una ragione o per l’altra, ci interessano: ad esempio, in mezzo a una folla di persone, vediamo solo quella che stavamo aspettando e che ci corrisponde affettivamente; oppure, se siamo appassionati di storia dell’arte, in una strada, in un quartiere, in una chiesa, vediamo solo le architetture, le sculture e le pitture; se siamo accaldati e assetati e ci aggiriamo per le strade deserte di ferragosto, la nostra attenzione cercherà solo l’insegna di una gelateria o di un bar in cui spegnere la nostra sete con una bella bevanda fresca.
Tutto il resto è come se non lo vedessimo, non lo udissimo, non lo gustassimo e non lo odorassimo; rimane sullo sfondo e non viene registrato dalla nostra attenzione; del resto, le cose devono per forza andare così, perché, se la nostra mente registrasse tutti gli innumerevoli stimoli sensoriali ed emotivi che fanno parte del nostro panorama, non solo quando ci rechiamo da un luogo all’altro, ma perfino quando ce ne stiamo seduti in poltrona, a casa nostra, il sovraccarico sarebbe tale da mandarci rapidamente in corto circuito.
Naturalmente noi siamo istintivamente attratti non solo da quello che amiamo o che desideriamo, ma anche da quello che temiamo; l’attenzione di una persona che abbia paura dei cani sarà sempre tesa e pronta a segnalare la presenza dello sgradito animale; mentre l’olfatto di una persona che sia allergica ad un determinato odore, ne sentirà gli effluvi in mezzo a cento altri - e magari così non fosse, almeno in quest’ultimo caso.
Tutti questi, comunque, sono meccanismi normali; altra cosa è quando noi, lasciandoci guidare dal nostro egoismo, pretendiamo di costruirci una falsa immagine dell’altro, deliberatamente anche se non sempre del tutto coscientemente; e un’altra cosa ancora è che noi, messi davanti alla sua realtà, ci rifiutiamo di accettarla e restiamo aggrappati alla maschera che gli avevamo imposta. Quando si verifica questa circostanza, è come se noi rifiutassimo la vita in nome di un fantasma.
Non ne parliamo, poi, se un singolo evento ha impresso su di un nostro simile il marchio di una colpa, di un vizio, di un errore: per noi, istintivamente (anche se poi, almeno in parte, alcuni si sforzano di reagire ai pregiudizi), un uomo che abbia rubato una volta, è e rimarrà sempre un ladro; uno che sia stato sorpreso a mentire, sarà sempre un bugiardo, e via dicendo.
Comportandoci così, noi ci abbandoniamo a una vera e propria volontà di manipolare l’altro; non lo trattiamo da persona, perché la persona è sempre ricca e poliedrica, anche quella in apparenza più monotona e prevedibile: lo trattiamo come se fosse una semplice cosa, della quale si può disporre a piacimento.
Un esempio eloquente di tale atteggiamento è descritto all’inizio del lungo romanzo di George Meredith «L’egoista» (titolo originale: «The Egoist»; traduzione dall’inglese di Sergio De Marco, Torino, Utet, 1969, pp. 29-32):
«Il caso volle che la nazione e il capo della famiglia Patterne [ossia il giovane Sir Willoughby, rampollo dell’antico casato dei Patterne] venissero a sapere, quasi contemporaneamente, dell’esistenza di un certo tenente Crossjay Paterne, del benemerito corpo della valorosa fanteria di marina, grazie a un atto di eroismo - di quell’eroismo freddo e senza pretese che infiamma l’animo britannico - computo dal modesto ufficialetto, durante l’assalto ad una roccaforte nel lontano Oriente, lungo la costa cinese. Che l’ufficiale fosse giovane si capiva dal suo grado, ed anche dal suo racconto, nel quale, con grande modestia, diceva “di aver fatto solo il proprio dovere”. Il nostro Willoughby si trovava allora all’università, emulo dello slancio generoso dei suoi giovani anni; il racconto, ed il proprio cognome stampato sui giornali, gli fecero una strana impressione. Ci pensò sopra parecchi mesi finché, rimasto erede del titolo e del patrimonio, spedì al tenente Crossjay Patterne un assegno per una somma di denaro pari a un anno di paga del valoroso giovanotto. Allo stesso tempo rivelò di conoscere i principi basilari - o, piuttosto, chimici - della generosità, dichiarando ai propri amici che “il sangue è più spesso del’acqua”. Sì, costui non è che un soldato, ma è pur sempre un Patterne. Come poi un Patterne fosse andato a finire nella fanteria di marina, è una delle tante domande sciocche che pretendiamo di fare al destino. La lettera complimentosa che accompagnava l’assegno invitava il tenente a presentarsi alla dimora avita, quando gli fosse piaciuto; e lo assicurava che,- grazie a lui - al suo parente ed amico Willoughby era quasi venuta voglia di farsi soldato. Al giovane Sir Willoughby, in verità, piaceva tanto parlare dell’ufficiale suo omonimo e lontano cugino, il giovane Patterne - quello della fanteria di marina. Era divertente, e non meno divertente era la descrizione dell’atto valoroso del suo omonimo, di come aveva liberato il marinaio inglese ubriaco, facendo prigionieri tre seguaci del drago nero in campo giallo, e di come li aveva legati, dorso contro dorso, per il codino, e poi condotti nelle nostre linee mediante uno stile di marcia, a testa bassa, di nuova concezione, tendente all’obliquo, proprio come i sei occhi attoniti dei figli del Celeste impero, ai quali, certamente non riusciva di andare dritti. Lo stato d’animo dei gentiluomini che se ne stanno a casa trae sempre grande beneficio dal racconto di simili imprese, compiute con tale freddezza. […] Il giovane Patterne si mise in testa che il suo valoroso cugino fosse una specie di testa matta, una sorta di eroe del calcio domenicale, e a volte si chiedeva perché il giovanotto si fosse limitato all’invio di una calorosa lettera di ringraziamento, trascurando l’invito alla magione dei Paterne.
Un pomeriggio, al castello, tra un acquazzone e l’altro, egli passeggiava sull’imponente terrazza del giardino in compagnia della fidanzata, la bella e vivace Costanze Durham seguito da gruppi di signore e signori che, in attesa del pranzo, si prendevano una boccata d’aria fresca. Proprio mentre stava, giunto ormai all’estremità della terrazza, tornando sui suoi passi, pur continuando a parlare d’amore, appassionatamente, alla signorina Durham, gli capitò di volgere lo sguardo, con la consueta fortuna (così appunto chiamiamo ciò che ci viene servito dal grande dispensiere segreto, il fato), al viale dei tigli; Sir Willoughby, che era tutt’altro che stupido, ebbe una specie di presentimento nel vedere un uomo tarchiato e corpulento attraversare il tratto ghiaioso tra il viale e la scalinata principale. Nessun segno, decisamente, faceva pensare che costui fosse un gentiluomo: “né il cappello, né il soprabito, né i piedi, né qualsiasi altra cosa che gli appartenesse, come ebbe a dire più tardi Willoughby alle signore della sua famiglia, in quello stile da sacra Scrittura proprio dei gentiluomini che si rivelano tali a prima vista. Gli bastò osservare di sfuggita quell’essere per provare un brivido di ripugnanza: il nuovo arrivato, infatti, portava una grossa valigia, il bavero del cappotto rialzato e in testa un cappello dal’aspetto triste; sembrava un commerciante fallito in cerca di rifugio; e non aveva né guanti né ombrello. […]
Il biglietto da visita de tenente Pattterne fu portato fu portato a Sir Willoughby, che lo ripose nel vassoio e disse al servitore: “Non sono in casa”.
Era stato deluso dall’età e ancor più dall’aspetto di quell’uomo che pretendeva di essere suo parente in modo tanto inopportuno; ed il suo istinto acuto gli fece rapidamente intuire l’assurdità di presentare ai suoi amici quell’uomo maturo, dalla figura pesante - del tutto impresentabile - come il famoso, valoroso tenente della fanteria di Marina, e come membro della famiglia! Aveva parlato troppo di quell’uomo, e con troppo entusiasmo, per poterlo fare.»
Qui si potrebbero fare molte considerazioni di natura sociale, compresa l’ipocrisia del gentiluomo che pensa, per mettersi a posto con la coscienza, di mandare un ulteriore assegno al suo sfortunato parente, ma si rifiuta di riceverlo e presentarlo agli amici per il suo aspetto “impresentabile”; tuttavia, per restare fedeli al nostro tema, ci limiteremo all’aspetto psicologico.
Sir Willoughby si era invaghito di una immagine ideale e romantica del suo lontano parente, per aver letto sul giornale di una sua eroica impresa di guerra; quando si trova davanti l’originale, si rifiuta di riconoscerlo e lo fa liquidare dalla servitù come se fosse l’ultimo degli estranei: troppo imbarazzante sarebbe stato presentarlo in società. È il classico caso in cui si volgono le spalle alla realtà dell’altro per non dover rinunciare all’immagine mitica di lui; si sacrifica, cioè, una persona viva, per poter seguitare a corteggiare un fantasma.
La cosa è tanto più grave, in quanto era stato Sir Willoughby a fare il primo passo, a scrivere al suo lontano e sconosciuto parente, a invitarlo a venire a trovarlo in Inghilterra; salvo poi fare finta di non sapere chi egli sia e tenerlo fuori della porta come l’ultimo degli accattoni. Ebbene, sono molte le persone che si comportano in questo modo: fanno il primo passo, invitano l’altro (o l’altra), anche in senso sentimentale e sessuale; ma poi, improvvisamente, si pentono di quell’invito, compiono un brusco dietro-front e diventano addirittura furiose se quello (o quella) stenta a rendersi conto che le cose sono cambiate e che la sua presenza non è più gradita.
Eppure, entrare nella vita di un altro essere umano, o invitarlo ad entrare nella nostra, non è una cosa da nulla; meno ancora se l’invito ha riguardato anche il letto, se ha coinvolto la sfera affettiva profonda; se, per un momento, è sembrato stabilire un intenso legame con l’altro, anche solo per pochi istanti, dando la sensazione di una affinità perfetta, di una corrispondenza intima. In tali casi, mettere l’altro alla porta, di colpo, magari dicendogli: «È stato bello, ma ora dobbiamo dirci addio», o, peggio ancora: «È stato un errore, dimentichiamoci tutto quello che è successo», non è altrettanto facile che mettere alla porta un venditore ambulante che abbia suonato al nostro campanello. Non si gioca coi sentimenti; se lo si fa, lo si fa a proprio rischio e pericolo, e ci si assume la responsabilità del male che verrà fatto agli altri.
Anche se sovente dissimulato dietro una certa cortesia formale, si tratta di un modo di fare improntato ad un egoismo feroce e ad un assoluto cinismo, per non dire a un aperto disprezzo dell’altro; non ha importanza ciò che egli sente, ciò che desidera, ciò che è; importa solo e unicamente quello che egli rappresenta per noi, la parte che noi vogliamo che egli impersoni a nostro beneficio.
L’utilitarismo e la volontà di manipolazione qui procedono senza remore e senza ombra di perplessità o di rimorso. È qualcosa di più della semplice attitudine allo sfruttamento dell’altro, per cui, ad esempio, questi ci serve quando ne abbiamo voglia o bisogno, mentre non esiste quando è lui che avrebbe bisogno di noi; si tratta di un passo ulteriore e radicale sulla via della riduzione di tutto alla nostra misura, poiché qui noi pretendiamo che una persona non solo si comporti, in una determinata circostanza o anche in più circostanze, come noi vogliamo e che poi scompaia totalmente dal nostro orizzonte, ma che ella sia, “in toto” e per sempre, ciò che a noi fa comodo e quindi non sia più se stessa, non sia ciò che è e ciò che deve essere, ma che diventi ciò che noi vogliamo, una volta per sempre.
Sovente, per amare o per odiare qualcuno, ricorriamo a questa “reductio ad unum” dell’altro; non ci passa neanche per la testa che anche lui, come tutti, sia suscettibile di evoluzione, di cambiamento: se ci ha delusi una volta, ci ha delusi per sempre; se lo abbiamo ammirato una volta, deve continuare ad essere ammirevole, ma non seguendo la sua natura, bensì uniformandosi alle nostre aspettative. Gli imponiamo un fardello perenne e insindacabile, del quale egli forse non sa nulla e di cui ci riserviamo d’essere i giudici onnipotenti.
Il minimo che si possa dire di un tal modo di fare è che esso costituisce la più completa negazione della relazione umana, se la relazione consiste nell’incontro fra due soggetti autonomi e dotati di una propria volontà, che siano quindi capaci di ascoltarsi, di porsi, di valorizzarsi reciprocamente. Qui non c’è rapporto, perché l’altro non viene posto, ma negato nella sua autonomia e, in fondo, nella sua stessa dignità di persona.
Purtroppo non è strano che una simile attitudine sia tanto diffusa, in una società che ha fatto dell’ego, del successo e del potere i grandi feticci da adorare.
Ma quali prospettive ha di sopravvivere una società in cui il soggetto non sa più dire “tu”, non sa porre l’altro, anzi non riesce neppure a vederlo?

