Ucraina. Una guerra per procura
di Eugenio Di Rienzo - 16/05/2016
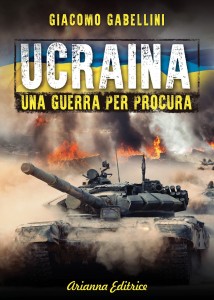
Fonte: Il Discrimine
Per gentile concessione di Arianna Editrice, pubblichiamo l’Introduzione al libro di Giacomo Gabellini Ucraina. Una guerra per procura, appena dato alle stampe.
Per la maggior parte della seconda metà del XX Secolo, l’Unione Sovietica ha controllato l’Eurasia dalla Germania orientale al Pacifico, dal Caucaso all’Hindukush. Dopo il 1991, la Russia ha arretrato la sua frontiera occidentale a est di quasi mille chilometri, dal confine tedesco alla frontiera con la Bielorussia. In questo modo il potere di Mosca è indietreggiato verso oriente più di quanto mai era accaduto nel passato. Dopo il disfacimento dell’Impero sovietico, Kiev ha iniziato la sua lunga, non rettilinea marcia per arrivare a un allineamento con Europa occidentale e Stati Uniti e a un allontanamento dalla Russia. Questo processo ha rappresentato un punto di rottura nella storia russa. Il recente colpo di Stato in Ucraina è stato il momento in cui la Guerra Fredda è definitivamente finita per la Federazione russa. I cittadini di Mosca, San Pietroburgo, Volgograd, Novgorod, Vladivostok hanno giustamente interpretato la “rivoluzione di Majdán Nezalžnosti” come il tentativo degli Stati Uniti di spingere l’Ucraina nella Nato e quindi di preparare il terreno per la definitiva disintegrazione della Russia come Grande Potenza1.
Se Washington riuscirà davvero a inserire stabilmente l’Ucraina nel blocco occidentale, la Russia diverrà automaticamente indifendibile. Il confine meridionale con la Bielorussia e la frontiera sudoccidentale non offrirebbero, infatti, alcun ostacolo all’ingresso di un potenziale invasore. Dopo aver assistito a questo tentativo di minare le basi geostrategiche della sua sicurezza russa, Mosca è tornata con maggior forza a promuovere una strategia in grado di riaffermare la sua sfera d’influenza storica nelle aree dell’ex Unione Sovietica. Anche se il limite degli interessi strategici della più grande Nazione slava resterà a lungo materia di controversie, è certo che la ritirata della Dherzava (Potenza russa) è terminata nella notte del 23-24 febbraio 2014, quando un ben orchestrato colpo di mano, presumibilmente portato a termine con la complicità di una parte delle Cancellerie occidentali, defenestrò il Presidente filo-russo dell’Ucraina Viktor Janukovyč. Gli Stati Uniti e i Paesi del vecchio Patto di Varsavia cercheranno sicuramente di arrestare la reconquista russa. Ma anche se la Russia non riuscirà a riacquistare il suo status di Potenza globale nel prossimo decennio, essa lotterà comunque con tutte le sue forze per restare almeno una Grande Potenza regionale. E questo non potrà non portare a un conflitto – “caldo” o “freddo” si vedrà – con l’Alleanza Atlantica, l’amministrazione statunitense e i “Big Three” dell’Unione Europea (Berlino, Parigi, Londra).
La frontiera russo-europea tornerà a essere, come nel passato prossimo, una “linea di faglia”: una frattura che evidenzia la contrapposizione di Grandi Spazi geopolitici fatalmente destinati a entrare in rotta di collisione. È errato e irragionevole, infatti, parlare di Europa come si trattasse di un’unica entità politica. Non lo è, nonostante l’esistenza del fragile sistema guidato da Bruxelles, perché il nostro continente è ancora costituito da Stati-Nazione sovrani, mossi da interessi divergenti e conflittuali. Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Polonia e gli Stati Baltici sono nella Nato, dove domani entreranno anche Moldavia, Georgia e Ucraina, Finlandia, Svezia. Anche la Bielorussia è a rischio e quando un’altra sollevazione di piazza spontanea, oppure manovrata come quella di Kiev, o in alternativa una “rivoluzione di palazzo” obbligherà a Minsk a ripudiare la sua lealtà verso il Cremlino, un potenziale schieramento avverso a Mosca sarà penetrato più profondamente verso il cuore del territorio russo di quanto abbiamo fatto le armate del Terzo Reich durante la Grande Guerra Patriottica del 1941-1945. Pressato dalle enormi difficoltà economiche e militari, il nuovo governo di Kiev difficilmente potrà sfuggire al suo eterno destino di “Stato-marionetta”, i cui fili saranno tirati questa volta dalla Casa Bianca e dalla Cancelleria di Berlino. Se questo governo avrà la forza di sopravvivere e di consolidarsi, la posizione della Russia nello scenario internazionale sarà quella di un “gigante incatenato” costretto a difendersi senza poter attaccare o contrattaccare. Nemmeno la minaccia d’interrompere le forniture di gas naturale verso l’Europa le permetterà di porre rimedio a una situazione d’insanabile e gravissima vulnerabilità strategica. Allora il futuro della Russia si riassumerà nell’unica parola che nessuna Nazione vorrebbe mai essere obbligata a pronunciare: Incertezza.
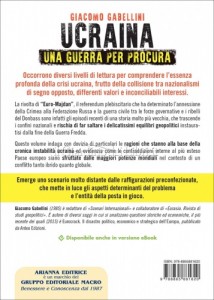 Quando la Guerra Fredda terminò, molti si persuasero che le questioni geopolitiche più gravi erano state in gran parte risolte. Con l’eccezione di alcuni problemi relativamente minori, come la fastidiosa questione dell’ex Jugoslavia e l’assillante disputa israelo-palestinese, allora si reputò che i maggiori problemi di politica mondiale non avrebbero più riguardato la difesa dei confini, l’installazione di nuove basi militari, la delimitazione delle sfere d’influenza, i conflitti etnici, religiosi, nazionali. In quel momento apparve all’orizzonte della storia l’epifania dell’“Secolo americano” e con esso la promessa di un assetto mondiale giusto, pacifico e duraturo. L’iscrizione virgiliano-massonica incisa nel 1782 sul lato posteriore del Gran Sigillo degli Stati Uniti d’America (Novus Ordo Seclorum) riacquistò nuovamente tutto il suo valore profetico. In Medio Oriente, dopo il 26 dicembre 1991, il predominio delle Potenze sunnite (Arabia Saudita, Stati del Golfo, Egitto e Turchia legate a Washington dal desiderio di stabilizzare questa regione ma anche da interessi opachi e inconfessabili) garantì il successo della tattica del “doppio contenimento” verso Iran e Iraq. In Asia, si potenziò la preponderanza strategica statunitense, la cui tenuta fu assicurata da una serie di patti di cooperazione politico-militari con Giappone, Corea del Sud, Australia, Indonesia e altri minori alleati. In Europa, la sistemazione politico-territoriale post-Guerra Fredda consentì il ripristino dell’unità della Germania, lo smembramento dell’Unione Sovietica e l’integrazione degli Stati dell’ex Patto di Varsavia e delle Repubbliche Baltiche nella Nato e nell’Unione Europea.
Quando la Guerra Fredda terminò, molti si persuasero che le questioni geopolitiche più gravi erano state in gran parte risolte. Con l’eccezione di alcuni problemi relativamente minori, come la fastidiosa questione dell’ex Jugoslavia e l’assillante disputa israelo-palestinese, allora si reputò che i maggiori problemi di politica mondiale non avrebbero più riguardato la difesa dei confini, l’installazione di nuove basi militari, la delimitazione delle sfere d’influenza, i conflitti etnici, religiosi, nazionali. In quel momento apparve all’orizzonte della storia l’epifania dell’“Secolo americano” e con esso la promessa di un assetto mondiale giusto, pacifico e duraturo. L’iscrizione virgiliano-massonica incisa nel 1782 sul lato posteriore del Gran Sigillo degli Stati Uniti d’America (Novus Ordo Seclorum) riacquistò nuovamente tutto il suo valore profetico. In Medio Oriente, dopo il 26 dicembre 1991, il predominio delle Potenze sunnite (Arabia Saudita, Stati del Golfo, Egitto e Turchia legate a Washington dal desiderio di stabilizzare questa regione ma anche da interessi opachi e inconfessabili) garantì il successo della tattica del “doppio contenimento” verso Iran e Iraq. In Asia, si potenziò la preponderanza strategica statunitense, la cui tenuta fu assicurata da una serie di patti di cooperazione politico-militari con Giappone, Corea del Sud, Australia, Indonesia e altri minori alleati. In Europa, la sistemazione politico-territoriale post-Guerra Fredda consentì il ripristino dell’unità della Germania, lo smembramento dell’Unione Sovietica e l’integrazione degli Stati dell’ex Patto di Varsavia e delle Repubbliche Baltiche nella Nato e nell’Unione Europea.
Questo momento storico appartiene ormai al passato. Con la rinascita delle ambizioni imperiali di Cina, India, Iran, Turchia, con la destabilizzazione generale del Medio Oriente, provocata ancor più dall’insensata strategia statunitense in quella regione che dalla barbarie jihadista, e soprattutto con la vigorosa ripresa di attività di Mosca in tutti i teatri internazionali, il rassicurante scenario del New World Order si è avviato verso un irreversibile declino. In questa fase, la Russia si presenta come una Potenza revisionista di media entità, sicuramente dotata di maggiori energie e risorse dell’Iran, ma più debole della Cina. Più abile a muoversi sulla scacchiera geopolitica di quanto sia stata capace di fare la Cina, come ha dimostrato la capacità di Mosca d’incunearsi sapientemente nell’alleanza tra Berlino e Washington fino al precipitare della crisi ucraina, ma meno abile dell’Iran a muoversi sul terreno dei conflitti regionali. Pur con molti limiti, dovuti in massima parte all’ancora insufficiente modernizzazione tecnologica dell’esercito russo e alla debolezza di un’economia troppo dipendente dal riciclaggio dei proventi derivanti dalla vendita di energia, Putin ha riportato un notevole successo nel frustrare i tentativi occidentali di penetrare nello spazio post-sovietico.
 Putin ha posto definitivamente fine al conflitto ceceno, disgregato la Georgia, ricondotto il governo di Erevan nell’orbita di Mosca, rafforzato il ruolo dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (sottoscritto da Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan), rinsaldato i vincoli di amicizia con Cina, Iran, India, Afghanistan, Siria, Egitto, Grecia e Serbia, mantenuto la presa sulla Crimea e, con l’intervento in Ucraina, inflitto all’Occidente un’imprevista quanto mortificante sconfitta. Questo bilancio sicuramente positivo può essere spiegato anche sulla base delle diversità culturali che distinguono il premier russo dai suoi colleghi del fronte euro-atlantico. A differenza di Obama, della Merkel, di David Cameron, di François Hollande, Matteo Renzi, Putin ha letto e meditato il vecchio von Moltke. Da lui ha appreso che «ogni promessa di pace perpetua», fatta da una Potenza che aspira al dominio mondiale, corrisponde «solo a un sogno e neppure a un sogno piacevole» perché quella promessa ha sempre generato soltanto «la pace di un cimitero» per le sventurate Nazioni che hanno creduto a quell’utopia.
Putin ha posto definitivamente fine al conflitto ceceno, disgregato la Georgia, ricondotto il governo di Erevan nell’orbita di Mosca, rafforzato il ruolo dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (sottoscritto da Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan), rinsaldato i vincoli di amicizia con Cina, Iran, India, Afghanistan, Siria, Egitto, Grecia e Serbia, mantenuto la presa sulla Crimea e, con l’intervento in Ucraina, inflitto all’Occidente un’imprevista quanto mortificante sconfitta. Questo bilancio sicuramente positivo può essere spiegato anche sulla base delle diversità culturali che distinguono il premier russo dai suoi colleghi del fronte euro-atlantico. A differenza di Obama, della Merkel, di David Cameron, di François Hollande, Matteo Renzi, Putin ha letto e meditato il vecchio von Moltke. Da lui ha appreso che «ogni promessa di pace perpetua», fatta da una Potenza che aspira al dominio mondiale, corrisponde «solo a un sogno e neppure a un sogno piacevole» perché quella promessa ha sempre generato soltanto «la pace di un cimitero» per le sventurate Nazioni che hanno creduto a quell’utopia.
Durante la crisi ucraina Putin a ricordato al mondo intero che l’Orso russo” possiede ancora muscoli possenti, artigli forti e affilati e soprattutto un cuore indomito che gli permette di tenere a bada grandi e piccoli avversari. Troppo cinico, troppo disincantato, troppo pervaso dalle ragioni della realpolitik, o forse più semplicemente troppo mosso dall’amore egoistico per la sua patria, il nuovo Zar del Cremlino sa inoltre che nessuno degli attuali rivali della Russia sarebbe disposto a “morire per Kiev” dopo aver accettato di morire invano per Baghdad e Kabul. Per dare un giudizio oggettivo sulla legittimità della risposta politico-militare di Putin al terremoto di Kiev e alle sue conseguenze prossime e remote, bisogna comunque ricordare che la maggiore responsabilità per la creazione dell’imbroglio ucraino appartiene a Stati Uniti e Germania e in subordine agli altri “soci di minoranza” della Nato. Ed è responsabilità di lunga durata. La “marcia verso oriente” dell’Alleanza Atlantica avvenne, infatti, al prezzo di una sistematica manomissione degli impegni contratti con Mosca prima della riunificazione tedesca. Nei primi mesi del 1990, il ministro degli Esteri tedesco-occidentale Hans Dietrich Genscher e il Segretario di Stato James Baker, consapevoli che i Sovietici non sarebbero stati disposti a ritirare le loro forze dalla Germania orientale in assenza di sufficienti garanzie per il futuro, dichiararono formalmente che non ci sarebbe stata «nessuna espansione dell’Alleanza Atlantica verso Est», dopo il ricongiungimento delle due Germanie, e assicurarono Ŝevardnadze e Gorbaciov che «mai e in nessun caso la giurisdizione della Nato e quella dell’Unione Europea avrebbero potuto estendersi alle Nazioni dell’Europa orientale».
 L’ultimo credibile tentativo di legare la Russia all’Europa fu sperimentato da François Mitterand che nel 1990 propose, incassando il tiepido sostegno di Helmut Kohl, la creazione di una “confederazione europea” inclusiva di Mosca. Il progetto fu bocciato dal Dipartimento di Stato che invece sostenne la formazione di un “triangolo strategico”, composto da Usa, Germania e Francia, dominato da Washington. La prima decisione presa dal triumvirato fu l’espansione delle funzioni dell’Osce: l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che annoverava significativamente Washington e Ottawa tra i suoi fondatori. La seconda fu il rinforzamento della Nato, giustificato dall’emergenza provocata dalle guerre di secessione iugoslave. La terza portò al via libera dato alla precipitosa adesione all’Alleanza Atlantica di tutti i vecchi satelliti europei dell’Urss. Anche oggi una possibile soluzione della crisi ucraina resta confinata all’interno di questo direttorio euro-atlantico che ormai poggia prevalentemente sull’asse tedesco-statunitense. Dopo che le correnti del Dipartimento di Stato, favorevoli al riarmo di Kiev e al suo inserimento nella Nato, hanno subito una provvisoria battuta di arresto, Obama è stato costretto a delegare la gestione della crisi alla Merkel che, sotto il mantello di un’aggressiva retorica atlantista, pare volersi muovere in realtà per riallacciare le fila del dialogo con Putin seppure nell’ambito di una dimensione transatlantica e non più euro-centrica. Nella media durata l’opposizione degli Stati Uniti a una ripresa delle relazioni tra Bruxelles e Mosca è destinata a restare immutata. Così come rimarrà inalterata, nel più breve periodo, la volontà di Washington di sabotare con manovre irrituali e azioni di disturbo la “Rapallo energetica eurasiatica” che lega Russia e Unione Europea. C’è un incubo, infatti, che aleggia nelle stanze della Casa Bianca, del Pentagono, del Dipartimento di Stato, e in quelle che ospitano i comitati d’affari della finanza e dell’industria statunitense: la nascita di un Asse Berlino-Mosca che farebbe dell’Eurasia, e cioè dell’Unione Europea e della Federazione Russa, la più grande Potenza Globale esistente.
L’ultimo credibile tentativo di legare la Russia all’Europa fu sperimentato da François Mitterand che nel 1990 propose, incassando il tiepido sostegno di Helmut Kohl, la creazione di una “confederazione europea” inclusiva di Mosca. Il progetto fu bocciato dal Dipartimento di Stato che invece sostenne la formazione di un “triangolo strategico”, composto da Usa, Germania e Francia, dominato da Washington. La prima decisione presa dal triumvirato fu l’espansione delle funzioni dell’Osce: l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che annoverava significativamente Washington e Ottawa tra i suoi fondatori. La seconda fu il rinforzamento della Nato, giustificato dall’emergenza provocata dalle guerre di secessione iugoslave. La terza portò al via libera dato alla precipitosa adesione all’Alleanza Atlantica di tutti i vecchi satelliti europei dell’Urss. Anche oggi una possibile soluzione della crisi ucraina resta confinata all’interno di questo direttorio euro-atlantico che ormai poggia prevalentemente sull’asse tedesco-statunitense. Dopo che le correnti del Dipartimento di Stato, favorevoli al riarmo di Kiev e al suo inserimento nella Nato, hanno subito una provvisoria battuta di arresto, Obama è stato costretto a delegare la gestione della crisi alla Merkel che, sotto il mantello di un’aggressiva retorica atlantista, pare volersi muovere in realtà per riallacciare le fila del dialogo con Putin seppure nell’ambito di una dimensione transatlantica e non più euro-centrica. Nella media durata l’opposizione degli Stati Uniti a una ripresa delle relazioni tra Bruxelles e Mosca è destinata a restare immutata. Così come rimarrà inalterata, nel più breve periodo, la volontà di Washington di sabotare con manovre irrituali e azioni di disturbo la “Rapallo energetica eurasiatica” che lega Russia e Unione Europea. C’è un incubo, infatti, che aleggia nelle stanze della Casa Bianca, del Pentagono, del Dipartimento di Stato, e in quelle che ospitano i comitati d’affari della finanza e dell’industria statunitense: la nascita di un Asse Berlino-Mosca che farebbe dell’Eurasia, e cioè dell’Unione Europea e della Federazione Russa, la più grande Potenza Globale esistente.
Tutto questo e altro ancora è bene analizzato nel volume di Giacomo Gabellini, che costituisce un contributo molto importante per comprendere il conflitto di potenza che si sta sviluppando sul fianco Est della Nato, in un quadrante economicamente e geopoliticamente vitale per i destini di tutti i Popoli europei.
***
Note all’Introduzione:
1) Sul punto e per quel che segue rimando a Eugenio Di Rienzo, Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2015.
(per gentile concessione di Arianna Edirice)
*Eugenio Di Rienzo è insegnante di Storia moderna all’Università di Roma La Sapienza. È direttore di “Nuova Rivista Storica” e autore dei volumi Il diritto delle armi. Guerra e politica nell’Europa Moderna (Franco Angeli 2005); Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee (Rubbettino 2012); Le potenze dell’Asse e l’Unione Sovietica, 1939-1945, in collaborazione con Emilio Gin (Rubbettino 2013); Afghanistan. Il Grande Gioco, 1914-1947 (Salerno 2014).


