Il fascismo e noi
di Marcello Veneziani - 22/09/2025
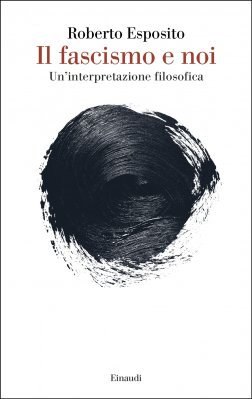
Fonte: Marcello Veneziani
Da anni, ormai, confesso di scansare i libri sul fascismo. Dieci anni fa donai a una Fondazione il settore dei miei libri storico-politici, in cui c’erano più di mille libri dedicati al fascismo, per farla finita con quelle letture. Da tempo avverto un fastidio e un rigetto perché la prevalenza schiacciante dei libri sul fascismo è costituita da cronaca nera, criminologia, esorcismo, rozza demonizzazione del fascismo. Ero abituato a leggere libri che erano frutto di ricerca, senso critico, libera interpretazione e anche revisione, ma sono diventati così rari e silenziati da quando il pre-giudizio cancella ogni giudizio; il fascismo è il paradigma di ogni male e chi ne parla in modo diverso dal canone penale è suo complice. Eppure, anche da una prospettiva antifascista, “per combattere qualcosa, non ci si può limitare a negarlo”, va studiato e capito. La citazione virgolettata è tratta dal libro di Roberto Esposito, Il fascismo e noi, uscito da poco da Einaudi. Quell’Einaudi che in altri tempi pubblicò la monumentale biografia di Mussolini scritta da Renzo De Felice. Esposito è un filosofo e dà una lettura filosofica del fascismo. Pur rassicurando in ogni pagina che è dalla “parte giusta” e condanna il fascismo senza appello, si spinge a conoscere le idee, i presupposti e a confrontarsi anche con autori non allineati alla “vulgata antifascista” come la chiamava De Felice: Ernst Nolte, Augusto Del Noce, Zeev Sternhell, Eric Voegelin, solo per citarne alcuni. E coglie nessi preziosi con alcune figure chiave del pensiero, come Gentile, Heidegger, Schmitt, Jünger, e altri.
La tesi di fondo è significativa: il fascismo non è negazione della filosofia, ma si è intrecciato alla filosofia, e con pensatori di primo piano; la sua è una concezione dell’uomo e del mondo. Prima di essere un regime, un movimento o una dottrina politica, il fascismo è “una macchina metafisica” che genera le sue condizioni d’esistenza e di espansione. L’espressione macchina congiunta a metafisica incrocia mito e tecnica, perché il fascismo tecnologizza il mito e mitizza la tecnologia. Affermazione interessante ma vera solo per quel versante del fascismo che discende dal futurismo in Italia, o da Jünger e dal “modernismo reazionario” in Germania. Il fascismo è anche altro, e giustamente Esposito ricorda che tende a occupare tutti gli spazi. Perfino l’anarchia: in fondo al nero del fascismo c’è il nero dell’anarchia, è il caos primordiale da cui poi discende l’ordine fascista. Fino a che, riassume bene Esposito, il fascismo diventa “rivoluzione senza anarchia, liberalismo senza individualismo, comunismo senza materialismo. Ma anche religione senza trascendenza”.
La macchina fascista per l’autore nasce dall’antagonismo con il comunismo, di cui vorrebbe essere, per Del Noce, una rivoluzione ulteriore, più coerente con la civiltà occidentale e legata alla realtà storica delle nazioni. Il fascismo nasce da tre eventi: la prima guerra mondiale e il passaggio dal risorgimentalismo dell’ottocento al nazionalismo e alla nazionalizzazione delle masse (George Mosse); la crisi del regime liberale e parlamentare; la minaccia del comunismo, che nel ’17 andò al potere in Russia e in Italia incombeva come una rivoluzione imminente. Il suo arsenale politico e conflittuale, il suo apparato ideale e filosofico, estetico e mitologico, nascono in quel crocevia. Così il fascismo – dice Esposito citando Mosse – fu capace di creare un consenso di massa che fu infranto solo da una guerra perduta. Ma lo scontro finale, non dimentichiamolo, fu contro le “plutocrazie occidentali” a cui si associò l’Urss bolscevica dopo che saltò il patto nazi-comunista del 1939. Alla fine il fascismo combatté contro il capitalismo, di cui il comunismo fu invece alleato.
Per Esposito il nazismo è stato “l’apocalisse del fascismo”, nel senso letterale che ne ha rivelato l’impulso latente. In realtà, il nazismo sin dalle sue origini nasce da un mito biopolitico, e traduce “la storia” fascista in natura, in sangue e razza. Il fascismo, invece, coniuga il suo vitalismo con un generico spiritualismo che a volte si incontra, a volte si scontra con il cattolicesimo. Sul piano filosofico i suoi autori di riferimento non sono gli stessi del fascismo: il nazismo usa malamente Nietzsche che il fascismo traduce in d’Annunzio (Mussolini scopre Nietzsche quando era ancora socialista, ma segue altri percorsi). Il fascismo resta neo-hegeliano, mentre Hegel è negato dal nazismo, come scrivono Schmitt, Rosenberg e nel dopoguerra Marcuse. Hegel resta sullo sfondo del leninismo come dello Stato fascista. Ma non solo: degli autori tedeschi contemporanei Mussolini si innamora, ricambiato, di Oswald Spengler che a differenza di Heidegger e Schmitt è ostile al regime hitleriano. Esposito segue la tesi di Simone Weil che i veri eredi dell’impero romano fossero i nazisti, mentre i fascisti si limitarono a evocare l’apparato simbolico; vero fino a un certo punto, se si pensa alla preminenza dell’idea dello Stato, assente nel nazismo che invece punta sul popolo, la razza e il capo (Führerprinzip non è il culto del duce per le folle latine). Il fascismo tramite Gentile torna a Hegel, il nazismo no. Giustamente Esposito riconosce che Gramsci si accosta più a Gentile che a Croce. E riconosce, come sostengo da tempo, che Gentile fu più coerente, rispetto ai “nazisti” Heidegger e Schmitt, e lo fu fino alla morte.
A proposito di Heidegger, Esposito sostiene che abbia aderito al nazismo in modo consapevole e meditato, come dimostrerebbero i “famigerati Quaderni neri” (non si può ridurre quel vasto laboratorio di idee all’adesione al nazismo). Qui Esposito compie un’operazione a mio parere pericolosa: riduce la questione dell’Essere alla questione ebraica, fino a ritenere metafisico l’antisemitismo di Heidegger. Mi pare una lettura impropria: è il tema di fondo in cui si dibatte l’Occidente da Parmenide a Severino e non può essere la trasposizione metafisica dell’antiebraismo. Non a caso, la sintesi semplificativa di questa tesi è riassunta in un’affermazione: chi è sradicato sradica, dunque l’ebreo sradicato è il principale veicolo dello sradicamento globale, che è il male metafisico di oggi per Heidegger. Ma quella frase non l’ha mai pronunciata Heidegger: è della pensatrice ebrea e operaista Simone Weil e la scrive, anche in polemica col suo stesso popolo, nel libro L’enracinement, sul radicamento.
Peraltro allo spirito guerriero del nazismo è assai più vicino Jünger, che pure fu ostile al regime, piuttosto che Heidegger: dalle sue tempeste d’acciaio alla sua mobilitazione totale, dal suo Milite del Lavoro al suo naturalismo conciliato con la tecnica, trae linfa la “metafisica” del nazismo.
Infine dissento sull’uso della definizione fascismo nel presente, in particolare riferito agli Stati Uniti. L’epoca, i protagonisti, le condizioni, i valori, l’opzione capitalista, sono del tutto diversi; non sarebbe il caso di trovare un altro nome al trumpismo, anziché ricorrere come al solito stereotipo fascista? E di Putin, dovremmo dire che è la riedizione del comunismo sovietico? Lo stesso Esposito rigetta la definizione di fascismo eterno (Umberto Eco). Rispettiamo la storia e le differenze. A ogni epoca le sue croci (e le sue glorie).
