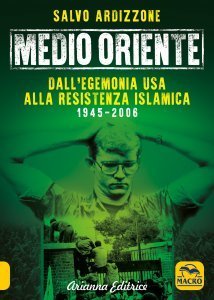Medio Oriente
di Salvo Ardizzone - 10/01/2022

Fonte: Italicum
Intervista a Salvo Ardizzone, autore del libro “Medio Oriente”, Arianna Editrice 2021, a cura di Luigi Tedeschi
D. 1) L’epoca dei regimi del socialismo arabo è ormai tramontata. Furono regimi autocratici che, con tutti i loro fallimenti, le loro conflittualità e le loro contraddizioni evidenti, emersero da movimenti che si dimostrarono comunque determinanti nella lotta per l’indipendenza dei popoli arabi e conferirono una identità politico – culturale ai nuovi stati sorti dalla decolonizzazione. Contribuirono inoltre alla emancipazione e alla modernizzazione di popoli già emarginati dalla storia. Al crollo dei regimi autocratici, hanno fatto seguito solo il caos politico generalizzato e conflitti – etnico religiosi senza sbocchi. Con la fine del socialismo arabo, non è scomparso un modello di riferimento, senza alcuna prospettiva di nuovi equilibri geopolitici nell’area mediorientale e nordafricana?
R. I movimenti che si intestarono il processo di decolonizzazione, Baath, nasserismo, lo stesso Fln algerino, seppero liquidare le dominazioni coloniali in quanto esse erano anacronistici fenomeni antistorici, ma nessuno di essi riuscì (né, in realtà, ci provò seriamente) a costruire sistemi politici capaci d’interpretare le aspirazioni delle popolazioni musulmane che pur, nelle fasi iniziali, tributarono a essi un forte consenso, e si evolsero tutti in regimi duri, alcuni durissimi.
Le identità politico – culturali che conferirono ai nuovi stati furono spesso distanti da quelle autenticamente espresse dai popoli che ci vivevano, insomma, sovrastrutture velleitarie; basta far cenno alla pretesa del Baath, che rinnegava i singoli stati definiti regioni, di riconoscersi in un’unica nazione araba, o i velleitari tentativi di Nasser di “unioni a freddo”, vedi la R.A.U. con la Siria (degli esperimenti estemporanei di Gheddafi è inutile parlare).
La ragione prima di questa distonia fu che le leadership di quei movimenti provenivano da ambienti intellettuali o militari che si erano formati in Occidente, imbevendosi di dottrine positiviste che, seppur filtrate da una certa elaborazione politica, finivano per suonare ostiche o irricevibili al sentire profondo delle masse. Per cui, più che autentici interpreti dei propri popoli, finivano per essere pur sempre emanazione della cultura politica occidentale. Lo stesso Nasser riscosse un consenso plebiscitario grazie a posizioni populiste, impregnate da un nazionalismo panarabo eterodosso, ma ebbe la sorte di morire prima che il completo fallimento del suo modello (che di fallimenti ne aveva già collezionati tanti) sbriciolasse l’idolo che rappresentava per le masse.
Il socialismo arabo non è dunque finito, ma ha semplicemente fallito in quanto, pur avendo dinanzi masse più che disponibili a un radicale cambiamento, metteva in campo (quando lo faceva) dottrine non in linea con i paesi presso cui si è sviluppato, con leadership avulse dal sentire delle masse (di cui non si curavano più di tanto, anzi, disprezzavano i valori profondi espressi della gente e, quando li assecondavano, lo facevano per raccogliere consenso). In definitiva, i regimi forti che ha originato avevano lo scopo primario di mantenere al potere oligarchie e, se un certo sviluppo hanno originato, è stato un modo di comprare l’appoggio di taluni ceti assai più che mirare a una crescita armonica delle società.
È poi da sottolineare che è stato l’Occidente (e/o i suoi alleati arabi) a segnare la fine di quelle esperienze, con attacchi diretti (vedi Guerre del Golfo) o indiretti (vedi varie “primavere”). Quando quei regimi sono crollati, hanno lasciato dietro di sé il nulla; il caos che ne è seguito è stato conseguenza diretta della loro natura: oligarchie che avevano occupato il potere, ponendo le società sotto una cappa. Quanto poi ai conflitti che ne sono conseguiti, non sono stati conflitti etnici, malgrado tensioni si fossero accumulate, meno che mai religiosi, ma indotti da precisi disegni di destabilizzazione che hanno fatto leva sulle linee di faglia di quelle società per sgretolarle.
A tal proposito, nel mio ultimo libro (Medio Oriente. Dall’egemonia Usa alla Resistenza Islamica) dedico diverse pagine alle Dottrine Bernard Lewis e Yinon, con le loro teorie di scomposizione dello scenario mediorientale, fatte proprie da think-tank e decisori politici statunitensi e israeliani, e alle dinamiche distruttive che sono state sviluppate.
Che poi quei regimi potessero essere un modello di riferimento personalmente non direi, erano regimi che non esito a definire iniqui; riferimento lo erano semmai per le potenze occidentali, che li hanno giostrati a seconda dei propri interessi, Usa in testa.
Quando potranno sorgere nuovi equilibri? Dall’osservazione dei fatti, è mia convinzione che nel MENA sia in corso da molto tempo uno scontro fra i vecchi assetti, che intendono mantenere il controllo sulla regione, e i nuovi, che combattono per liberarsi. In altre parole, una lotta fra oppressori e oppressi, fra il Vecchio e il Nuovo Medio Oriente che vuole emergere. È questo il filo rosso che lega e spiega gli eventi.
Alla luce di ciò, i nuovi equilibri cominciano già a intravedersi, in alcune vaste aree sono ormai delineati, ovvero dove l’antico sistema oppressivo è ormai in crisi irreversibile e combatte le ultime battaglie prima di prendere atto della sconfitta (come sta avvenendo in Iraq, Yemen e nello stesso Libano, ma anche altrove).
D. 2) L’Islam ha costituito un valore identitario di coesione e di riscatto politico – culturale per i popoli arabo – islamici. L’Islam ha rappresentato un valore spirituale universale unificante, per popoli diversi suddivisi in stati artificialmente creati in base alle spartizioni coloniali delle potenze europee dominanti nei secoli scorsi. L’Islam dovrebbe dunque essere un elemento identitario di contrapposizione al dominio imperialista dell’Occidente americano. Tuttavia, date le conflittualità interconfessionali esistenti e le nuove eresie sanguinarie islamiche diffusesi negli ultimi decenni, l’Islam è divenuto un fattore di destabilizzazione dell’area mediorientale e nordafricana. Anzi, i fanatismi diffusi hanno fornito una sovrastruttura ideologica necessaria per le guerre d’aggressione condotte dagli imperialismi vecchi e nuovi. L’Islam quindi, da valore spirituale unificante, non si è trasformato in uno strumento della “strategia del caos” e di dissoluzione degli stati?
R. Prima di risponderle, devo necessariamente ribattere ad alcune affermazioni che precedono la sua domanda: nell’Islam non ci sono sostanziali conflittualità interconfessionali e le eresie sviluppatesi negli ultimi decenni non hanno a che vedere con l’Islam più di quanto Michele Greco, con le sue improbabili citazioni dei Vangeli nei processi, ne aveva con il Cattolicesimo.
L’Islam non è un fattore destabilizzante del MENA né, tantomeno, è uno strumento della “strategia del caos”, semmai è stato vittima di una gigantesca operazione di disinformazione finalizzata alla costruzione di un “Nemico”, che giustificasse gli interventi di destabilizzazione tesi a realizzare gli interessi egemonici degli Usa e dei suoi alleati.
Andiamo con ordine: negli anni Novanta del secolo scorso, fra i think-tank “neocon” americani si affermarono le tesi elaborate anni prima da Bernard Lewis, uno studioso britannico ex collaboratore dei Servizi, e ciò in assonanza con quanto già formulato dal giornalista Odet Yinon in Israele.
Come ho già accennato, secondo tali dottrine Usa e Israele avrebbero dovuto decomporre gli stati mediorientali, facendo leva con qualsiasi mezzo sui loro punti critici, al fine di destrutturare l’area e ricomporla secondo i loro interessi o, in alternativa, determinando quel “caos creativo” (copyright by Hillary Clinton) che inibisse quelle aree a chi era giudicato un avversario (con ciò facendo espresso riferimento all’Iran e, soprattutto, alla proiezione della Rivoluzione Islamica).
Terzo pilastro del progetto era l’Arabia Saudita, giudicata essenziale per la creazione, il controllo e l’indirizzo dei gruppi che avrebbero dovuto destabilizzare la regione, replicando il ruolo interpretato con successo al tempo dell’invasione sovietica dell’Afghanistan.
Un simile progetto avrebbe dato il via a un ciclo di guerre ma, se centri di potere e complessi militari-industriali erano entusiasti di una tale prospettiva, l’opinione pubblica Usa non ne era per nulla interessata; occorreva “qualcosa” che la sintonizzasse su quel programma e giustificasse una politica d’aggressione dinanzi al mondo. In altre parole, occorreva un “Nemico” contro cui gli Usa (e i loro alleati) potessero dichiarare una guerra permanente con il consenso generale.
Il “qualcosa” accadde l’11 settembre e il “Nemico” esisteva già da anni, perché creato dalle Intelligence americana e saudita al tempo dell’invasione sovietica dell’Afghanistan e, da allora, mai perso di vista. Da quel momento gli Usa scesero in guerra contro il “Terrore”, ovvero contro chiunque l’Amministrazione del momento ritenesse conveniente.
La riuscita di una tale strategia è stata resa possibile da una colossale operazione di “framing” operata dal sistema mediatico americano e avallata dai media dell’intero Occidente; in “Medio Oriente” dedico più pagine a spiegare come essi si prestarono a una sistematica narrazione dei fatti distorta, lacunosa e faziosa, realizzando una gigantesca disinformazione collettiva.
Fulcro di questa operazione è stata una campagna contro l’Islam: descrivere quella religione e quella cultura nel modo più distorto, accreditando di esse l’immagine oscurantista e fanatica del wahabismo, vicino ai gruppi terroristici nati grazie alle manovre saudite e gli aiuti Usa, è servito a creare il “Nemico” e giustificare gli interventi militari.
A conclusione di quanto detto, ribadisco che il sedicente “scontro di civiltà” sia strumentale, evocato per motivare un vasto programma d’aggressione, come pure, assimilare all’Islam alle farneticazioni dei takfiri (così vengono chiamati dai veri islamici), o ritenerli parte di esso, sia una mistificazione fuorviante. Affermare dunque che siano stati i fanatismi in qualche modo presenti nell’Islam a fornire il pretesto per le guerre d’aggressione è invertire i ruoli, avallando la narrazione bugiarda del mainstream.
Allo stesso modo, insistere nella convinzione che sia in corso uno scontro interconfessionale fra sunniti e sciiti è falso, il nocciolo della questione è politico: l’Iran è la potenza guida della Rivoluzione Islamica che guida la Resistenza contro il sistema di potere che ha oppresso e opprime quella regione; le petromonarchie del Golfo e gli altri potentati locali fanno parte di quel sistema e per questo si oppongono con ogni mezzo al cambiamento. È tutto qui il discorso e il fatto che taluni stati siano a maggioranza sciita e altri sunnita non è affatto il cuore del problema.
Alla luce di quanto detto, spero sia chiaro che l’Islam non sia in alcun modo uno strumento della “strategia del caos”, ma sia stato così dipinto dall’interessata vulgata occidentale. Piuttosto, per i suoi principi correttamente intesi, è invece la fonte di un progetto di liberazione rivolto a tutti gli oppressi; sciiti, sunniti, anche cristiani, non fa differenza.
D. 3) Con la nascita della Repubblica Islamica si è affermato un nuovo sistema politico di natura identitaria islamica e antimperialista nei confronti dell’Occidente. La rivoluzione iraniana fu concepita da Khomeyni come un evento che avrebbe potuto estendersi a tutto il mondo islamico. tuttavia tale rivoluzione rimase circoscritta all’Iran. Anzi, l’Iran fu aggredito e combattuto da altri stati islamici. Si è inoltre rivelata insanabile la frattura interna all’Islam fra sciiti e sunniti, tuttora coinvolti in uno stato di guerra permanente. Quali sono le cause che hanno impedito al modello iraniano di espandersi e universalizzarsi?
R. La Rivoluzione Islamica non è rimasta affatto circoscritta all’Iran, al contrario, e la continua espansione dell’Asse della Resistenza è lì a dimostrarlo. In Libano, Iraq, Yemen, Palestina, Bahrein, e ora anche in Afghanistan e persino in Pakistan, in tante parti del mondo si sta radicando, anche in Nigeria, dove ne sentiremo parlare presto. Da questa proiezione, che minaccia sistemi di dominio e antiche egemonie, nascono le tante guerre scatenate prima per soffocarla (vedi la Guerra Imposta provocata da Saddam Hussein con l’appoggio degli stati del Golfo e dell’Occidente) e poi per frenarla (vedi i lunghi conflitti in Siria, Iraq, Yemen, Libano e Palestina).
In ormai cinquant’anni, malgrado repressioni selvagge, guerre, aggressioni d’ogni tipo, sanzioni, non è mai capitato che movimenti ispirati alla Rivoluzione Islamica siano stati sradicati, al contrario, essi si sono sempre sviluppati, accrescendo il radicamento nelle rispettive società. Ed è la Storia che lo afferma, non è un’opinione. È per questa riconosciuta capacità che la Dottrina della Resistenza è considerata un pericolo esiziale sia dalle tante monarchie assolute della regione, che in essa vedono la fine dei propri privilegi, sia dalle potenze che traggono utili (enormi) da questo stato di cose (Usa in primis).
Come ho già detto, se l’Iran è stato aggredito e combattuto da altri stati islamici, non è accaduto certo in nome della religione, ma a causa della dottrina di liberazione che da esso si proiettava; una dottrina che era una minaccia mortale per i poteri assoluti (e le ricchezze) d’un pugno di famiglie regnanti.
Per questo, lo ripeto ancora, è strumentale parlare di frattura interna all’Islam fra sunniti e sciiti, una frattura evocata per coprire lo scontro fra chi vuole mantenere un iniquo sistema di sfruttamento sulla regione e chi lotta per liberarsi da esso. E ribadisco che in questa lotta di liberazione c’è posto per tutti: sunniti, sciiti, cristiani, drusi, curdi, yazidi e ogni altra etnia o confessione, tutte largamente rappresentate nelle formazioni della Resistenza Islamica. Malgrado tutti gli sforzi di quello che in “Medio Oriente”, con un neologismo, ho chiamato per semplicità Fronte dell’oppressione, non c’è stato modo d’impedire alla Rivoluzione Islamica di espandersi.
Ancora una notazione: quando lei evoca un “modello iraniano” bisogna intendersi; è un errore pensare che la Rivoluzione Islamica sia un modello rigido e la sua applicazione uguale in ogni paese in cui si radichi; per sua costituzione essa si adatta alle condizioni culturali, storiche, sociali ed economiche di ogni popolo, per cui, dagli stessi principi, ispirati ai medesimi valori, deriveranno modelli diversi di Società della Resistenza. In poche parole, il modello iraniano non sarà replicato in Yemen, come quello libanese non lo sarà in Iraq, ma ognuno ne avrà uno proprio.
D. 4) L’area geopolitica mediorientale dal secondo dopoguerra in poi, è sempre stata un teatro di scontro tra le grandi potenze mondiali. Gli USA hanno voluto sostituirsi agli imperi coloniali europei nel dominio geopolitico dell’area. Dopo il crollo dell’URSS, l’unilateralismo americano, con il sostegno di Israele, dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, ha messo in atto la “strategia del caos” con la destabilizzazione interna e l’aggressione degli “stati canaglia”. Alla strategia imperialistica americana, non hanno però fatto riscontro i successi politici programmati, in Iraq, Afghanistan, Siria, Libia. La supremazia militare ed economica americana non si è tradotta in primato geopolitico globale. Gli americani non hanno quindi realizzato un dominio senza egemonia? Gli Usa non sono dunque una potenza imperialistica congenitamente incapace di divenire un impero?
R. Gli Usa sono divenuti egemoni di metà del mondo quando l’Europa si suicidò e l’URSS emerse come loro antagonista; con l’implosione del blocco sovietico gli Stati Uniti rimasero l’unica superpotenza e per qualche tempo s’illusero che la Storia fosse finita, consacrandoli egemoni del mondo. Ma, malgrado i tanti decisori politici che l’hanno creduto, rischiando di auto avverare quella strampalata teoria, la Storia non è finita affatto e lo dimostra l’emergere di un multipolarismo che è nei fatti prima ancora che nelle teorie geopolitiche, e che ha posto crescenti limitazioni al potere a Stelle e Strisce.
Tuttavia, se un dominio globale stringente è nei fatti precluso agli Usa (neanche loro hanno i mezzi e, meno che mai, le capacità per mantenerlo), ritengo necessario soffermarci sulla natura dell’egemonia americana, che pur esiste.
A mio parere quello americano è un impero, ma di natura talassocratica e ora finanziaria, assai diverso da quelli che l’hanno preceduto, solo in qualche modo simile a quello britannico dell’Era Vittoriana, ma anni luce lontano da ciò che era l’URSS e dal modo che essa aveva di esercitare il potere. Ciò che muove i centri che controllano l’enorme macchina federale (costituita da Pentagono, Dipartimento di Stato, Intelligence e Agenzie varie) è il conseguimento degli interessi di cui essi sono terminali, e la forza è solo uno, e neanche il più usato né, alla prova dei fatti, il più efficace, degli strumenti adoperati per realizzarlo.
La forza del biglietto verde, a tutt’oggi misura e strumento della stragrande maggioranza degli scambi commerciali, e il controllo delle istituzioni finanziarie mondiali (Banca Mondiale, Fondo Monetario, Club di Parigi, etc.), uniti al più forte e pervasivo sistema finanziario del globo, danno a quell’impero una leva enorme.
A ciò s’aggiunge un vantaggio troppo spesso trascurato: possedere il più grande e, piaccia o no, influente sistema di media esistente, capace di determinare il pensiero mainstream e influenzare in modo decisivo le opinioni pubbliche di tutto il mondo. È un soft-power, certo, ma enorme; basti pensare alla copertura che ha dato alle guerre imperialistiche degli Usa, alla creazione del “Nemico”, alla capacità di “vendere” la società americana, basata sulla disuguaglianza e lo sfruttamento più iniquo, come un sogno, alla demonizzazione di tutto ciò che è contrario al sistema Usa e, dunque, ai suoi interessi.
Non è un caso che il sistema statunitense sia il padre della globalizzazione, ciò che gli interessa realmente è che: i traffici marittimi funzionino coerentemente al suo tornaconto (e l’US Navy è ancora la vera padrona dei mari); il dollaro rimanga arbitro di commerci, investimenti e transazioni; il mondo intero sia costretto a sostenere il biglietto verde nei suoi momenti critici, sottoscrivendo in massa i titoli di stato americani per evitare il collasso dell’economia globale (vedi le stratosferiche emissioni di debito Usa, che hanno accollato al mondo intero i danni della crisi originata da Lehman Brothers).
Per il resto, al Deep State americano, vero depositario del potere con buona pace delle Amministrazioni che passano e che esso, al bisogno, sa ingabbiare (vedi le feroci limitazioni imposte a Trump su temi giudicati sensibili, come le relazioni con la Russia), basta che in nessun quadrante del mondo si affermi un vero egemone capace di tenergli testa in quell’area. Certo, molto ci sarebbe da dire sui punti fermi dello Stato Profondo Usa e sul come (non) riesca a ottenere i risultati che si aspetta, ma ci porterebbe troppo lontano.
Concludendo, ritengo che gli Usa siano una potenza certamente imperialista, con una netta vocazione imperiale del suo sistema resa tuttavia sempre più riluttante da una crescente fetta di opinione pubblica interna tagliata fuori dai benefici dell’impero (di qui la base del successo di Trump, riscosso fra i “forgottens” della globalizzazione).
D. 5) La causa palestinese è oggi priva di rilevanza internazionale. Dopo gli insuccessi bellici degli stati arabi contro Israele susseguitisi dal 1948 al 1973, il fallimento politico dell’OLP e il moltiplicarsi degli insediamenti israeliani nei territori occupati, la nascita di uno stato palestinese è, allo stato attuale, da considerarsi un evento assai improbabile. La causa palestinese è stata sempre strumentalizzata dagli stati arabi per loro fini politici, salvo poi espellere o addirittura massacrare i profughi palestinesi al pari d’Israele. Con i nuovi equilibri geopolitici mediorientali e il riconoscimento di Israele da parte di alcuni stati arabi, la causa palestinese è da ritenersi ormai esaurita? Mancando gli alleati di riferimento, quale futuro si prospetta per i palestinesi? L’affermazione di Hezbollah in Libano, quale influenza può esercitare sul destino politico della Palestina?
R. È una domanda che per l’ampiezza necessiterebbe di un’intervista a parte, proverò a sintetizzare anche se mi rendo conto che alcuni temi possano apparire sorprendenti alla luce del pensiero mainstream attuale, focalizzato su ciò che non è e assai distante dalla realtà dei fatti sul campo. In realtà, l’interesse della comunità internazionale per la causa palestinese non è servito a molto, il massimo che ha saputo produrre è stata la beffa degli Accordi di Oslo, ovvero la svendita della Palestina a Israele, con tutti intorno ad applaudire, e la straordinaria ipocrisia del conferimento di due Nobel per quella truffa.
Nei fatti nessuno, in Occidente come nei paesi arabi che pur davano mostra di agitare quella causa, ha preso in seria considerazione la nascita di un vero stato palestinese, era invece la finzione di uno stato-non-stato che serviva a tutti: a Israele, che dinanzi al mondo metteva la pietra tombale su una crisi fastidiosa, senza rinunciare a nessuno dei suoi programmi espansionistici; ad Arafat e la sua cerchia corrotta che, con l’ANP, si vedevano riconoscere da interessati attori esterni un ruolo e una legittimazione che avevano ormai perso fra la loro gente; ai paesi arabi, che spazzavano sotto il tappeto una causa divenuta troppo scomoda.
Tuttavia, se la via indicata da Oslo si è rivelata da subito impraticabile, perché nessuno di chi l’ha sottoscritta era interessato a uno sbocco concreto (anzi, il contrario), l’eventualità di una nascita di un vero stato palestinese, seppur non ancora alle porte, non è mai stata più probabile.
Sgombrati dal tavolo i falsi riferimenti, che mai hanno fornito appoggio vero ai palestinesi, sul campo e fra la gente la causa della Palestina è stata presa in mano da un unico soggetto, la Resistenza Islamica, a cui oggi tutte le formazioni della militanza palestinese fanno riferimento e in cui si riconoscono, sia pur con sensibilità e sfumature diverse, ma seguendo un unico coordinamento. Per chi conosce la realtà di quelle terre, si tratta di un evento straordinario, mai accaduto: oggi, un’unica sala di comando dirige tutti i gruppi della Resistenza a Gaza, nel West Bank e perfino all’interno di Israele.
Alla nuova e crescente unità dei palestinesi, corrisponde uno sfarinamento della società israeliana, sempre più spaccata fra “tribù” (definizione del presidente israeliano Reuven Livlin), componenti separate da interessi, opinioni e visioni dello stato ferocemente contrapposte, causando una lacerazione del tessuto sociale che il passare del tempo rende più radicale e avvelenata.
Laici ashkenaziti, tradizionalisti-nazionalisti sefarditi, ultraortodossi haredim e, da ultimi, gli arabi israeliani, sono inconciliabilmente divisi su tutto. La dimostrazione ultima c’è stata in occasione della crisi del maggio scorso: il successo politico dell’Operazione “Spada di Gerusalemme”, lanciata dalla Resistenza Palestinese, e lo speculare fallimento dell’Operazione “Guardiano delle Mura”, intrapresa da Tsahal, ne sono la dimostrazione (come ammesso senza mezzi termini dalla stampa israeliana).
A maggio Israele ha dovuto interrompere la sua azione militare perché non era in grado di entrare a Gaza, una striscia di appena 365 chilometri quadrati, ma, soprattutto, per l’insurrezione degli arabi israeliani che ha messo fuori controllo le città stesse di Israele e frantumato la sua coesione interna. Illuminante in tal senso è il numero 5 della rivista Limes a ciò dedicata e il lungo editoriale del suo direttore Lucio Caracciolo.
Tra l’altro, non è corretto affermare che ai palestinesi ora manchino alleati di riferimento, è più esatto dire che in passato hanno avuto accanto sciacalli che si sono ingrassati sulle loro sciagure o che, dietro al loro nome, hanno svolto i loro mercimoni (e i risultati si sono visti); oggi la Resistenza Palestinese partecipa a pieno titolo all’Asse della Resistenza, è unita come non mai, ha consapevolezza di sé e della situazione, ha archiviato i dirigenti discutibili e dispone ora di leadership credibili e di un progetto di liberazione come non ha mai avuto.
Che poi alcuni stati arabi abbiano normalizzato le relazioni con Israele non sposta affatto le equazioni geopolitiche, è solo l’emersione delle reali posizioni già esistenti, spinta e pagata in moneta sonante dall’Amministrazione Trump, venduta agli interessi israeliani dietro lauto compenso (in primis al Presidente stesso e al genero Jared Kushner).
In tutto questo, da molti anni Hezbollah ha pazientemente svolto (e svolge tutt’ora) un ruolo centrale di guida, riferimento, supporto ed esempio oltre che di forte deterrenza nei confronti di Israele, che lo considera il nemico più temibile (copyright by Stato Maggiore di Tsahal). È evidente che la deflagrazione di una crisi in Palestina, quando nel West Bank la preparazione della Resistenza ormai unita sarà giudicata sufficiente, vedrà in Hezbollah un attore primario, come lo saranno le altre formazioni dell’Asse della Resistenza dal Golan.
Questi non sono affatto vaneggiamenti o fantapolitica, questo è l’incubo più volte manifestato apertamente dalle Forze Armate israeliane, che ai più alti livelli hanno manifestato seri dubbi sulla capacità di tenuta di Israele, ripreso da una stampa inquieta. Mi rendo conto che questa sia una rappresentazione “eretica” della realtà in Palestina, ma è quella che farebbe qualsiasi analista od opinionista di media accreditati (e indipendenti) della regione, come Al-Mayadeen o Al-Manar.