Olivetti, la fabbrica al servizio dell’umanità
di Marcello Veneziani - 29/09/2025
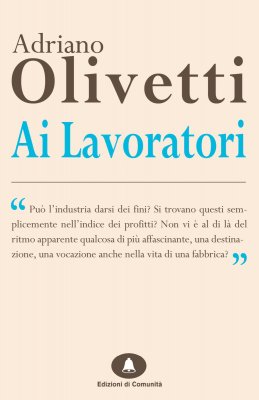
Fonte: Marcello Veneziani
C’è stato un momento nella storia del nostro Paese in cui davvero gli italiani avvertirono di vivere un Miracolo. Certo, il boom economico e demografico di un Paese che aveva fiducia nel futuro, fino alla consacrazione delle Olimpiadi di Roma nel 1960; e nel mezzo, l’irruzione di un’imprenditoria audace, creativa, che faceva del nostro Paese la punta avanzata in tanti ambiti vitali. E tra loro due figure straordinarie, uno dell’impresa pubblica e l’altro privata: Enrico Mattei da una parte e Adriano Olivetti dall’altra. Due giganti, che lanciarono l’Italia nella sfida globale in un ruolo non subalterno ma creativo e decisivo, al punto da impensierire seriamente alcuni partner europei e soprattutto gli Stati Uniti. La politica energetica dell’Eni guidata da Mattei e l’impresa tecnologica della Olivetti, alle prese coi primi computer, a partire dal calcolatore Elea, potevano fare dell’Italia l’avanguardia nel mondo, così come era stato ai tempi di Marconi e poi di Fermi, per non dire d’altri. La morte precoce di Olivetti e la morte improvvisa per un misterioso incidente aereo di Mattei misero fine a quel sogno italiano. E a tanti altri paralleli primati che l’Italia aveva raggiunto nel tempo.
Mattei era uno spregiudicato imprenditore pubblico che pensava e agiva in grande; benché cattolico era capace di usare mezzi anche illeciti per perseguire i suoi scopi, non personali ma nazionali, pubblici. Olivetti era invece un moralista e un idealista, cristiano valdese poi convertito al cattolicesimo, piemontese radicato nel Canavese, socialista e liberale, utopista e tecnocratico. Ma con la sua impresa, ereditata dal padre a Ivrea, restò memorabile per tre ragioni: sul piano imprenditoriale, umanizzò l’azienda come nessuno prima, ponendosi il problema della qualità della vita, la dignità, la bellezza e il ristoro e l’assistenza sociale e sanitaria dei dipendenti. Sul piano civile e politico, progettò la via comunitaria allo sviluppo armonioso delle città e del lavoro. Infine, sul piano della ricerca, dopo aver lanciato la rivoluzionaria lettera 22, la macchina per scrivere più agile e graziosa del mondo che ebbe uno straordinario successo, si cimentò nell’impresa elettronica, dove fu a un passo dal realizzare in Italia il primo vero computer. Poi l’azienda, finì la sua parabola in mano a De Benedetti…
Per comprendere la sua capacità visionaria vi invito a leggere Il mondo che nasce, un libretto pubblicato di recente dalle edizioni di Comunità, da lui fondate, in cui emergono i tratti di questo grande idealista pragmatico dell’industria e apostolo del comunitarismo. Si circondò non solo di operai e tecnici motivati, ma di intellettuali e poeti, da Franco Ferrarotti a Paolo Volponi, da Ignazio Silone a Cesare Musatti, da Franco Fortini a Libero Bigiaretti, da Luciano Gallino a Geno Pampaloni (che gli presentò il poeta veneto Giacomo Noventa, socialista, cattolico e spiritualista come lui). Olivetti si ispirò ad autori come Simone Weil e Jacques Maritain, Immanuel Mounier, Thomas Stearns Eliot e Hannah Arendt.
La fabbrica per lui era un bene comune, non un interesse privato dedito al solo profitto; era un’impresa affacciata sulla comunità, legata al territorio, sensibile alla vita e al benessere dei suoi dipendenti. Il suo progetto figurò un ordine politico delle comunità “per esaltare i migliori, per proteggere i deboli, per sollevare gli ignoranti, per scoprire le vocazioni”. Olivetti più volte ribadì di essere mosso da un solo insegnamento: “saremo condotti da valori spirituali”e la loro “supremazia”. Una nuova spiritualità, un nuovo ordine, una nuova umanità che sintetizzasse al meglio l’anelito cristiano e l’ispirazione socialista ma superando ogni lotta di classe, ogni sistema coercitivo ed egualitario. Al contrario, armonia, solidarietà, libertà, merito e gerarchia furono i suoi cardini. Per Olivetti, assumere in azienda era un dovere etico, un atto di fiducia nel futuro, come mettere al mondo dei figli. Non più muri arcigni ma vetrate nelle fabbriche, finestre in cui entra la luce e si crea simbiosi con la campagna e il mondo esterno; grande attenzione all’architettura industriale, e poi assistenza medica per gli operai, il nido e l’asilo per i loro figli, maternità tutelata e post-gravidanza retribuita a casa, centri di formazione per i figli degli impiegati e degli operai; la mensa, le attività culturali, dal cinema al teatro, dalla musica alla biblioteca, e poi le riviste parallele all’impresa.
La sua era un’Italia in cammino, per dirla con Giacchino Volpe, un’Italia operosa che ha fiducia nel domani e crede possibile realizzare concretamente i suoi sogni. S’imbatté in un muro di diffidenze, incomprensioni e boicottaggi ma non si scoraggiò. Ne Il cammino della comunità, nel 1959, denunciava “allarmanti sintomi premonitori di involuzione”, “la scomparsa quasi totale di una stampa indipendente dai gruppi monopolistici, la decadenza delle istituzioni universitarie, la povertà e il letargo delle associazioni culturali, il monopolio governativo della radio e della televisione”, e poi povertà, sfratti, miserie, che convivono col lusso, i consumi, la crescita delle città e del tenore di vita.
Con il suo ardito spirito d’impresa Olivetti aveva deciso di investire anche a sud, aprendo uno stabilimento a Pozzuoli, dove tenne nel 1955 un memorabile discorso che sembra scritto da un vero meridionalista che ama il sud e non è accecato dall’ideologia progressista e irreligiosa: “Abbiamo lasciata, in poco più di una generazione, una millenaria civiltà di contadini e di pescatori. Per questa civiltà, che è ancora la civiltà presente nel Mezzogiorno, l’illuminazione di Dio era reale e importante, la famiglia, gli amici, i parenti, i vicini, erano importanti; gli alberi, la terra, il sole, il mare, le stelle erano importanti. L’uomo operava con le sue mani, esercitando i suoi muscoli, traendo direttamente dalla terra e dal mare i mezzi di vita. Lo sconvolgimento di due guerre ha spinto l’uomo definitivamente verso l’industria e l’urbanesimo. Ha strappato il contadino dalla terra e lo ha racchiuso nelle fabbriche, spinto non solo dall’indigenza e dalla miseria, ma dall’ansia di una cultura che una falsa civiltà aveva confinato nelle metropoli, negandola alle campagne del sud”. E aggiungeva che la conquista per i beni materiali aveva corrotto l’uomo vero, figlio di Dio, che amava la natura, la terra, era legato al cosmo e alle sue forze misteriose, alla comunità e al senso del sacro. Rispetto all’uomo del nord, diceva il piemontese Olivetti, l’uomo del sud ha ancora viva l’impronta della civiltà della terra, col suo “intenso calore umano”. E si appellava alla Provvidenza divina, alla Natura e alla Bellezza e infine auspicava che nascesse “la festa dell’amicizia tra Nord e Sud”. Parole così calorose, solidali e veraci non le ho mai sentite da un meridionalista; una carica di umanità e di amore per il sud, la sua civiltà e la sua tradizione, anche quello più arcaico e vituperato.
Morì troppo presto, Olivetti, stroncato su un treno quando aveva 59 anni. Giganti come lui servirono alla crescita dell’Italia; giganti come lui servirebbero alla sua rinascita.
