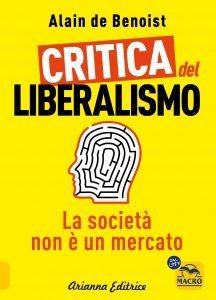Per Rousseau, la ragione non può fare a meno del sostegno della passione per realizzare la virtù
di Alain de Benoist - 30/07/2025
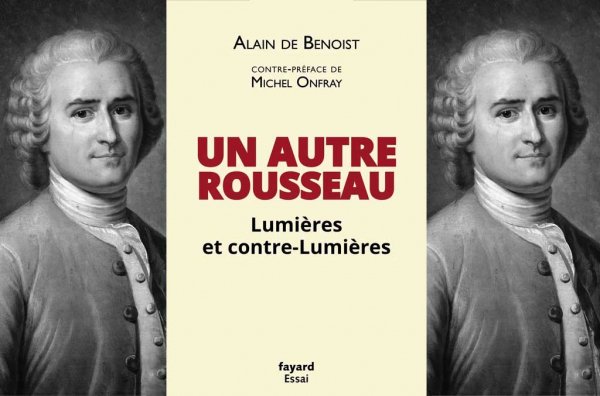
Fonte: GRECE Italia
In questa intervista alla Rivista Monde et Vie, Alain de Benoist rivisita Jean-Jacques Rousseau, spesso ridotto alla figura del filosofo dell’Illuminismo. Lungi dall’essere un progressista, Rousseau fu un critico acerrimo della modernità, sostenendo la religione civile e il patriottismo virtuoso di fronte all’universalismo e agli eccessi del razionalismo.
MONDE&VIE. Lei sottolinea il ruolo del suo eroe come grande oppositore dell’Illuminismo francese, che per la maggior parte era decisamente ateo (da Diderot a D’Holbach). Lui, invece, sosteneva che bisognava allontanarsi dalle grandi città e riscoprire Dio nella natura. Voltaire, che non era del tutto ateo, non sopportava questo Rousseau…
ALAIN DE BENOIST: Lo definì addirittura il «Giuda della confraternita»! Voltaire rappresentava tutto ciò che Rousseau detestava: la civiltà al massimo, opposta alla vera cultura, il razionalismo pretenzioso, il primato dell’artificio, la preoccupazione per le apparenze, il gusto della derisione, l’ironia che si crede superiore e l’empietà. Rousseau, da parte sua, condannava l’ateismo, colpevole ai suoi occhi di favorire la disarmonia sociale, e lo riteneva invece una religione che in qualche modo sacralizzava il patriottismo.
I commentatori sono sempre stati molto discordi su cosa Rousseau intendesse per «religione civile»: alcuni vi vedono l’istituzione di una sorta di teismo di Stato, altri semplicemente un mezzo per mettere la religione al servizio della politica (questa è l’ipotesi più spesso adottata) o per neutralizzare politicamente gli effetti deleteri di un ‘fanatismo’ che storicamente ha assunto la forma della «religione del prete», altri ancora la volontà di riconoscere che la religione è una «forza attiva» di cui non si può fare a meno. Quel che è certo è che Rousseau, quando parlava di istituire una religione dei cittadini, non sosteneva affatto una «chiesa nazionale» nello spirito del gallicanesimo o della Chiesa anglicana, una formula che gli piaceva ma che considerava irrealistica. Piuttosto, egli ritiene che la ragione non possa fare a meno del sostegno della passione per realizzare la virtù. La religione motiva e può anche motivare il patriottismo. Per Rousseau, la fede nell’aldilà è un prerequisito per la virtù del cittadino: nessuno Stato potrebbe chiedere ai suoi cittadini di sacrificare la propria vita per difendere la patria se non credessero in un aldilà. La necessaria autonomia della politica non implica quindi che essa debba mettere da parte la religione. Questo è quanto spiega diffusamente nel capitolo 8 del Libro IV del Contratto sociale, e anche nei suoi testi sulla Polonia e sulla Corsica, dove spiega che i cittadini saranno tanto più patriottici quanto più saranno stati educati a considerare la loro patria come degna di culto. Questa affermazione prende chiaramente a modello la città antica.
Ciò che Rousseau trovava problematico era, in primo luogo, l’universalismo cristiano, che poteva essere un pretesto per cancellare le frontiere (essendo universale fin dall’inizio, l’amore cristiano difficilmente può formare una comunità), e in secondo luogo, il fatto che la religione cristiana si occupa principalmente delle “cose del cielo”: «Lungi dal legare i cuori dei cittadini allo Stato», scriveva, «li distacca da esso come da tutte le cose della terra: non conosco nulla di più contrario allo spirito sociale». Infine, Rousseau era preoccupato per le conseguenze dell’esistenza di un
potere religioso separato da quello politico: promuovere l’autorità sia della Chiesa che del Principe avrebbe significato creare una situazione in cui entrambi avrebbero potuto solo competere tra loro ed entrare in conflitto. Rousseau osserva che il risultato è stato un «perpetuo conflitto di giurisdizione che ha reso impossibile la buona politica negli Stati cristiani». La sua critica è quindi essenzialmente politica.
MONDE&VIE. Molti pensatori politici hanno deciso da tempo di lasciare Jean-Jacques Rousseau nella loro biblioteca, tanto numerosi sono i temi su cui interviene il vicario savoiardo, tanto attuali e, visti dal suo punto di vista, spesso inquietanti. E voi, portando alla luce l’immenso pensatore politico che era, fate il contrario di questi stanchi ricercatori. Cosa trova in Rousseau, il filosofo politico di oggi, che non si possa trovare altrove?
ALAIN DE BENOIST: Sono interessato a Rousseau non perché trovo in lui cose che non «trovo altrove», ma perché come storico delle idee non sono d’accordo con il modo in cui viene spesso rappresentato. In parole povere, Rousseau, lungi dall’essere un filosofo illuminista, è a mio avviso un anti-illuminista. Certo, la sua critica all’Illuminismo non è quella di Joseph de Maistre o di Donoso Cortés, ma basta leggerlo per capire che è ancora attuale.
Innanzitutto, Rousseau non era un progressista. Arriva a dire che «l’avversione per le novità è sempre fondata», ma è ossessionato dalla decadenza che gli sembra di vedere intorno a sé. Lungi dall’annunciare un futuro roseo, è un ammiratore incondizionato dell’antichità greca e romana: «
Quando si legge la storia antica, ci si sente trasportati in un altro universo e tra altri esseri». I «politici dell’antichità», aggiunge, «parlavano senza posa di costumi e di virtù; i nostri non parlano che di commercio e di denaro». Ecco perché era in forte disaccordo con i fisiocratici, che stavano gettando le basi dell’economia liberale classica che domina ancora oggi. Ed è anche il motivo per cui sosteneva costantemente la subordinazione dell’economia alla politica. Molto prima di Maurras, sosteneva la necessità di «privilegiare la politica». Mentre Condorcet affermava che una buona Costituzione è valida in ogni momento e in ogni luogo, egli riteneva che la Costituzione di ogni popolo dovesse essere redatta in base alla specificità di quel popolo. Gli esempi potrebbero essere molteplici. Sto solo sfiorando la superficie di un argomento che sviluppo a lungo nel mio libro.
MONDE&VIE. Avete appena pubblicato un numero della vostra rivista annuale, «Nouvelle École», dedicato a Karl Marx. Il parallelo tra Rousseau e Marx è allettante. Del resto, nelle sue pagine troviamo questa breve frase su Jean-Jacques: «Si potrebbe tracciare un parallelo con Marx, che generazioni di uomini di destra hanno condannato senza averlo mai letto» (p. 184). Si potrebbe dire che c’è il Marx letto da Lenin e il Marx letto in modo molto positivo dal caro cattolico Michel Henry… E c’è il Rousseau letto da Robespierre e il Rousseau letto da Louis de Bonald, quel controrivoluzionario che, come lei dice nel suo libro, ha un debito nei confronti di Rousseau. O ancora il Rousseau letto, alle origini del romanticismo francese, da Châteaubriand, che rinuncia a criticarlo.
ALAIN DE BENOIST: Il confronto con il «Marx letto da Lenin» e il «Marx letto positivamente dal cattolicissimo Michel Henry» è assolutamente corretto. Nel suo grande libro su Marx, Michel Henry aggiunge che il marxismo potrebbe essere definito come l’insieme dei fraintendimenti che sono stati scritti su Marx. «Non sono mai stato un marxista», diceva Marx. Dobbiamo distinguere tra Marx e il marxismo, e allo stesso tempo vedere che non esiste «un» marxismo, ma un’intera gamma di marxismi che non possono essere ridotti a un’unica entità. Quanto al «marxismo-leninismo», per non parlare del «materialismo dialettico», pura invenzione di Lenin nel 1908, non è altro che una falsificazione. «Il pensiero di Marx non fa parte della storia del marxismo», ricordava il filosofo italiano Costanzo Preve. Potremmo altrettanto facilmente dire che il pensiero di Rousseau non fa parte della storia del rousseauismo…
Un altro punto in comune tra Marx e Rousseau è che sono senza dubbio i due filosofi che, nel corso della storia, sono stati più diffamati, denigrati e messi alla gogna. E con metodi quasi identici. Sono stati oggetto di numerosi attacchi ad hominem e, soprattutto, sono stati ritenuti responsabili di tutto. Rousseau sarebbe il padre del Terrore, Marx l’antenato del Gulag. È un modo di vedere le cose al tempo stesso anacronistico e teleologico. La verità è che ignoriamo completamente come entrambi avrebbero reagito allo spettacolo di ciò di cui si è voluto così generosamente attribuire loro la paternità. Il fatto che Robespierre si sia richiamato a Rousseau, sia durante la rivoluzione che quando le ceneri di Rousseau furono trasferite al Pantheon, non ci dice nulla sul valore di verità di questa rivendicazione. Al contrario, il giurista Joseph de Bernardi (1751-1824), arrestato nel 1793 per le sue opinioni monarchiche, si diceva convinto «che l’anima sensibile e virtuosa di Rousseau, che, si dice, non avrebbe voluto una Rivoluzione macchiata da una sola goccia di sangue, avrebbe versato lacrime amare il 2 settembre, la legge dei sospetti o degli ostaggi, le proscrizioni private o di massa e tutti gli omicidi arbitrari che hanno devastato o insanguinato il suolo della Francia».
Ancora una volta, rileggiamo Rousseau, che aggiunge che «in uno stato già consolidato, è preferibile evitare innovazioni legislative, poiché i benefici di nuove leggi sono spesso meno certi dei rischi che comportano»? Lui che, opponendo fin dall’inizio un rifiuto categorico ai rivoluzionari che si sarebbero abusivamente richiamati a lui, scriveva di sé stesso: «La gente si è ostinata a vedere un promotore di sconvolgimenti e di disordini nell’uomo del mondo che ha il più vero rispetto per le leggi e le costituzioni nazionali, e che ha la più grande avversione per le rivoluzioni, e per i leziosi di ogni genere che lo ripagano bene» (Rousseau giudice di Jean-Jacques). La radicalità di Rousseau non era politica, ma filosofica.
MONDE&VIE. La particolarità del suo libro su Rousseau è che è anche un libro sulle persone di destra che, per oltre duecento anni, hanno letto Le Promeneur solitaire. E sono in parte responsabili della figura storica di Jean-Jacques, spesso molto lontana dalla persona reale… Tra i sostenitori, non c’è da stupirsi, ci sono Barrès, che parla bene di Rousseau nei suoi «Carnets», Péguy e Victor Delbos, cattolico e kantiano, che ha definito Rousseau «il Barrès del XVIII secolo». Tra gli oppositori inconciliabili: Maurras, Maritain e Mauriac, forse i «cattolici dell’Ordine»?
ALAIN DE BENOIST: Maurras, Maritain e Mauriac possono senza dubbio essere definiti dei «cattolici dell’Ordine». Ma Barrès e Péguy sostenevano il disordine? Nel capitolo abbastanza corposo che ho dedicato all’antirousseauismo della destra francese, ho osservato che la maggior parte degli avversari di Rousseau lo giudicavano sulla base di formule preconfezionate e ripetute come mantra: «lo stato di natura», il «contratto sociale», «l’uomo naturalmente buono corrotto dalla società», la «volontà generale», e così via. Ad un esame più attento, appare chiaro che lo «stato di natura» a cui fa riferimento Rousseau non è altro che un’ipotesi sperimentale che ci permette di esaminare nuovamente il rapporto tra libertà e obbligo sociale e che il suo «contratto sociale», che non dà origine alla società attraverso la scelta razionale degli individui, è di natura molto diversa dal contratto sociale di Locke, che si basa sulla ricerca dell’interesse o dell’utilità degli agenti, e dal contratto sociale di Hobbes, che si basa sul desiderio di sfuggire alla lotta di tutti contro tutti. Contrariamente a quanto si crede, egli non auspica un «ritorno allo stato di natura». L’uguaglianza di cui parla è un’uguaglianza strettamente politica. Quanto alla «bontà naturale», per lui non è una qualità ma una propensione, che si riferisce soprattutto al legame sociale, alla capacità dell’uomo di essere felice senza causare infelicità agli altri.
In un noto passo, Rousseau parla inequivocabilmente dello stato di natura dell’uomo come di «uno stato che non esiste più, che forse non è mai esistito, che probabilmente non esisterà mai». Ammettendo che lo stato di natura «potrebbe non essere mai esistito», egli chiarisce di basare la sua argomentazione su un’ipotesi utile, non su un fatto provato. La maggior parte delle critiche mosse a Rousseau sullo stato di natura crollano di per sé non appena ci si rende conto che per lui lo stato di natura non è un periodo storico, ma un modello teorico.
MONDE&VIE. Non è sorpreso di trovare tra gli oppositori di Rousseau anche Proudhon ed Edouard Berth, al quale mi pare abbia dedicato un libro, «Le socialisme héroïque»? In realtà, anche se ci sono altre letture, non basta essere di sinistra per essere rousseauisti, così come non basta essere di destra per essere antirousseauisti. Né a destra né a sinistra, cosa resta della politica di Rousseau? Quali principi metapolitici? L’ecologia?
ALAIN DE BENOIST: L’anti-rousseauismo di Proudhon e di Edouard Berth non è altro che la conseguenza della loro ostilità nei confronti del romanticismo. Si noti tuttavia che Georges Sorel, che Berth ammirava ancora più di Proudhon, non condivideva questa opinione. Nel 1907 rimproverò addirittura a Jules Lemaître di non riconoscere «il ruolo del genio che ha lasciato un’impronta più profonda nella nostra letteratura dopo Corneille». «Jean-Jacques, aggiungeva, non è più responsabile di imitazioni inette di quanto Raffaello sia responsabile dello stile accademico».
Descrivendo Rousseau come un «conservatore rivoluzionario», intendevo dire che era un moderno antimodernista. Questo lo distingue ovviamente dai controrivoluzionari e capisco bene perché alcuni non sopportino il fatto che abbia difeso la sovranità del popolo. Rousseau non era ovviamente un sostenitore dell’Ancien Régime. Era un democratico, ma un democratico antiliberale, che ha preannunciato l’ascesa di quella che oggi chiamiamo «democrazia illiberale». La sua grande ossessione era fare in modo che, nella società, gli interessi dei singoli, dei partiti e delle fazioni non prevalessero sull’interesse generale e sul bene comune. Ecco perché parla incessantemente di nazione, virtù civica e della patria. Certo, ha una concezione moderna della patria (penso ovviamente al grande libro di Jean de Viguerie su Les deux patries), ma è anche questo che lo rende così attuale. Il dibattito da lui lanciato se un uomo debba essere prima un uomo o un cittadino risuona ancora oggi con singolare forza. La risposta di Rousseau è inequivocabile: «Dovete scegliere se fare un uomo o un cittadino, perché non potete fare entrambi allo stesso tempo». Per Rousseau, la libertà individuale non è una questione privata, ma si afferma nella sfera pubblica, dove l’individuo diventa cittadino. Ciò che conta non sono i diritti dell’uomo, ma i diritti del cittadino. Permettetemi di concludere con questa citazione: «Ogni società parziale, quando è intimamente unita, si aliena dalla grande. Ogni patriota è rigido cogli stranieri: essi non sono che uomini e non sono niente agli occhi suoi. Questo inconveniente è inevitabile, ma è debole. L’essenziale è di essere buoni verso quelli coi quali viviamo […] Guardatevi da questi cosmopoliti che si spingono oltre nei loro libri per cercare doveri che disdegnano di compiere intorno a loro».
[Alain de Benoist, Éléments, «Pour Rousseau, la raison ne peut se passer du renfort de la passion pour faire émerger la vertu», 30 luglio 2025.]
Traduzione a cura di Piero della Roccella Sorelli.
Informazioni per richiedere il libro e la Rivista Éléments:
www.revue-elements.com