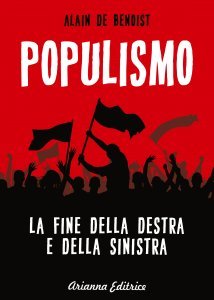Populismo primordiale
di Luca Leonello Rimbotti - 06/07/2025

Fonte: Italicum
Da quando la “sinistra” mondiale ha abbandonato se stessa per diventare malamente liberale, alcune parole, alcuni concetti, sono stati subito svalutati, svuotati di senso, rovesciati e infamati. Noi ci ribelliamo a questa imposizione dei linguaggi omologati dal potere e dall’egemonia degli incolti e restituiamo significato al significante. E prendiamo la parola “populismo”, tra le più svergognate dal mainstream a partito unico mondialista, per quello che è, una nobile asserzione di dominio sociale attraverso volontà politica ferma, carìsma dell’avanguardia, e alto tasso di fidelizzazione del seguito.
Fu infatti subito faccenda di élites nella Russia zarista della seconda metà del secolo XIX, nell’epoca e nel luogo in cui il termine modernamente inteso nacque diffusamente, in mezzo alle tensioni impressioniste e tremende che si offrivano a quel mondo, al fine di uscire tutto ad un tratto dall’immobilismo post-feudale per entrare nella modernità, senza tappe intermedie.
Le sigle politiche russe che, come Volontà del Popolo, oppure Terra e Libertà, veicolarono lavoglia di rivolta contro l’ottusità dell’aristocrazia zarista, impegnarono fior di intellettuali e militanti che, da Georgj Plechanov, operaista e proto-marxista, a Sergej Necaev, punta di lancia del fanatismo terrorista, fino a Aleksandr Herzen, padre filosofico dell’etica rivoluzionaria e del socialismo slavo rielaborato con criteri hegeliani, e fino anche a quel Lev Aleksandrovic Tichomirov, che racchiuse tutte le aporie e le contraddizioni del sovversivismo non solo russo, ma in genere europeo, con quel suo iniziale oltranzismo antimonarchico, presto trasformatosi nel ravvedimento, nell’abiura dell’esule che si inginocchia sulla tomba dello zar. C’era, in un personaggio del genere, tutta la sfasatura di un ideale – la nobiltà del popolo, il desiderio di riscatto sociale, l’annuncio di un’epoca nuova da parte di un’aristocrazia politica carismatica – che ondeggiava pericolosamente tra l’istinto regicida e il pentimento emotivo, ciò che per lunghi decenni impedì alla genialità politica europea di presentarsi con tutti i crismi della rivoluzione, arrestandosi troppo spesso sulla soglia dell’insurrezione. Del resto, da noi in Italia, dove il populismo lo potevi trovare persino tra i monarchici e i legittimisti, di questi ondeggiamenti se ne ebbero, da Croce a Labriola a Bombacci, e la terra di nessuno tra i vari schieramenti venne sovente attraversata, senza neppure – secondo il tipico costume italiano – l’aura del tragico travaglio interiore.
Dire populismo significa dire radicalismo in favore del popolo. Si tratta dell’ideologia più semplice e più elementare che mai sia stata asseverata, è vino schietto e non edulcorato dal raziocinio delle moderne carte costituzionali vergate a tavolino alla luce fioca dell’illuminismo, non abbisogna di lemmi dialettici, è essa stessa un programma politico, ben aperto e comprensibile, visibile, chiarissimo, racchiuso in un’unica parola.
In questo, il populismo è cosa arcaica, se ne trovano tracce sostanziose nella politica di avanzamento sociale e di progresso economico che veniva intrapresa nella Grecia antica precisamente dalla tirannia, un termine che in origine non era per nulla negativo (il tyrannos era semplicemente il “signore”), rimandando, al contrario, al tipo di governo che, rovesciando lo status quo ante tramite un rivoluzionamento, svolge politica decisionista, favorevole al benessere della maggioranza, anzi, della totalità. Dai Trenta a Pisistrato, la storia riporta il programma del populismo al suo sorgere: difesa della comunità dalle insidie esterne, politica sociale di grande avanzamento, attraversovasti programmi di opere pubbliche, incentivazione della piccola proprietà, aiuti ai poveri, contrasto alla ricchezza dei grandi proprietari, mecenatismo (l’Acropoli ateniese, per dire, è un manufatto della “tirannia”) e così via, ed ivi compresa una franca pratica di imperialismo sociale, di insediamento, di colonizzazione della terra, di lavoro e commercio. In ogni caso, nel dare fondo a queste intraprese, si assolveva ad una vera e propria politica sociale in solido, nel senso di “dare lavoro al popolo” concretamente, coinvolgerlo, redimerlo. Si direbbe tutto questo un vero e proprio socialismo nazionale dell’antichità. E così fu, solo a leggere sul tema i maggiori storici grecisti, dal Finley aMarco Giuman, a Martin Nilsson. Il fatto che Erodoto abbia lasciato scritto che il tiranno Pisistrato «governò Atene in base alle istituzioni vigenti e l’amministrò saggiamente», per noi è più che sufficiente.
In quel tempo felice degli inizi aurorali, l’idea di democrazia e quella di populismo – che sono due parole etimologicamente identiche ed indistinguibili – combaciavano alla perfezione, né era da prevedersi l’accaparramento dell’ideale democratico, da parte di quelle minoranze di allucinati giacobini che si innamorarono, ad esempio, della libertà e dell’uguaglianza spartane, scambiandole per la loro utopia letteraria, e dimenticandone – tragicamente – la valenza storica. Quelle due sante parole racchiudevanoentrambe precisi significati di oltranzismo: Stato gerarchico e razziale, socialità castale innestata sulla segregazione schiavile, imperialismo di conquista ed etica guerriera. Cosa avesse a che spartire una tale realtà democratico-populista al suo apogeo, con gli illusionismi egualitari degli illuministi, la storia non ha saputo dirci.
Ma poi, la sequela degli imperatori romani, cos’altro fu, nei suoi esemplari migliori, compresi i grandissimi, un Traiano, un Adriano, un Marco Aurelio, e fino a un Costantino, se non superbi, magnifici capi populisti? E non furono perfettamente populisti un Mazzini, un Garibaldi, i fondatori delle varie patrie nazionali, un Cid, una Giovanna d’Arco, un Bolìvar, fino ai grandi ribelli, un Cola di Rienzo, un Pugacëv, un Andreas Hofer? Fu Ghino di Tacco un populista, e lo fu Napoleone? Si potrebbe andare avanti per molto, inglobando, probabilmente, l’intera storia mondiale. Certi giacobini, invidiosi di questi protagonismi, s’inventarono poi la taccia di demagogico, da affibbiare a chiunque ricevesse qualunque forma di consenso plebiscitario. Ma la storia va molto oltre i nominalismi dell’impotenza.
Cosa dunque questa formula così semplice e scarna, racchiudibile in un unico termine, volesse e voglia dire politicamente, direi chenon abbisogna di teorici o di gran dispiego di sofismi. Il popolo è argomento immediato, rappresenta una realtà e un mitema viventi. Il populismo sarà dunque l’andare verso il popolo, l’essere popolo, il risvegliare il popolo.
Il populismo è insomma una tensione, un indirizzo generale, un protendersi verso un unico obiettivo: tutto quello che un movimento politico, un governo, un capo carismatico o un direttorio decisionista fanno e intraprendono non solo nel nome del popolo – ciò che non basta ed è troppo generico – ma a favore materiale e morale del popolo, della sua mobilitazione e della sua esaltazione religioso-liturgica, tutto quello che serva, nella pratica, per promuovere un popolo, la sua identità, la sua civiltà tradizionale, proteggendone lo status sociale così come le proiezioni verso il futuro, secondo un progetto di destino comune, tutto ciò rappresenta la categoria populismo, e basta pienamente a se stesso.
A giusta ragione, è stato scritto che «il populismo è servitore di molti padroni», poiché, volta a volta, è sembrato appartenere a situazioni variegate, a idee diverse, forse anche opposte tra loro. Ma questo non è il male, è il bene di un’idea. Il vivere l’ossimoro di apparenze in contrasto, nasconde, per la verità, una natura potente, agitata da benefici contrasti, che si arricchisce dalle contraddizioni, dato che la coerenza, l’armonia dell’organico l’idea molteplice la reca nel significato profondo e di base, e non nelle mutevoli occasionali apparenze. Alle volte, infatti, nulla di più reazionario e passatista di una rivoluzione, e nulla di più innovativo e vitalistico di una cocciuta conservazione. Il populismo – quel nobile esporsi che ad esempio un Pétain chiamava spada e insieme scudo del popolo – vive di opposti, e li ingloba nella più straordinaria miscellanea di suoni ben temperati.
Ma il populismo – lamenta dal suo angoloombroso il politologo razionalista, questo pigro animale, sempre al traino e mai alla guida degli avvenimenti – è indicatore troppo vago, letterario, ci vogliono concetti scientifici, parametri, tabelle, misurazioni geometriche. Noi obbiettiamo che si riconosce la forza del politico per l’appunto nella sua vaghezza, nell’ampia possibilità di inveramento in situazioni e corpi diversi, e così facendo si riesce meglio dell’arido scientista a carpirne i segni e i valori.
Idea troppo vaga, il populismo? E, allora, l’amore, la libertà, il bene, il male? Gli universalismi – in cui eccellono i liberali e i loro compagni di strada progressisti – non hanno i mezzi per capire. La vita ragiona per relativismi: la mia libertà può essere la schiavitù di un altro, il mio amore può essere l’odio altrui… Dice: «In momenti differenti e in differenti luoghi il populismo è stato una forza di cambiamento, una forza di opposizione al cambiamento, una creatura della politica progressista della sinistra, un rifugio per la difesa moderata dello status quo e un adepto dell’estrema destra»[1]. Per l’appunto. In questo, il populismo è un preciso richiamo, una chiamata a raccolta.
Poiché lo aveva detto uno come Isaiah Berlin, che non a caso conosceva bene le fonti del Romanticismo politico europeo (che fu l’uteroculturale da cui nacque il moderno populismo) e che non esitò a rimarcare che il primo requisito di una forma qualunque di populismo è l’impegno per la Gemeinschaft: a questo punto, non basterebbe aggiungere altro, potremmo chiudere il discorso, e il termine, da vago, per chiunque non sia un banale radical-chic impreparato a cogliere la tremenda semplicità delle cose vere, da vago diventa preciso, da indeterminato diviene determinatissimo.
In ogni caso, si è detto, e giustamente, che «il populismo, inteso nel suo senso più ampio, è una reazione al liberalismo»: esattamente questo, è il grande significato di quella formula, che può comprendere tanto lo scamiciato popolano perònista, quanto magari il sussiegoso imprenditore/politico borghese. Il fatto, davvero decisivo, nel suo rapporto oppositivo con l’idea populista, è stato notato, ed è il seguente: «Il liberalismo ha una visione del mondo incentrata sugli individui»[2]. Nato nemico dello Stato, e con in più la pretesa di erigere uno Stato con il consenso della gente attraverso il magico ricorso alla terminologia “democratica”, il liberalismo si capisce bene perché sia nemico del populismo, lo diffami, e soprattutto lo tema.
Si è detto altrove che il populismo, questa “deprecabile” insorgenza di un’identità di base per solito ben rappresentata da una volontà politica di vertice (ciò che alla mentalità bolscevica post-marxista, adusa a minoranze padrone dei cervelli e indispettita dalla presenza di contro-movimenti, non può piacere), si è detto dunque che il populismo sia una «malattia senile della democrazia, quando i tempi della politica sembrano essere finiti»[3]. Direi invece, e proprio all’incontrario, che la “democrazia” intesa secondo il modello liberale, lobbistico e oligarchico tipico dell’anglo-zona, sia per l’appunto la “malattia senile” del populismo, quella macchina politica di protezione del popolo che sappiamo essere in attività dalle origini dello Stato europeo, spesso con ottimi fatturati di politica sociale.
La quadratura del cerchio, difatti, se non rimandasse per assonanza a sgradevoli e parodistiche realizzazioni dell’epoca moderna, sarebbe l’abbinamento concettuale del popolo con l’idea di popolo e con la politica ad esso dedicata. Per cui “democrazia popolare”, questa splendida tautologia, costituirebbe l’apice del politico virtuoso, quello che concepisce il potere – come faceva il vecchio Federico II re di Prussia – essenzialmente come servizio reso al popolo.
E possiamo ben dire che la cultura, tutta la grande cultura, è al tempo stesso cultura popolare, il che significa non solo espressa dal popolo o per il popolo, ma anche – e soprattutto - come religioso, sacrale rispecchiamento dell’origine essenziale in tutto ciò che è popolo. Popolo è famiglia, tribù, etnia e sangue genealogico trasmesso dalle generazioni. L’Ur-Volk, di cui parlava Fichte l’idealista. Grande epitome di tutto questo è il concetto di Essere come populismo, cioè populismo dell’Essere. Alla maniera di Heidegger, il raffinato filosofo della zolla e dell’Esserci comunitario. La profondità e la grandezza di questi richiami rimontano a ciò che i romani antichi, già per loro conto, percepivano con esattezza istintiva: esservi una nobiltà nella plebe, il patriziato plebeo essendo una mimesis per dire che tutto il popolo non è vile popolazione, ma mistero sacro dell’appartenere.
Scriveva parecchi anni fa Nicolao Merker di queste cose, proprio mettendo in relazione l’alta scuola identitaria del pensiero di Heidegger, così elaborato e còlto, con la naturalità semplice degli atavismi, che spontanei e veridici, privi della necessità di vedersi appiccicata una teologia oppure una dottrina, sgorgano dai corpi e dalle anime di quanti si riconoscono nella comunanza perenne. E, in riferimento al dire del pensatore-contadino, Merker ha lasciato scritto frasi da scolpire in un manifesto del populismo riconsacrato nella modernità. E diceva parole di rifondazione identitaria, ciò che esattamente è il populismo come filosofia dell’essere e ideologia del divenire:
In ogni momento – questo è il succo di Essere e tempo – l’individuo deve (con lotta, impegno nell’azione, sfida alla morte, intuizione del vero destino, o come altro richiedeva il vitalismo irrazionalista rafforzato dal combattentismo del dopoguerra) riguadagnare faticosamente una propria Esistenza genuina, il proprio “Esserci” autentico insidiato dal trovarsi egli “gettato nel mondo”. Ovvero nell’alienante mondo moderno della falsa cultura tecnico-scientifica, nel mondo delle apparenze e dell’esistenza anonima e impersonale della massa. L’individuo salva il suo vero Sé soltanto se riaggancia il suo Esserci esistenziale al primordiale, antichissimo Essere dove apparenza e sostanza erano metafisicamente unificati, e che è la filosofia greca antica ad aver intuito.[4]