Spezzati in due
di Lorenzo Merlo - 07/09/2025
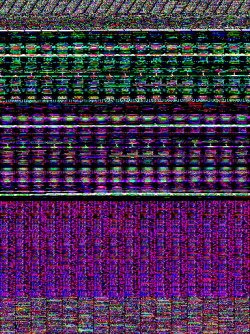
Fonte: Lorenzo Merlo
Chi troverà nelle righe che seguono un’informazione o uno spunto d’attenzione nei confronti di una centralità della vita finora passata sotto silenzio, si sentirà forse motivato a coltivare quella vena. A costoro va fatto presente che partendo da questo singolo argomento si troveranno ad avere a che fare con l’infinito.
Punto primo
Diversamente dalle indicazioni intellettuali forniteci da un sapere acquisito, sempre ideologiche quando non dogmatiche, quindi dozzinali, impersonali e uniformatrici, quelle che ci offre il sentire sono di schiatta energetica, corrispondono sempre a noi, alla nostra natura profonda, provengono dall’interno, non sono acquisite, non sono trasmissibili.
Si può dire siano maestre, in quanto sempre rivelatrici di qualcosa di buono all’evoluzione di noi stessi, una verità che i saperi analitici e quelli acquisiti non possono far emergere.
Sono una guida, alla quale possiamo anche rinunciare, purché consapevolmente e non in quanto sopraffatti da dati, codici e consuetudini imparati in famiglia, in società, a scuola.
Nonostante il potere formativo ed educativo che una cultura fondata sulla conoscenza attraverso il sentire offrirebbe a noi, alla politica e alla società, di essa non si discute, e non viene praticata se non in isolati momenti privati, atolli senza le doti per divenire continenti.
Quel potere formativo ed educativo avviene nella realizzazione di persone compiute, ovvero centrate: da un lato, consapevoli di sé stesse, dei propri limiti, talenti, carenze, motivazioni, sentimenti ed emozioni e, dall’altro, all’altezza di ascoltare e osservare, per riconoscere e, quindi, legittimare le caratteristiche del prossimo e le identicità con sé stesse. Nuovo humus che stravolge le relazioni prima basate sull’affermazione di sé. Una specie di ruspa che avanza cieca nel campo delle relazioni.
Uno spirito intessuto con le trame e gli orditi del sentire tende a realizzare il massimo rischio di una vita piena, che vuol dire anche in salute, in quanto attraverso il sentire – attraverso la meditazione e la contemplazione che questo implica – ognuno può riconoscere le vere cause, dinamiche e responsabilità che abbiamo in merito a come ci va la vita, all’insorgenza di fastidi, malattie e sofferenze. Rispettare il proprio sentire permette di distinguere i condizionamenti, di assistere alle loro forze su noi e sulle nostre relazioni.
Tende perciò a poter sfruttare al meglio l’energia che lo attraversa, anche nei momenti e periodi difficili. Tendenza, invece, soffocata per chi dedica l’energia a vittimistici sentimenti e richieste, se non pretese, di aiuto.
Punto secondo
Sappiamo mediamente ed eufemisticamente poco del sentire e del suo potere. La politica e la cultura non solo non coltivano il tema ma, a causa dei dogmi che stanno loro a cuore (competizione, guadagno, individualismo, sopraffazione legittimata, ipocrisia come furbizia, vanità come virtù) ne appannano la diffusione.
Del sentire, come di qualunque momento umano, va ricordato che si tratta di un’attenzione allenabile. Motivazione personale e ambiente famigliare e/o sociale permettono e favoriscono l’avvio e la coltivazione della ricerca.
Ma come fare? Come intraprendere la modalità del sentire? Come arrivare a riconoscere nell’assenza del sentire un vuoto esistenziale fondamentale?
L’esperienza non è trasmissibile, ricreare è necessario, e quindi non solo non basta, ma è assurdo credere che le istruzioni forniteci da una descrizione/narrazione/teoria possano condurci dall’avere saperi all’essere conoscenza o dal sapere posseduto alla conoscenza incarnata. Il percorso individuale, ricreativo, non è sostituibile e ogni imitazione non può che contenere inconvenienti e delusioni.
Punto terzo (che sarebbe il primo)
Il corpo. Per fare proprio il contenuto del sentire abbiamo a disposizione il corpo. Un punto di partenza in quanto esso costantemente ci informa di noi stessi, e noi, altrettanto costantemente, preferendo dottrine e inseguendo idee, non sentiamo la sua voce.
Di seguito, un esempio di informazione attraverso il corpo, e contemporaneamente di descrizione estranea al sentire, rispettosa soltanto del formale.
Al buio o a occhi chiusi, seduti su una sedia, ci chiedono di alzarci e di descrivere come abbiamo realizzato la consegna.
Descrizione formale:
– Ho disteso le gambe.
– Ma così spingi avanti i piedi oppure ti ribalti indietro. Non è vero?
– Sì, ma io ho disteso le gambe e mi sono alzato.
Descrizione sensoriale:
– Ho disteso le gambe, dopo avere portato il peso (il baricentro) entro la base di appoggio definita dai piedi.
Chi dispone della consapevolezza espressa nella seconda descrizione non ha difficoltà a vedere le innumerevoli ragioni e situazioni in cui un movimento raggiunge il suo scopo, e quelle in cui non ha successo.
Il servizio resoci da questa capacità di attenzione permette, per esempio, di intervenire opportunamente per perfezionare una qualunque, nostra o altrui, prassia psico-motoria. Intervento che, prima di essere tecnico, è di presa di coscienza di sé da parte di chi sta ricreando la prassia stessa.
Il discorso è tanto ampio quanto culturalmente e individualmente rivoluzionario. Quel medesimo sentire e vedere permette di riconoscere la presenza di tensioni muscolari che impediscono il successo della prassia, inoltre informa sulle condizioni psicologiche nostre e altrui, ovvero sulla causa delle tensioni stesse. Il corpo, i muscoli – oltre che gli organi – esprimono e registrano tutto ciò che metafisicamente avviene in noi.
Punto quarto
Il diaframma è un muscolo. Anatomicamente parlando, segue l’andamento delle costole più basse, è legato allo scheletro lungo l’estremità inferiore della cassa toracica, alla base dello sterno, e a tre delle cinque vertebre lombari.
Secondo la scienza, questo muscolo laminare ha diverse funzioni. Separa gli organi – fegato, milza, reni, pancreas, stomaco, intestino – da cassa toracica, polmoni e cuore. Contraendosi, con la sinergia di altri muscoli (1), induce l’inspirazione, l’espulsione di scarti (minzione e defecazione), di sostanze tossiche ingerite (vomito) e il parto.
Il rilascio della contrazione è, invece, necessario all’espirazione.
Questa è la descrizione delle sue funzioni meccaniche. Una delle innumerevoli che la scienza utilizza per descrivere tutte le sue parti del corpo. Essa, derivando dal modus analitico, rinforza l’idea dell’uomo-macchina e porta all’idea dei trapianti come valore universale.
Ma il corpo è solo l’espressione formale di un certo spirito vitale.
In ambito energetico, il diaframma è un cancello: se cronicamente contratto interrompe il flusso emozionale, dividendo in due parti separate l’individuo. Più esattamente, divide lo stato intellettuale, che domina, da quello sensoriale, che viene mortificato.
Nello stato di paura la contrazione muscolare del diaframma coinvolge l’intero organismo. La respirazione diviene superficiale e toracica, lo scorrimento energetico è impedito e il controllo su noi stessi si riduce. È il momento della reazione acritica e, di conseguenza, della cancellazione dell’azione consapevole.
I riflessi di tali circostanze si possono vedere nell’espressione del volto, dimostrativa di quello stato di paura. Uno stato al quale si può riconoscere la cancellazione della creatività, che sarebbe, invece, particolarmente utile in ambito di difficoltà, in quanto proprio a mezzo di questa potremmo ricombinare idee e mezzi a disposizione per uscirne.
Nei bambini e negli adulti consapevoli, a riposo, un diaframma decontratto permette l’inspirazione cosiddetta addominale o bassa, e che le narici – che svolgono le funzioni di filtro e riscaldamento – possano essere sede dello scorrimento del flusso d’aria. Al contrario, se contratto, sarà più frequente osservare il passaggio del flusso dalla bocca.
È a causa di questa evidenza che il pranayama, volgarmente lo yoga della respirazione, e le tradizioni sapienziali in generale, invitano a utilizzare le narici invece della bocca, sostenendo che ciò stimola un godimento energetico del corpo, a favore di tutti i contesti della vita. È inspirando in questo modo che possiamo avvalerci del prana, l’energia vitale presente nell’aria. I cosiddetti respiriani, coloro che hanno cessato di assumere cibo –insospettabile abitudine che tutti possono cessare di perseguire – che si nutrono di aria, lo possono testimoniare più di chiunque altro.
Lo stato di contrazione o libertà del diaframma, e il conseguente potere che nega o offre all’uomo che ne è semplicemente consapevole, è noto a molti, tra questi gli apneisti, i cantanti, gli atleti evoluti in generale. Le contrazioni incontrollate e croniche del diaframma, spesso associate a quella dei muscoli addominali e dell’ileo psoas, concorrono a ridurre la mobilità articolare tanto della colonna, quindi del tronco, tanto del bacino e degli arti inferiori.
Anche l’impiego della cintura e di capi stretti, tipici dell’abbigliamento occidentale, in particolare se stretti in vita, sopra le creste iliache, comprimendo la libertà dell’addome, possono ridurre la qualità della respirazione addominale e, con esso, la profondità della meditazione e della contemplazione, ovvero il loro potere auto-curativo.
Lo sbadiglio è una conseguenza di un cambio di stato del diaframma, che riflette un cambio di stato della persona, dell’attività, dell’emozione. Tuttavia, è limitatamente noto in quanto indice di stanchezza, richiesta di riposo, avvio delle attività nel risveglio.
Anche il singhiozzo e il pianto singhiozzante ne sono espressioni. Al primo corrisponde un’irrefrenabile contrazione involontaria, provocata – come molte contratture muscolari e molti incidenti – da una distonia tra quanto sentiamo e quanto vogliamo, dall’assenza di presenza nel qui ed ora, sostituita da una forma-pensiero che ne prende il posto.
Per placare il pianto singhiozzante, –che pure corrisponde a una contrazione fuori controllo – e la connessa respirazione toracica si sente dire fai un bel respiro. Un’indicazione rispettabile se ne seguisse una respirazione addominale, ma inefficace se, per inconsapevolezza, rimare toracica.
Se, dunque, la disponibilità del diaframma (decontratto) e la sua indisponibilità (contratto) possono essere considerate centrali per l’equilibrio/squilibrio e la miglior forza/vulnerabilità della persona, esse hanno anche a che vedere con la sessualità. Un blocco emozionale o un timore morale possono provocare la contrazione del diaframma che, in questo modo, lascia senza forza la parte addominale, generando impotenza e frigidità.
Punto quinto
Nella mia esperienza didattica relativa a diverse attività psicomotorie, gran parte delle persone vive nell’assenza, apparentemente asintomatica, di sintonizzazione con la respirazione, il corpo, il sentimento e l’emozione. Non significa che non avvertano la loro presenza, ma che non sono consapevoli dei messaggi che contengono. Per questa maggioranza le informazioni sul diaframma si esauriscono, ed è già tanto, nel sapere dove si trova e come viene descritto e classificato dalla scienza analitica, avendone così una concezione esclusivamente materiale che, per definizione, destituisce il mondo in oggetto dal significato simbolico e valore energetico.
Infatti, esotericamente parlando, la piatta descrizione anatomica “muscolo impari, cupuliforme e laminare che separa la cavità toracica da quella addominale” (2) risulta asettica, privata dell’eros. Una considerazione che tutti gli emancipati dalla cultura materialista-analitico-intellettuale, consapevoli che la conoscenza è già in noi, troveranno pleonastica.
Questi sentono che il diaframma e noi stessi siamo tutt’uno con la respirazione, con il corpo, con il sentimento e l’emozione, con la scoperta, l’esplorazione e il recupero del sé, ovvero del pieno equilibrio e della massima invulnerabilità.
Note
.1 All’inspirazione a riposo partecipano anche i muscoli intercostali esterni, mentre addominali, intercostali interni e scaleni concorrono all’espirazione sotto sforzo.
.2 https://it.wikipedia.org/wiki/Muscolo_diaframma

