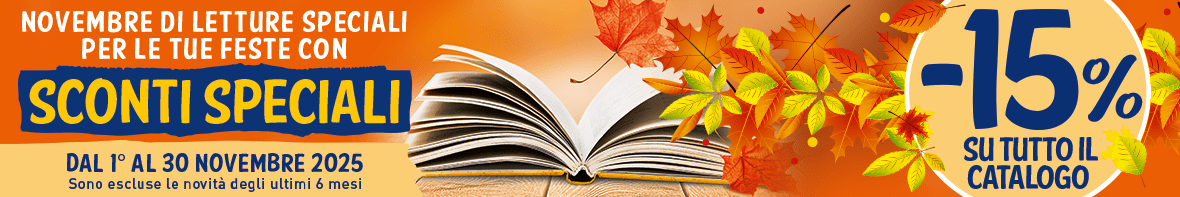Stati Uniti a Trump: rivolta contro il sistema
di Giacomo Gabellini - 12/11/2016

Fonte: l'indro
Come accaduto all’indomani del Brexit, già dalle ore immediatamente successive al verdetto delle urne negli Stati Uniti si è assistito al proliferare di analisi e valutazioni basate su griglie demografiche (che prendono in esame, sesso, etnia, religione, età, ecc.) del tutto inadeguate a interpretare spiegare le ragioni del successo di Donald Trump. Sondaggisti e ‘profeti’ di varia natura si erano adoperati in analisi di questo tipo per essere clamorosamente smentiti dai fatti, non comprendendo la natura ‘di classe’ che stava acquisendo una fetta più che ragguardevole dell’elettorato.
Alla vigilia del voto, i commentatori liberal continuavano ad esprimere la convinzione che tutti gli Usa stiano guadagnando dalla globalizzazione nella stessa misura in cui se ne avvantaggiano gli Stati del New England e della Silicon Valley, non accorgendosi (o non volendosi accorgere o accorgendosi ma facendo finta del contrario) che per dare una pennellata di presentabilità alla condizione economica in cui versano gli Stati Uniti si è dovuto ricorrere a una sostanziale modifica dei metodi di calcolo di fondamentali come disoccupazione e inflazione. Non stupisce quindi che, vedendo disintegrarsi le proprie previsioni che attribuivano alla Clinton una vittoria con largo margine, l’intellettuale liberal Premio Nobel per l’economia Paul Krugman abbia dovuto ammettere di non conoscere in proprio Paese, a differenza di un grande cantautore come Bruce Springsteen, capace di dipingere quell’America lavoratrice sempre più consapevole di esser scaricata dai propri tradizionali referenti, tanto più ricchi ed autoreferenziali quanto più inclini ad allontanarsi dalla propria base elettorale. Agli occhi di questa fascia sociale abbandonata ed impoverita, i Clinton, capaci di sfruttare la politica in maniera incredibilmente spregiudicata – come dimostrato dalle migliaia di e-mail diffuse da ‘WikiLeaks’ e dall’inchiesta del ‘Wall street Journal’ – per mettere in piedi un impero (quella della Clinton Foundation) da quasi 400 milioni di dollari, rappresentano l’incarnazione dello storico voltafaccia subito dai lavoratori Usa. Bernie Sanders, il candidato sconfitto alle primarie democratiche da Hillary Clinton anche grazie ai favoritismi dall’apparato del partito, ha dimostrato piena consapevolezza di ciò dichiarando che Trump «ha attinto alla rabbia della classe media stanca dell’establishment politico, economico e dei media […] Se Trump si mostrerà serio nel voler perseguire politiche che migliorino la vita dei lavoratori in questo Paese, io e altri politici progressisti siamo pronti a lavorare con lui».
Se si osserva la mappa elettorale degli Stati Uniti, è facile accorgersi che non sono gli evangelici, il Ku Klux Klan o gli ‘anziani egoisti’ (un’espressione che ha preso piede a seguito del referendum britannico) ad aver spostato gli equilibri elettorali, ma la valanga di voti della Rust Belt, la ‘cintura della ruggine’ che soffre maggiormente l’impatto della globalizzazione. In questi Stati manifatturieri si concentrano gli effetti disastrosi della delocalizzazione degli impianti produttivi, dell’aumento della disoccupazione e dello stallo dei salari. Una situazione ben illustrata dalle condizioni indicibili (spopolamento, disoccupazione dilagante, aumento esponenziale della criminalità, ecc.) in cui versa una città come Detroit, storica capitale mondiale dell’automobile. Trump ha sbancato in Michigan, Wisconsin, Iowa, Indiana, West Virginia, Ohio e Pennsylvania (Stati che, ad eccezione dell’Indiana e del West Virginia, erano andati tutti ai democratici alle elezioni del 2012) sottolineando agli occhi dei disoccupati e degli operai che fanno sempre più fatica a sbarcare il lunario e a tenersi stretto il posto di lavoro di aver di fronte un candidato estraneo al ‘sistema’, che aveva pagato di tasca propria gran parte della campagna elettorale e stava riuscendo a concorrere efficacemente per la Casa Bianca nonostante l’establishment del suo stesso partito avesse fatto di tutto per frenare la sua corsa. Lo ha fatto impiegando una retorica tanto rude e volgare quanto efficace nell’indurre bianchi, neri, ispanici, eterosessuali, gay, cristiani, ebrei e musulmani ad attribuire un’importanza del tutto secondaria alle loro differenze etniche, religiose e di genere in nome del primato costituito dalla loro comune appartenenza a classi sociali disagiate.
A fare la differenza è stata proprio questa capacità di Trump di fare in modo che i fattori etnici – su cui molto tendono a far leva i democratici, i quali godono tradizionalmente del favore delle minoranze – venissero declinati in forma economica e non identitaria. Ciò ha fatto sì che una compagine estremamente variegata votasse a favore del candidato repubblicano assieme a quegli Wasp razzisti contro cui si scagliano oggi gli stessi ‘specialisti’ che fino a ieri consideravano questo gruppo sociale il nocciolo duro della middle-class, unanimemente riconosciuta la vera e propria spina dorsale dell’economia Usa. L’identikit stereotipato (maschio, bianco non particolarmente acculturato) dell’elettore medio di Donald Trump disegnato da costoro non solo trasuda un marcato odio di classe più confacente alla Francia del XVIII Secolo che al mondo d’oggi, ma tradisce la totale ignoranza della realtà statunitense, perché non riflette la complessità dell’elettorato che ha favorito l’ascesa del tycoon newyorkese alla presidenza.
Un elettorato che ha cercato per anni una alternativa allo status quo, e che appena ha creduto di averla individuata in Barack Obama, ha appoggiato in massa il semi-sconosciuto senatore dell’Illinois facendone una macchina da guerra in grado di sconfiggere Hillary Clinton alle primarie e di seppellire il candidato repubblicano John McCain sotto una valanga di voti. Obama non è stato tuttavia capace di assicurare quella sostanziale discontinuità rispetto alle politiche del passato, ed ora quello stesso elettorato che lo aveva condotto alla Casa Bianca è passato ad appoggiare un outsider come Trump, riponendo in lui le medesime speranze. Il punto è che per mettere in atto un vero cambiamento occorre garantire all’elettorato la possibilità di scegliere strade realmente differenti tra loro. Esattamente ciò che i partiti si sono finora assicurati di evitare in nome di una visione assiomatica che trova nella liberalizzazione dei flussi di capitale, nelle privatizzazioni, nella compressione dei salari e nella riduzione della spesa pubblica i propri capisaldi concettuali.
In America come in Europa, questa è stata la politica adottata finora, a prescindere dal colore dei governi e dei parlamenti. Personaggi come Trump sono la risposta a questo stallo intellettuale risultate dalla degenerazione oligarchica fattasi progressivamente strada in tutte le democrazie europee. Un approccio che rifiuta di porre tutti i cittadini su un livello di parità perché ritiene che le élite tecnocratiche siano depositarie di una specie di ‘conoscenza assoluta’ che non contempla l’esistenza di alcuna alternativa allo status quo. Il successo di Trump è dovuto in buona parte proprio al suo mettere in radicale discussione i dogmi del nostro tempo, la cui stretta osservanza ha spinto le società civili sul piano inclinato dell’impoverimento e della disoccupazione.