Suggestione, incantesimo, emozione, magia
di Lorenzo Merlo - 17/08/2025
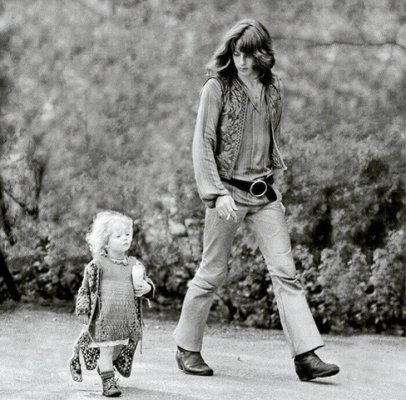
Fonte: Lorenzo Merlo
Cosa non è suggestione se non ciò che si sente? E come fa la descrizione che possiamo farne a non sfuggire alle suggestioni?
La suggestione e l’incantesimo hanno il medesimo carattere, riferiscono la medesima condizione. La sola differenza è nella loro durata, il che permette di riconoscerne l’identicità.
Entrambe sottostanno a un’emozione. Entrambe, nel perdurare dell’emozione che le impone, impediscono una visione del mondo, un comportamento a esse incompatibile. Mentre, ignari del loro potere assoluto su noi, abbiamo l’avventata sconsideratezza di utilizzare il senno di poi per sostenere che sarebbe bastato fare 1+1 per comprendere, per evitare il comportamento che invece abbiamo eseguito.
Ma il senno di poi esiste entro una trama razionale e un ordito egocentrico, che, nonostante la loro presunta esaustività nella descrizione del reale, compongono un tessuto dalle maglie sempre troppo, infinitamente, larghe per contenere, per spiegare e piegare a sé le energie sottili che fanno capo alle emozioni.
Queste si potrebbero dire di due generi: acute e croniche.
Le prime sono quelle di facile riconoscimento. Quando entrano in noi devastano gli schemi ordinari, tipici di quelle croniche, e cambiano in un momento il mondo “davanti” a noi. Davanti, con le virgolette, in quanto è più opportuno dire dentro, sebbene egocentricamente e scientisticamente lo si creda fuori, quindi separato da noi, quindi davanti. In esse – in quanto non sono in noi, ma noi siamo in loro – tanto più sono forti, tanto più è evidente, siamo obbligati a scelte altrimenti latenti, teoriche, impotenti.
Le seconde sono meno avvertite e riconosciute. Possono essere dette croniche in quanto conviviamo con esse senza avvertirne la presenza, cioè coincidono con noi stessi. È a causa di queste che, quando diciamo io, intendiamo qualcosa che conosciamo bene, fino a sapere sempre i suoi desideri, le sue aspirazioni. È così, per le emozioni croniche, che si persegue un progetto, che si diventa e si realizza ciò che avevamo sognato di essere e di fare. È a causa della loro persistenza-insistenza che troviamo le motivazioni necessarie a qualunque intento. È a causa di un’emozione cronica di altro genere che non possiamo capacitarci di come un nuotatore stia in acqua ore tutti i giorni, per anni, o di come si possa venire corrotti per amore di una proiezione di se stessi come persona di successo. E così via. L’emozione cronica, perlopiù, non pare sia presente nella consapevolezza della persona che l’ha in sé. Tanto più è forte, tanto più il pensare e il fare sono in sua funzione. E quando così va, tendenzialmente, si sfrutta al meglio il gradiente dei talenti specifici di cui disponiamo. Il pensare costantemente al nostro sogno è un allenante, ed è la condizione necessaria per allenare anche la parte fisica, pratica. Vale per l’abilità di un chirurgo, per la strategia di uno scacchista, per tenere una curva a 300 all’ora.
In qualche modo, dire io è riferire l’emozione cronica che vive in noi, dire non io, è riconoscere un’anomalia rispetto allo standard dell’io.
Suggestioni, incantesimi, e le relative emozioni, possono avere carattere relativamente neutro, parzialmente condizionato, o condizionato.
Tra quelle relativamente neutre troviamo le più frequenti. Esse insorgono e muoiono in noi e sono sostanzialmente vissute come faccende private.
A quelle parzialmente condizionate corrispondono le suggestioni e gli incantesimi famigliari e sociali. Le prime, per esempio, vengono smascherate da adulti; le seconde a mezzo di consapevolezze, per esempio sulle dinamiche e ragioni della necessità di controllo del potere, senza le quali del potere neppure si avverte la presenza, al pari del bambino che non conosce il dubbio sulle verità imparate in famiglia.
Il tipo condizionato corrisponde a una suggestione o incantesimo preterintenzionale, messo in atto da terzi, a loro vantaggio. Ed è a causa di questo che si differenzia dal tipo parzialmente condizionato. Lo si può osservare ancora in famiglia, se gli adulti vogliono sfruttare i piccoli per servizi più o meno importanti, dove il fin di bene – presente nel tipo precedente – viene meno. E lo si può riscontrare in molte relazioni interpersonali tra adulti, in cui una delle parti è gestita a suo piacimento dall’altra.
Fa parte non marginale, ma costituente, di questo discorso la condizione dell’accredito. Quanto finora detto, infatti, tende a corrispondere all’esperienza della maggior parte di noi, quindi a una generale attendibilità, condivisibile inserendo l’elemento dell’accredito. Più è l’accredito che accordiamo a una fonte, un’ideologia, una moda, una persona, una passione, in modo direttamente proporzionale ne saremo dipendenti, quando non succubi, dominabili. Al contrario, senza accredito, resteremo all’altezza di muoverci attraverso il nostro sentire, nonché di rinunciare a questo consapevolmente, cioè senza sofferenza, senso di colpa, ma mantenendo serenità.
Da non tralasciare che nell’accredito è implicito l’ascolto, il quale sarà tanto più acritico, tanto più sarà lo stato di soggezione, comportando così il massimo assorbimento di valori, modelli, criteri, espressioni. Si veda una moda qualunque. Ma anche lo stato di innamoramento dipendente in cui la mortificazione di se stessi avviene di buon grado, e di chi amiamo non vediamo difetti e carenze, o superiamo aspetti per noi prima inaccettabili, intollerabili, brutti.
Le dinamiche relative alle suggestioni e agli incantesimi sono ben note ai pubblicitari, agli psicologi, ai comandanti e a chi si trova tra le mani l’opportunità di sfruttare il prossimo a mezzo delle suddette suggestioni e incantesimi, altrimenti detti promesse o ricatti d’ordine e dimensione varia.
Di tutto ciò è da sempre consapevole la ricerca esoterica, che, infatti, ha nominato magia bianca e magia nera quanto qui abbiamo indicato come suggestioni e incantesimi neutri e condizionati.
Se quanto detto finora è sostanzialmente banale, nel senso di disponibile alla consapevolezza di molti, forse lo è meno un altro aspetto di queste dinamiche. Esse, nel momento in cui evochiamo la realtà, vengono regolarmente scippate della loro natura, violentate nel loro potere, e zittite nella loro voce di conoscenza, in quanto, inconsapevolmente, riteniamo che dire “realtà” corrisponda a riferire un monoblocco definito dalla descrizione che ne facciamo, più simile a un cerchio, che pensiamo denso di miniature, bidimensionale e ben rifinito, che a una tempesta di frattali. Bidimensionale, in quanto ogni descrizione ferma il mondo come la fotografia fa con l’azione. E così fa ogni spiegazione e ogni piatto sapere cognitivo.
Ciò che pare utile estrarre dal sottobosco dell’inconsapevolezza riguarda altre dinamiche che potremmo nominare come quantistiche. Queste avrebbero in sé l’impedimento alla concezione di una realtà monolitica e identica, nonché un antidoto al virus esiziale dell’egocentrismo.
Quantistiche in quanto la realtà diviene, come sopra detto parlando di emozioni che ci dominano, in funzione delle esigenze presenti in noi. Col mutare di queste passiamo da uno stato – per esempio morale – a un altro, senza difficoltà, come fossimo sciami di passeri che assumono nel volare forme e direzioni molteplici. Oppure, al contrario, con senso di colpa, se la concezione di noi stessi ha la medesima monoliticità che attribuiamo alla realtà.
Quantistiche in quanto, come nell’esperimento della particella ¬ relativo al Principio di indeterminazione di Heisenberg ¬ non è possibile, come lo è invece nella meccanica classica, conoscere contemporaneamente la quantità di moto (velocità) e la posizione nello spazio della particella stessa. Significa che per la fisica classica il mondo è certo e prevedibile, nonché oggettivo, mentre nella meccanica quantistica no, in quanto esso avviene, decanta in un certo modo, poi descrivibile solo nel momento dell’osservazione. Cioè, la realtà si condensa in dato di fatto e si fa riconoscere solo al cospetto di chi la osserva. Non a caso si impiega il termine concezione della realtà.
L’osservatore la trova conforme a sé o difforme in funzione del suo stato. Ovvero, più osservatori – cioè individui esponenti di culture, sentimenti, obiettivi, geografie, epoche storiche, valori, ecc., differenti – descrivono diversamente il medesimo presunto dato di fatto, quello disgraziatamente bistrattato dal senno di poi, dal senso di colpa, dal buon senso, dall’ 1+1. Come se così rimuginando, oltre a prenderne le distanze, si ritenesse davvero di compiere un intervento utile e importante, incapaci invece di osservare per riconoscere le cause dell’azione criticata.
Anche la memoria è soggetta a questo tipo di relazione. Essa è, infatti, una realtà al nostro cospetto. Insorge in noi evocata da ciò che ci fa opportunamente vibrare (emozione) in modo funzionale alla sua condensazione.
Divenire altro, transitare da uno stato a un altro, entrare in un campo o uscirne, mantenendo per noi il solito stesso io, non è altro che avere inconsapevole natura quantistica, trattata con criteri meccanicistici. Come se la goccia che siamo, una volta unita al mare pretendesse di restare la goccia che era. Non è altro che far parte dell’infinito che ad ogni istante decanta nel finito sempre composto da suggestioni e incantesimi.
Siamo quantistici, come se ci spostassimo, inseguendo un filo che vediamo solo noi, da un campo all’altro, di cui non avvertiamo i confini, evidenti, invece, a chi ci osserva e critica.
“Disse che il mondo poteva solo essere conosciuto per come esisteva nel cuore degli uomini. Perché per quanto sembrasse un luogo che conteneva degli uomini, in realtà era un luogo contenuto nei loro cuori e quindi per conoscerlo era lì che bisognava guardare [...]”.
Cormac McCarthy, Oltre confine, Torino, Einaudi, 2014, p. 115.
