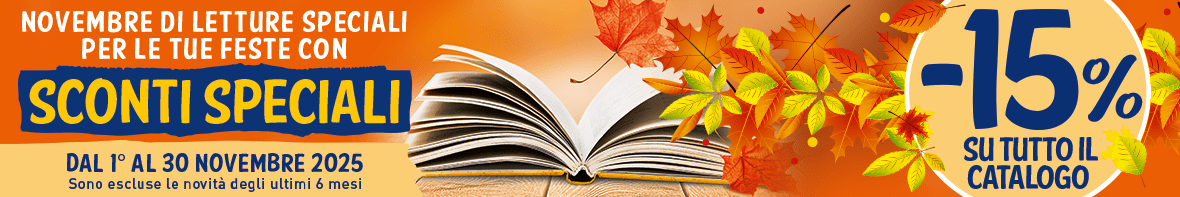Ma quanta ipocrisia quando gli occidentali parlano della pena di morte nel mondo
di Francesco Lamendola - 14/07/2010

Da un punto di vista puramente quantitativo, non si può certo dire che la pena di morte sia uno dei problemi più urgenti che affliggono l’umanità alla svolta del terzo millennio.
Le statistiche, nella loro nuda crudeltà, ci informano che un bambino, da qualche parte nel Sud della Terra, muore di fame ogni cinque secondi: chi ne ha voglia, può fare velocemente il calcolo di quanti ne muoiano in un’ora, in un giorno, in un mese o in un anno.
Il numero delle condanne a morte comminate nel 2006, secondo la Fondazione Dui Hua (con sede negli Stati Uniti d’America), sarebbe stato fra 7.500 e 8.000, in base a ben 68 reati che includono l’evasione fiscale, l’appropriazione indebita, il traffico di droga e la corruzione. Di queste, la parte del leone (93% del totale) la fanno i soliti cinque: Cina, Iran, Arabia Saudita, Pakistan e Stati Uniti; percentualmente, il tristo primato spetta all’Iran, con una esecuzione ogni 200.000 abitanti.
Ora, non c’è chi non veda come si tratti di cifre estremamente modeste, se confrontate a quelle della morte dovuta alla malnutrizione, alla sete, alle malattie infettive: lo scandalo della pena di morte, dunque, non sta nei numeri; questo bisogna dirlo con franchezza. Lo scandalo sta nel fatto in se stesso; nel terribile esempio che danno le massime istituzioni cui fanno riferimento gli individui nella loro vita sociale: il codice e il tribunale. Grazie alla pena di morte, lo Stato si fa assassino e la giustizia si presta a tale assassinio legalizzato.
Non c’è bisogno di scomodare alcune pagine famose di Victor Hugo o di George Orwell o alcune intense interpretazioni cinematografiche (come quella di una bravissima Sharon Stone nel film «Difesa a oltranza», del 1996) per sapere che - nel nostro paradigma culturale - la pena di morte è, puramente e semplicemente, una barbarie; noi Europei lo sappiamo da quasi tre secoli, e l’italiano Cesare Beccaria ha detto la parola definitiva in proposito, al tempo dell’Illuminismo.
Il fatto che gli Americani non lo sappiano, e che gli Stati Uniti figurino brillanti secondi, accanto alla Cina, per numero di esecuzioni capitali, dimostra soltanto quanta orribile ipocrisia vi sia nella mentalità calvinista e nella pretesa, tutta moderna e democratica, di fare la morale agli altri Paesi del mondo - a cominciare dalla Cina, appunto - nei quali non vengono rispettati i “diritti umani”. E chi non sa come vi fosse lo zampino, nemmeno tanto nascosto, del presidente Bush junior, dietro il processo, la condanna a morte e l’esecuzione di Saddam Hussein, che pure si sono svolti, formalmente, in piena autonomia da parte delle “autorità” irachene?
Riguardo alla pena di morte, possiamo dividere i Paesi del mondo in quattro categorie: quelli che la utilizzano normalmente come forma di punizione legale; quelli che la contemplano, ma non la applicano; quelli che la riservano ad alcune speciali circostanze, particolarmente per i crimini che vengano commessi in tempo di guerra; infine, quelli che l’hanno abolita totalmente, per qualsiasi tipo di crimine e in qualsiasi circostanza.
Alla prima categoria appartengono, oltre ai quattro già menzionati, l’Afghanistan, la Mongolia, la Corea del Nord, il Giappone, l’India, la Thailandia, il Vietnam, l’Indonesia, la Libia, l’Egitto, il Sudan, l’Etiopia, la Somalia, la Nigeria, lo Zaire, l’Iraq, la Siria, la Giordania, gli Emirati Arabi Uniti. L’unico Stato europeo che appartenga a questa categoria è la Russia Bianca o Bielorussia. In America, vi è anche il caso di Cuba, nella quale - però - è in corso una moratoria dal 2008. In tutto, sono sessantotto.
Alla seconda categoria, in cui la pena di morte non è stata eseguita da almeno dieci anni, appartengono il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, il Mali, il Gambia, il Niger, il Ghana, il Camerun, il Gabon, la Repubblica Centrafricana, il Kenya, la Tanzania, il Madagascar: tutti Stati africani. Gli unici stati asiatici che rientrano in questo gruppo sono il Myanmar (ex Birmania) e Sri Lanka (Ceylon). Si tratta, in totale, di 30 stati.
Della terza categoria, in cui la pena di morte è riservata a circostanze eccezionali, fanno parte l’Argentina, la Bolivia, il Perù, il Cile. In Asia, fino a due anni fa, erano Uzbekistan, Kazakistan e Israele. Il primo l’ha abolita gennaio 2008; il secondo ha istituito una moratoria dal dicembre 2003; il terzo la mantiene tuttora formalmente, per i reati di crimini contro l’umanità e alto tradimento, anche se l’ultima esecuzione (legale) risale al 1954, con lo spettacolare processo ad Adolf Eichmann, estradato illegalmente, o per meglio dire rapito, dall’Argentina. È il gruppo meno numeroso, composto complessivamente da soli dieci stati.
La quarta categoria comprende gli Stati europei (Russia compresa), la Turchia, il Canada, il Messico, la Colombia, il Venezuela, l’Ecuador, il Paraguay, l’Angola, il Mozambico, la Repubblica Sudafricana, la Namibia, l’Australia, la Nuova Zelanda. Si tratta, in totale, di 89 stati che hanno abolito definitivamente, per legge, la pena di morte.
Si giunge così alla conclusione che la maggior parte degli abitanti del nostro pianeta sono soggetti, almeno teoricamente, alla possibilità di subire la sentenza capitale; tra essi vi sono le più grandi (in senso quantitativo) democrazie del mondo: India e Stati Uniti d’America. I reati per i quali essa è prevista sono estremamente vari e, per un occidentale progressista e politicamente corretto, le sorprese non sarebbero poche, se andasse a vederli uno per uno.
Non sempre, infatti, si tratta di strage, omicidio, alto tradimento o gravissimi reati finanziari, come si potrebbe immaginare; o di adulterazione di prodotti alimentari, come in un caso, recente, che ha fatto scalpore in Cina. In Iran, ad esempio, si può essere giustiziati per il reato di sodomia; in altri stati, per quello di spergiuro. Paese che vai, usanza che trovi: e chi siamo noi occidentali, che ci crediamo sempre gli unici depositari della verità, per giudicare barbare o incoerenti le legislazioni altrui?
Ecco, qui ci stiamo avvicinando al cuore del problema. La pena di morte è, per un occidentale moderno, uno scandalo assoluto, perché nel suo DNA vi sono - gli piaccia o non gli piaccia - duemila anni di insegnamento e di pratica cristiani. Il fatto che la pena di morte sussista tuttora in India, culla del Brahmanesimo, in Cina, culla del Confucianesimo, in Giappone, patria dello Scintoismo, in Arabia Saudita, culla dell’Islamismo, e in Israele (sia pure non applicata), patria del Giudaismo, parla piuttosto chiaro.
In questo senso, il vero scandalo sono gli Stati Uniti, che si dicono, anzi si autoglorificano, come la più progredita delle società occidentali. La legislazione e la pratica della pena di morte negli Stati Uniti d’America sono il più grave atto di accusa contro il modello culturale e spirituale (se così si può dire) di quella nazione. Quando si ambisce ad essere leader, ma non si è capaci di mettersi al passo con le acquisizioni universalmente riconosciute nell’ambito di civiltà cui si appartiene, vuol dire che si esibisce una pretesa del tutto ingiustificata. La società americana non è in condizioni di fare da maestra all’Europa; al contrario, ha ancora moltissime cose da imparare: prima fra tutte, un poco di umiltà.
Diverso è il discorso per i Paesi di tradizione non cristiana; anche se ormai, con la globalizzazione dilagante, è ben difficile che uno stato possa isolarsi fino al punto di ignorare gli standard culturali ed etici che si vanno affermando a livello planetario. Non tutti possono fare come la Corea del Nord; il cui isolazionismo, del resto, ha i giorni contati.
Sia chiaro che non pretendiamo in alcun modo di dare un giudizio di valore. I giudizi di valore si possono dare solamente nell’ambito del proprio paradigma culturale, non fuori di esso. Per questa ragione, diciamo alto e forte che la pena di morte negli Stati Uniti d’America è uno scandalo intollerabile; ma non ci permetteremmo di dire la stessa cosa per la Cina, l’India, i Paesi arabi, i quali appartengono ad altri paradigmi culturali, prodotti da un’altra storia e basati su altri valori sociali e morali, che non coincidono con i nostri, ma che non abbiamo alcuna ragione per giudicare e tanto meno per condannare.
Perciò, se vogliamo essere coerenti e rispettosi del multiculturalismo, bisogna criticare la sopravvivenza della pena di morte nel mondo partendo da un altro ordine di ragionamento e non pretendendo di imporre a tutti la nostra storia ed i nostri valori.
Se esistano valori morali assoluti, infatti, è cosa troppo ardua a decidersi sul piano filosofico. Difficile spiegare a una tribù di cannibali della Nuova Guinea che la pratica di uccidere e divorare il copro dei nemici è moralmente sbagliata; e ancora più difficile è farlo da parte di una civiltà, come la nostra, che non ha esitato a praticare il genocidio e ad impiegare la bomba atomica, in anni purtroppo recentissimi, per risolvere le controversie internazionali. Tutto quel che si può fare, decentemente, è di scendere sul terreno pratico e contrastare, nei limiti del possibile e senza impiego sproporzionato della violenza, quelle pratiche che configgono irrimediabilmente con quel senso di umanità e di civiltà senza i quali, nella società globalizzata, non sarebbe possibile né ai popoli, né agli individui, parlare ed intendere un linguaggio comune.
Questo, per inciso, significa che le nostre femministe e le nostre anime belle dovrebbero andarci molto caute quando levano altissime strida per certe pratiche, come l’infibulazione o l’escissione, per non parlare dell’uso del velo o del burqa, le quali - a loro modo di vedere - offendono la dignità della donna. Primo, bisognerebbe vedere se e quando le dirette interessate, ossia le donne islamiche, si sentano davvero offese da tali pratiche; secondo, bisogna tener presente che queste ultime non sono nate dal nulla, ma da una lunga storia, che fa loro da contesto e le rende, spesso, non solo accettate, ma desiderate, in quei determinati ambiti culturali.
Non è detto che quanto risulta inaccettabile per la nostra mentalità, lo sia anche per gli altri; e non è detto che non vi siano, nella nostra società, dei costumi e delle tradizioni che non risultino sgradevoli o persino offensivi per quanti hanno vissuto un’altra storia e si sono dati dei valori differenti dai nostri.
Il guaio, naturalmente, è che con il fenomeno, rapidissimo e incontenibile, dell’immigrazione di milioni di persone, provenienti dai più diversi ambiti culturali, verso i Paesi occidentali, le diverse morali vengono bruscamente a confronto, specialmente attraverso il contatto fra gli immigrati di seconda e di terza generazione ed i loro coetanei occidentali; e ciò è causa di fortissime tensioni sia all’interno delle famiglie e delle comunità di immigrati, sia fra queste e le società che le hanno formalmente accolte, ma illudendosi di limitare tale accoglienza ad un ambito puramente utilitaristico (lavoro poco qualificato in cambio di ospitalità).
Questo, però, è un altro discorso, che esorbita dal nostro assunto presente; ne abbiamo già parlato in diverse altre occasioni, per cui non ci soffermeremo oltre su tale aspetto della questione, per quanto perfettamente consapevoli che si tratta di un nodo estremamente drammatico e dal cui mancato scioglimento dipenderà, senza dubbio, il destino della nostra civiltà.
Torniamo alla pena di morte. Se noi occidentali, figli della civiltà cristiana, non abbiamo alcun diritto di giudicare e condannare altre civiltà e altre culture, nelle quali la pena di morte non fa scandalo - e non necessariamente perché vi sia un minore rispetto della vita umana, ma piuttosto perché tale rispetto parte da altri presupposti e si misura con altre categorie, come nel caso del suicidio rituale giapponese -, come si può sostenere che la pena di morte è un male assoluto e, pertanto, andrebbe abolita ovunque?
Anche perché, a questo punto, viene in luce, in maniera clamorosa, tutta l’ipocrisia della nostra cultura odierna, per la quale è male che lo Stato tolga la vita ad un criminale, ma non lo è, anzi se ne incarica lo Stato medesimo, sopprimere un nascituro nel grembo della propria madre, mediante una pratica abortiva perfettamente legalizzata. Su questo le nostre femministe, sempre pronte a strillare per la triste sorte delle donne islamiche “costrette” a nascondersi sotto il burqa, non hanno niente da dire e non vedono alcuna contraddizione: anzi, semmai considerano la legalizzazione dell’aborto come una delle più radiose conquiste della nostra civiltà.
Non solo.
La vita è una; la vita di tutti gli esseri dovrebbe essere considerata un bene e unico e prezioso, se tale viene considerata quella dei nostri simili.
Non è serio il comportamento di quanti si indignano per la pena di morte, ma vanno tranquillamente a caccia e a pesca o, peggio, sfoggiano pellicce di foca o di leopardo. E non si venga a dire che la vita di un animale è una cosa, mentre quella di un essere umano è tutta un’altra cosa: perché, se si ritiene che la vita di qualsiasi essere umano, anche del peggior criminale, sia comunque un bene irrinunciabile, allora significa che si crede nella vita in quanto tale, indipendentemente dal fatto che sia quella di una persona degna, oppure no; e, in tal caso, ogni vita diventa preziosa e meritevole di compassione.
Coloro i quali si battono a spada tratta per la difesa della vita umana, ma non sprecherebbero neanche il più piccolo gesto per la difesa della vita di un animale, non hanno compreso che la vita universale è interrelata, che niente e nessuno vive separatamente dagli altri; e che mostrare rispetto e compassione per la vita degli animali non significa togliere nulla alla compassione e al rispetto dovuti agli esseri umani. L’amore per la vita non è una faccenda quantitativa; non diminuisce con l’aumentare dei soggetti meritevoli di amore, così come due genitori non amano di meno i propri figli allorché decidono di adottare un orfano.
Certo, l’atteggiamento più coerente sarebbe quello dei giainisti, che si mettono una reticella sulla bocca per non rischiare di inghiottire inavvertitamente nemmeno un moscerino; ma, senza arrivare a tanto, possiamo e dobbiamo avere, nei confronti di tutti i viventi, un atteggiamento di rispetto che parte dai medesimi presupposti, sia che si rivolga agli umani, quanto ai non umani. Il pastore navajo che tagliava un albero, rivolgeva una preghiera in cui si scusava per averlo ucciso; e la stessa cosa facevano i nostri progenitori prima di mettersi a caccia di orsi, cervi, bufali.
Amare la vita, vuol dire amarla sempre, sotto qualsiasi spoglia ed involucro; tanto nell’uomo adulto, quanto nel nascituro, e così pure nell’animale e nella pianta.
A meno di voler tornare all’aspetto più discutibile della filosofia di Cartesio e ritenere che solo l’uomo, in quanto dotato di pensiero, sia degno di essere considerato una nobile creatura; mentre tutti gli altri viventi non sarebbero che delle forme di “res extensa”: vale a dire delle cose, in fondo, e non degli esseri.
L’unico serio argomento con il quale si può auspicare che tutti i Paesi del mondo aboliscano la pena di morte dalle proprie legislazioni, è che essa non è in linea con un sentire che, nato e sviluppatosi nell’ambito della civiltà cristiana, si è poi diffuso ovunque e sta prendendo piede in ogni angolo del mondo, lentamente ma inarrestabilmente.
Qualsiasi altro argomento, crediamo, sarebbe sbagliato edimproprio.
Le statistiche, nella loro nuda crudeltà, ci informano che un bambino, da qualche parte nel Sud della Terra, muore di fame ogni cinque secondi: chi ne ha voglia, può fare velocemente il calcolo di quanti ne muoiano in un’ora, in un giorno, in un mese o in un anno.
Il numero delle condanne a morte comminate nel 2006, secondo la Fondazione Dui Hua (con sede negli Stati Uniti d’America), sarebbe stato fra 7.500 e 8.000, in base a ben 68 reati che includono l’evasione fiscale, l’appropriazione indebita, il traffico di droga e la corruzione. Di queste, la parte del leone (93% del totale) la fanno i soliti cinque: Cina, Iran, Arabia Saudita, Pakistan e Stati Uniti; percentualmente, il tristo primato spetta all’Iran, con una esecuzione ogni 200.000 abitanti.
Ora, non c’è chi non veda come si tratti di cifre estremamente modeste, se confrontate a quelle della morte dovuta alla malnutrizione, alla sete, alle malattie infettive: lo scandalo della pena di morte, dunque, non sta nei numeri; questo bisogna dirlo con franchezza. Lo scandalo sta nel fatto in se stesso; nel terribile esempio che danno le massime istituzioni cui fanno riferimento gli individui nella loro vita sociale: il codice e il tribunale. Grazie alla pena di morte, lo Stato si fa assassino e la giustizia si presta a tale assassinio legalizzato.
Non c’è bisogno di scomodare alcune pagine famose di Victor Hugo o di George Orwell o alcune intense interpretazioni cinematografiche (come quella di una bravissima Sharon Stone nel film «Difesa a oltranza», del 1996) per sapere che - nel nostro paradigma culturale - la pena di morte è, puramente e semplicemente, una barbarie; noi Europei lo sappiamo da quasi tre secoli, e l’italiano Cesare Beccaria ha detto la parola definitiva in proposito, al tempo dell’Illuminismo.
Il fatto che gli Americani non lo sappiano, e che gli Stati Uniti figurino brillanti secondi, accanto alla Cina, per numero di esecuzioni capitali, dimostra soltanto quanta orribile ipocrisia vi sia nella mentalità calvinista e nella pretesa, tutta moderna e democratica, di fare la morale agli altri Paesi del mondo - a cominciare dalla Cina, appunto - nei quali non vengono rispettati i “diritti umani”. E chi non sa come vi fosse lo zampino, nemmeno tanto nascosto, del presidente Bush junior, dietro il processo, la condanna a morte e l’esecuzione di Saddam Hussein, che pure si sono svolti, formalmente, in piena autonomia da parte delle “autorità” irachene?
Riguardo alla pena di morte, possiamo dividere i Paesi del mondo in quattro categorie: quelli che la utilizzano normalmente come forma di punizione legale; quelli che la contemplano, ma non la applicano; quelli che la riservano ad alcune speciali circostanze, particolarmente per i crimini che vengano commessi in tempo di guerra; infine, quelli che l’hanno abolita totalmente, per qualsiasi tipo di crimine e in qualsiasi circostanza.
Alla prima categoria appartengono, oltre ai quattro già menzionati, l’Afghanistan, la Mongolia, la Corea del Nord, il Giappone, l’India, la Thailandia, il Vietnam, l’Indonesia, la Libia, l’Egitto, il Sudan, l’Etiopia, la Somalia, la Nigeria, lo Zaire, l’Iraq, la Siria, la Giordania, gli Emirati Arabi Uniti. L’unico Stato europeo che appartenga a questa categoria è la Russia Bianca o Bielorussia. In America, vi è anche il caso di Cuba, nella quale - però - è in corso una moratoria dal 2008. In tutto, sono sessantotto.
Alla seconda categoria, in cui la pena di morte non è stata eseguita da almeno dieci anni, appartengono il Marocco, l’Algeria, la Tunisia, il Mali, il Gambia, il Niger, il Ghana, il Camerun, il Gabon, la Repubblica Centrafricana, il Kenya, la Tanzania, il Madagascar: tutti Stati africani. Gli unici stati asiatici che rientrano in questo gruppo sono il Myanmar (ex Birmania) e Sri Lanka (Ceylon). Si tratta, in totale, di 30 stati.
Della terza categoria, in cui la pena di morte è riservata a circostanze eccezionali, fanno parte l’Argentina, la Bolivia, il Perù, il Cile. In Asia, fino a due anni fa, erano Uzbekistan, Kazakistan e Israele. Il primo l’ha abolita gennaio 2008; il secondo ha istituito una moratoria dal dicembre 2003; il terzo la mantiene tuttora formalmente, per i reati di crimini contro l’umanità e alto tradimento, anche se l’ultima esecuzione (legale) risale al 1954, con lo spettacolare processo ad Adolf Eichmann, estradato illegalmente, o per meglio dire rapito, dall’Argentina. È il gruppo meno numeroso, composto complessivamente da soli dieci stati.
La quarta categoria comprende gli Stati europei (Russia compresa), la Turchia, il Canada, il Messico, la Colombia, il Venezuela, l’Ecuador, il Paraguay, l’Angola, il Mozambico, la Repubblica Sudafricana, la Namibia, l’Australia, la Nuova Zelanda. Si tratta, in totale, di 89 stati che hanno abolito definitivamente, per legge, la pena di morte.
Si giunge così alla conclusione che la maggior parte degli abitanti del nostro pianeta sono soggetti, almeno teoricamente, alla possibilità di subire la sentenza capitale; tra essi vi sono le più grandi (in senso quantitativo) democrazie del mondo: India e Stati Uniti d’America. I reati per i quali essa è prevista sono estremamente vari e, per un occidentale progressista e politicamente corretto, le sorprese non sarebbero poche, se andasse a vederli uno per uno.
Non sempre, infatti, si tratta di strage, omicidio, alto tradimento o gravissimi reati finanziari, come si potrebbe immaginare; o di adulterazione di prodotti alimentari, come in un caso, recente, che ha fatto scalpore in Cina. In Iran, ad esempio, si può essere giustiziati per il reato di sodomia; in altri stati, per quello di spergiuro. Paese che vai, usanza che trovi: e chi siamo noi occidentali, che ci crediamo sempre gli unici depositari della verità, per giudicare barbare o incoerenti le legislazioni altrui?
Ecco, qui ci stiamo avvicinando al cuore del problema. La pena di morte è, per un occidentale moderno, uno scandalo assoluto, perché nel suo DNA vi sono - gli piaccia o non gli piaccia - duemila anni di insegnamento e di pratica cristiani. Il fatto che la pena di morte sussista tuttora in India, culla del Brahmanesimo, in Cina, culla del Confucianesimo, in Giappone, patria dello Scintoismo, in Arabia Saudita, culla dell’Islamismo, e in Israele (sia pure non applicata), patria del Giudaismo, parla piuttosto chiaro.
In questo senso, il vero scandalo sono gli Stati Uniti, che si dicono, anzi si autoglorificano, come la più progredita delle società occidentali. La legislazione e la pratica della pena di morte negli Stati Uniti d’America sono il più grave atto di accusa contro il modello culturale e spirituale (se così si può dire) di quella nazione. Quando si ambisce ad essere leader, ma non si è capaci di mettersi al passo con le acquisizioni universalmente riconosciute nell’ambito di civiltà cui si appartiene, vuol dire che si esibisce una pretesa del tutto ingiustificata. La società americana non è in condizioni di fare da maestra all’Europa; al contrario, ha ancora moltissime cose da imparare: prima fra tutte, un poco di umiltà.
Diverso è il discorso per i Paesi di tradizione non cristiana; anche se ormai, con la globalizzazione dilagante, è ben difficile che uno stato possa isolarsi fino al punto di ignorare gli standard culturali ed etici che si vanno affermando a livello planetario. Non tutti possono fare come la Corea del Nord; il cui isolazionismo, del resto, ha i giorni contati.
Sia chiaro che non pretendiamo in alcun modo di dare un giudizio di valore. I giudizi di valore si possono dare solamente nell’ambito del proprio paradigma culturale, non fuori di esso. Per questa ragione, diciamo alto e forte che la pena di morte negli Stati Uniti d’America è uno scandalo intollerabile; ma non ci permetteremmo di dire la stessa cosa per la Cina, l’India, i Paesi arabi, i quali appartengono ad altri paradigmi culturali, prodotti da un’altra storia e basati su altri valori sociali e morali, che non coincidono con i nostri, ma che non abbiamo alcuna ragione per giudicare e tanto meno per condannare.
Perciò, se vogliamo essere coerenti e rispettosi del multiculturalismo, bisogna criticare la sopravvivenza della pena di morte nel mondo partendo da un altro ordine di ragionamento e non pretendendo di imporre a tutti la nostra storia ed i nostri valori.
Se esistano valori morali assoluti, infatti, è cosa troppo ardua a decidersi sul piano filosofico. Difficile spiegare a una tribù di cannibali della Nuova Guinea che la pratica di uccidere e divorare il copro dei nemici è moralmente sbagliata; e ancora più difficile è farlo da parte di una civiltà, come la nostra, che non ha esitato a praticare il genocidio e ad impiegare la bomba atomica, in anni purtroppo recentissimi, per risolvere le controversie internazionali. Tutto quel che si può fare, decentemente, è di scendere sul terreno pratico e contrastare, nei limiti del possibile e senza impiego sproporzionato della violenza, quelle pratiche che configgono irrimediabilmente con quel senso di umanità e di civiltà senza i quali, nella società globalizzata, non sarebbe possibile né ai popoli, né agli individui, parlare ed intendere un linguaggio comune.
Questo, per inciso, significa che le nostre femministe e le nostre anime belle dovrebbero andarci molto caute quando levano altissime strida per certe pratiche, come l’infibulazione o l’escissione, per non parlare dell’uso del velo o del burqa, le quali - a loro modo di vedere - offendono la dignità della donna. Primo, bisognerebbe vedere se e quando le dirette interessate, ossia le donne islamiche, si sentano davvero offese da tali pratiche; secondo, bisogna tener presente che queste ultime non sono nate dal nulla, ma da una lunga storia, che fa loro da contesto e le rende, spesso, non solo accettate, ma desiderate, in quei determinati ambiti culturali.
Non è detto che quanto risulta inaccettabile per la nostra mentalità, lo sia anche per gli altri; e non è detto che non vi siano, nella nostra società, dei costumi e delle tradizioni che non risultino sgradevoli o persino offensivi per quanti hanno vissuto un’altra storia e si sono dati dei valori differenti dai nostri.
Il guaio, naturalmente, è che con il fenomeno, rapidissimo e incontenibile, dell’immigrazione di milioni di persone, provenienti dai più diversi ambiti culturali, verso i Paesi occidentali, le diverse morali vengono bruscamente a confronto, specialmente attraverso il contatto fra gli immigrati di seconda e di terza generazione ed i loro coetanei occidentali; e ciò è causa di fortissime tensioni sia all’interno delle famiglie e delle comunità di immigrati, sia fra queste e le società che le hanno formalmente accolte, ma illudendosi di limitare tale accoglienza ad un ambito puramente utilitaristico (lavoro poco qualificato in cambio di ospitalità).
Questo, però, è un altro discorso, che esorbita dal nostro assunto presente; ne abbiamo già parlato in diverse altre occasioni, per cui non ci soffermeremo oltre su tale aspetto della questione, per quanto perfettamente consapevoli che si tratta di un nodo estremamente drammatico e dal cui mancato scioglimento dipenderà, senza dubbio, il destino della nostra civiltà.
Torniamo alla pena di morte. Se noi occidentali, figli della civiltà cristiana, non abbiamo alcun diritto di giudicare e condannare altre civiltà e altre culture, nelle quali la pena di morte non fa scandalo - e non necessariamente perché vi sia un minore rispetto della vita umana, ma piuttosto perché tale rispetto parte da altri presupposti e si misura con altre categorie, come nel caso del suicidio rituale giapponese -, come si può sostenere che la pena di morte è un male assoluto e, pertanto, andrebbe abolita ovunque?
Anche perché, a questo punto, viene in luce, in maniera clamorosa, tutta l’ipocrisia della nostra cultura odierna, per la quale è male che lo Stato tolga la vita ad un criminale, ma non lo è, anzi se ne incarica lo Stato medesimo, sopprimere un nascituro nel grembo della propria madre, mediante una pratica abortiva perfettamente legalizzata. Su questo le nostre femministe, sempre pronte a strillare per la triste sorte delle donne islamiche “costrette” a nascondersi sotto il burqa, non hanno niente da dire e non vedono alcuna contraddizione: anzi, semmai considerano la legalizzazione dell’aborto come una delle più radiose conquiste della nostra civiltà.
Non solo.
La vita è una; la vita di tutti gli esseri dovrebbe essere considerata un bene e unico e prezioso, se tale viene considerata quella dei nostri simili.
Non è serio il comportamento di quanti si indignano per la pena di morte, ma vanno tranquillamente a caccia e a pesca o, peggio, sfoggiano pellicce di foca o di leopardo. E non si venga a dire che la vita di un animale è una cosa, mentre quella di un essere umano è tutta un’altra cosa: perché, se si ritiene che la vita di qualsiasi essere umano, anche del peggior criminale, sia comunque un bene irrinunciabile, allora significa che si crede nella vita in quanto tale, indipendentemente dal fatto che sia quella di una persona degna, oppure no; e, in tal caso, ogni vita diventa preziosa e meritevole di compassione.
Coloro i quali si battono a spada tratta per la difesa della vita umana, ma non sprecherebbero neanche il più piccolo gesto per la difesa della vita di un animale, non hanno compreso che la vita universale è interrelata, che niente e nessuno vive separatamente dagli altri; e che mostrare rispetto e compassione per la vita degli animali non significa togliere nulla alla compassione e al rispetto dovuti agli esseri umani. L’amore per la vita non è una faccenda quantitativa; non diminuisce con l’aumentare dei soggetti meritevoli di amore, così come due genitori non amano di meno i propri figli allorché decidono di adottare un orfano.
Certo, l’atteggiamento più coerente sarebbe quello dei giainisti, che si mettono una reticella sulla bocca per non rischiare di inghiottire inavvertitamente nemmeno un moscerino; ma, senza arrivare a tanto, possiamo e dobbiamo avere, nei confronti di tutti i viventi, un atteggiamento di rispetto che parte dai medesimi presupposti, sia che si rivolga agli umani, quanto ai non umani. Il pastore navajo che tagliava un albero, rivolgeva una preghiera in cui si scusava per averlo ucciso; e la stessa cosa facevano i nostri progenitori prima di mettersi a caccia di orsi, cervi, bufali.
Amare la vita, vuol dire amarla sempre, sotto qualsiasi spoglia ed involucro; tanto nell’uomo adulto, quanto nel nascituro, e così pure nell’animale e nella pianta.
A meno di voler tornare all’aspetto più discutibile della filosofia di Cartesio e ritenere che solo l’uomo, in quanto dotato di pensiero, sia degno di essere considerato una nobile creatura; mentre tutti gli altri viventi non sarebbero che delle forme di “res extensa”: vale a dire delle cose, in fondo, e non degli esseri.
L’unico serio argomento con il quale si può auspicare che tutti i Paesi del mondo aboliscano la pena di morte dalle proprie legislazioni, è che essa non è in linea con un sentire che, nato e sviluppatosi nell’ambito della civiltà cristiana, si è poi diffuso ovunque e sta prendendo piede in ogni angolo del mondo, lentamente ma inarrestabilmente.
Qualsiasi altro argomento, crediamo, sarebbe sbagliato edimproprio.