Il dramma italiano è l’assenza di classe dirigente
di Francesco Lamendola - 25/07/2019
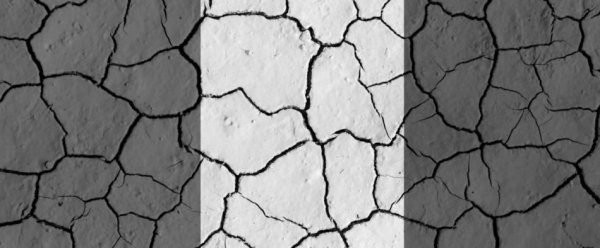
Fonte: Accademia nuova Italia
La classe dirigente è, o dovrebbe essere, la spina dorsale di una nazione. Niente classe dirigente, niente spina dorsale: e avremo una nazione afflosciata, prostrata, inerte. Per evitare di procedere nell’ambiguità, proviamo innanzitutto a dare una definizione di classe dirigente: essa è quella parte di una nazione che possiede sia la capacità, sia la volontà, sia infine i mezzi, per svolgere un ruolo trainante, e perciò direttivo, rispetto alla società. Si direbbe che ogni società possieda, almeno potenzialmente, la sua classe dirigente: anche quella formata dai superstiti di un naufragio, o quella di un carcere; perché è nella natura umana che le persone più intraprendenti, più intelligenti, più audaci, assumano delle iniziative che determinano, nel bene o nel male, la vita di tutti gli altri. La classe dirigente è perciò formata da quella minoranza creativa, da quel 5% della popolazione totale, che non si accontenta di vivere in maniera passiva, facendo quel che si è sempre fatto, obbedendo ai costumi e alle consuetudini, senza immaginare un futuro diverso, ma che cerca tenacemente di migliorare la propria condizione, sia sul piano economico, sia su quello sociale e politico. Abbiamo detto che essa esiste almeno potenzialmente. Tuttavia, di fatto, può essere del tutto assente, o per dir meglio del tutto latitante, una classe dirigente? Pensare una nazione non vuol dire anche pensare una classe dirigente, così come pensare a un corpo umano include, per ciò stesso, l’idea di una spina dorsale? Anche se ciò può sembrare un paradosso, a determinate condizioni la risposta è affermativa, ossia che può esistere una nazione, e a maggior ragione uno Stato, pressoché sprovvisto di una propria classe dirigente; e l’Italia ne è appunto un esempio molto significativo. Altri esempi, ancora più eclatanti, sono quelli delle nazioni africane, asiatiche e latino-americane, divenute indipendenti dopo l’esperienza del colonialismo, ma del tutto incapaci di reggersi da sé, senza invocare continuamente aiuti e interventi stranieri che impediscano loro d’implodere. Anche alcune aree d’Europa, specialmente l’area balcanica, sono esempi di nazioni e di Stati pressoché sprovvisti di classe dirigente, oppure, come nel caso della federazione lituano-polacca, dotati di una classe dirigente che, per varie ragioni, non ha saputo svolgere il suo ruolo storico e si è rivelata più d’impaccio che di aiuto per la propria patria. Dobbiamo infatti precisare che una classe dirigente degna di questo nome sa contemperare, in una misura ragionevole, il proprio interesse privato, di classe, con il bene generale della nazione e dello Stato dei quali fa parte; altrimenti è una classe meramente parassitaria.
L’Italia, come Stato nazionale, è stata fatta da un pugno di cospiratori, avventurieri e statisti spregiudicati, ma senza il contributo di una classe dirigente, che infatti non esisteva. Altro paradosso: l’Italia aveva una classe dirigente prima di nascere come Stato: l’aveva al tempo dei Comuni, al tempo delle Signorie e dei Principati; l’aveva, soprattutto, nelle due gloriose repubbliche marinare, Genova e Venezia (che erano al tempo stesso degli Stati regionali e dei piccoli imperi marittimi, ma non Stati nazionali); e anche nella gerarchia della Chiesa cattolica, la quale, non scordiamolo, era anche una monarchia (teocratica) e uno Stato temporale. Ed era una classe dirigente di prim’ordine; tanto è vero che per qualche secolo fu all’avanguardia mondiale in tutti i campi della vita associata, dalla finanza al commercio, dalle arti alla navigazione oceanica. Italiani erano i banchieri più ricchi, i mercanti più intraprendenti, gli artisti più celebri e i navigatori più audaci; e la moneta internazionale era il fiorino, come oggi il dollaro. Poi questa classe dirigente, che non era nazionale ma comunale o regionale, cominciò a perdere terreno, passò in coda rispetto a quelle delle altre nazioni europee, e infine si dissolse. Quando venne fatta l’unità d’Italia, si trattava di ricostruirla; e tale infatti è stato l’impegno degli uomini del Risorgimento e del post-Risorgimento, o, almeno, dei migliori fra essi – quelli che non perseguivano fini meschini, né inseguivano ideali utopistici, ma che, stando coi piedi ben piantati in terra, vedevano e capivano di che cosa il nuovo Stato avesse bisogno. Tanto più che la sua realizzazione veniva a coincidere con un momento storico in cui cominciava a scatenarsi la gara fra i nazionalismi, specie per l’accaparramento delle materie prime e lo sfruttamento dei mercati; gara che vedeva avvantaggiate le nazioni che avevano alle spalle una secolare esperienza di vita nazionale unitaria, durante la quale si erano formate le loro classi dirigenti, e svantaggiate le nazioni che, come l’Italia - e in misura diversa la Germania e il Giappone – erano giunte per ultime sulla scena della politica e dell’economia mondiale, e dovevano recuperare in pochi anni il tempo perduto, se volevano reggere l’urto di una simile sfida.
La scommessa era alquanto difficile ma non impossibile. Il Giappone doveva affrontare una scommessa ancor più difficile: partire da zero, importando una tecnologia interamente straniera ed estranea alle sue tradizioni. Si trattava, per l’Italia, di dotarsi di una classe dirigente che svolgesse il compito di spina dorsale della nazione e trasformasse in popolo un volgo disperso che nome non ha (Manzoni). Inevitabilmente, essa fu una classe dirigente “statale”, cioè il cui fulcro non era costituito, come negli altri maggiori Stati, dalla borghesia imprenditoriale e finanziaria, che in Italia muoveva appena i primi passi, ma dal ceto amministrativo, burocratico e militare, dalle famiglie aristocratiche antiche e recenti, che formavano il nerbo della grande proprietà fondiaria, specie nel Mezzogiorno, e, in seconda battuta, da un ceto imprenditoriale che muoveva i primi passi sulla scena nazionale e internazionale, con l’appoggio e le sovvenzioni dello Stato (la scelta protezionista in economia a partire dal 1876, con l’avvento della Sinistra al potere). Ciascuna di queste componenti aveva origini, strutture e finalità diverse: compito dello Stato era quello di fonderle, nella misura del possibile, o almeno di armonizzarle, e, nello stesso tempo, di avviare una “nazionalizzazione” del popolo, il grande escluso sia dai processi risorgimentali, sia dalla nascita dell’Italia unita (escluso o peggio, come si vide nella repressione del Brigantaggio meridionale: la prima guerra sostenuta dallo Stato unitario e che fu, precisamente, una guerra civile). Non è questa la sede per fare la storia, neanche sommariamente, di come lo Stato abbia fatto questo tentativo di armonizzazione e fusione della classe dirigente e di nazionalizzazione del popolo, e di come, per varie ragioni, interne ed esterne, abbia sostanzialmente fallito. Di quel fallimento il riflesso più evidente appare nel dramma dell’8 settembre 1943: il nodo in cui vengono al pettine decenni di tentativi abortiti per fondere in un solo blocco il popolo italiano e per dotarlo di una vera classe dirigente. La colpa non fu quindi del fascismo, che rappresentò, anzi, lo sforzo più serio, benché ancora insufficiente, per realizzare un tale obiettivo: il fascismo ebbe la sorte di prendere su di sé la responsabilità di quel fallimento, che risaliva al 1861, e di portarne eternamente il marchio, e ciò a causa dell’esito sfavorevole della Seconda guerra mondiale. Ma se, per ipotesi, la Prima guerra mondiale fosse finita con la vittoria degli Imperi Centrali, e per l’Italia si fosse conclusa sotto il segno di Caporetto, si può star certi che la crisi sarebbe esplosa allora, e l’Italia avrebbe avuto il suo 8 settembre nel 1917 o nel 1918. Insomma il fascismo cadde per una disavventura di politica estera, come gli storici più imparziali, come Sergio Romano, volentieri riconoscono: se avesse scelto la neutralità, avrebbe avuto l’evoluzione che ebbe il franchismo in Spagna dopo la morte di Franco: avrebbe dato luogo alla democrazia. Ma bisogna precisare che questa è pura teoria, sia perché la Spagna aveva avuto, prima della vittoria di Franco, la sua guerra civile, costata qualcosa come 300.000 morti, sia perché l’Italia, nel 1940, non era la Spagna, aveva uno status da grande potenza e per varie ragioni non poteva star fuori dal conflitto, meno di quanto lo avrebbe potuto nel 1915, allorché il governo liberale aveva deciso l’azzardo dell’intervento, contro la volontà del Parlamento e contro i sentimenti della maggioranza del popolo italiano.
Nell’età giolittiana e poi nel ventennio fascista, comunque, l’Italia aveva fatto grandi passi sulla via dell’industrializzazione, anche se solo nella pare nordoccidentale del Paese; era nata, quindi, una borghesia moderna, diversa dalla borghesia agraria meridionale, i cui interessi avevano conciso solo in parte con quelli della grande borghesia statale, formata da politici, diplomatici, dirigenti di industrie statali, militari di carriera e direttori di giornali, associazioni e istituzioni create o favorite dal regime. La giovane borghesia imprenditoriale aveva goduto tutti i vantaggi di una forte protezione statale, dalla neutralizzazione dei conflitti sociali alle forti commesse statali in regime di protezionismo, ciò che le aveva risparmiato un difficile confronto con la concorrenza straniera. La grande e media borghesia industriale italiana si sviluppò così in regime agevolato, fece ottimi affari col fascismo e contrasse anche il vizio di abituarsi a realizzare profitti con poco o nessun rischio: vizio fatale per una classe che ha nella propensione al rischio la molla fondamentale per svilupparsi e guadagnarsi ogni giorno, lottando sui mercati, il diritto di esistere. Questo vizio non l’ha più perso e lo conserva tuttora. Un tipico esempio è offerto dalle vicende della FIAT negli anni a noi più recenti. Abituata al trasformismo politico, ad assecondare qualunque regime purché le assicurasse aiuti legislativi e finanziamenti, la grande borghesia industriale non aveva sviluppato una concezione imprenditoriale all’altezza del suo ruolo: pensava, e pensa, che il gioco valga la candela solo se i margini di profitto sono buoni e i rischi sono minimi. Si spiega così il fatto che la famiglia Agnelli, a un certo punto, ha trasferito tranquillamente la produzione all’estero, insieme alla sede legale e quindi ai capitali e alla sua funzione contributiva, insalutata ospite di quello Stato italiano che pure l’aveva favorita in ogni modo e le aveva consentito di divenire una delle prime industrie automobilistiche al mondo. Così si comportavano i capitani di ventura del Rinascimento; così non si comporta una borghesia moderna e matura. E qui sarebbe necessario aprire un discorso sulla passività dello Stato, cioè degli uomini che lo servono e lo rappresentano, di fronte a una simile diserzione. Uno Stato degno di questo nome non avrebbe lasciato espatriare la più grande industria nazionale senza chiederle la restituzione delle somme generosamente elargite nel corso del tempo: avrebbe preteso, nell’interesse della comunità nazionale, un vero e proprio redde rationem. Invece la classe dirigente statale si è comportata come se lo Stato fosse una scala mobile alla quale si può accedere per salire senza fatica, e dalla quale si può scendere in qualsiasi momento, senza dare spiegazioni ad alcuno, secondo il proprio tornaconto privato. Se la famiglia Agnelli ha moralmente tradito l’Italia, il governo che l’ha autorizzata a esportare fabbriche, capitali e sede legale avrebbe dovuto affrontare un processo di Norimberga, perché merita solo una qualifica, quella di traditrice. E quel che è accaduto per la FIAT è accaduto, in varia misura, in tanti altri casi, sia con industrie private, come la Parmalat, sia con le banche, sulle quali lo Stato avrebbe dovuto vigilare affinché non truffassero i risparmi dei cittadini, e non l’ha fatto. Dunque lo Stato, a tutt’oggi, non è riuscito nemmeno a creare una classe di amministratori e di politici consci dei doveri della cosa pubblica nei confronti della nazione. Vizio antico, peraltro; si pensi allo scandalo della Banca Romana del 1892-94: ciò significa che dai tempi di Francesco Crispi a oggi, nell’arco di centoventi anni, poco o nulla è cambiato.
È valido ancora oggi, in sostanza, questo ritratto della grande borghesia italiana dei decenni tra il fascismo, la Seconda guerra mondiale, il boom economico e gli anni della recessione, tracciato da Piero Ottone nel suo libro Il gioco dei potenti (Milano, Longanesi & C., 1985, pp. 144-146):
Presto si tornò alla normalità [dopo l’aprile del 1945], e le grandi famiglie ripresero la loro esistenza. Un’esistenza dorata, senza dubbio, quale poteva essere permessa da grande ricchezza. Ma non certo volgare. Si era formata in Italia un’aristocrazia capitalistica che era giunta alla terza o quarta generazione, e aveva imparato ad apprezzare le cose belle. I Conti, i Falck, i Crespi abitavano in palazzi di città, avevano quadri preziosi alle pareti, erano circondati da vaste schiere di servitori, maggiordomi, cuochi, cameriere, giardinieri, autisti, ricevevamo artisti e scrittori. (A Londra, il presidente della Dunlop, una delle maggiori società industriali, invitava ospiti a pranzo senza alcun servitore, la moglie andava in cucina; all’estero, la decimazione della servitù era già un fatto compiuto; gli stranieri si meravigliavano dei nostri lussi, noi ci meravigliavamo della loro austerità.)
Alle date prestabilite, ogni anno, si trasferivano nelle ville in campagna, o sui grandi yacht, o a Vichy o ad Aix-les-Bains per la cura delle acque. Certo i nuovi ricchi mostravamo disprezzo. I Crespi sembrarono offesi quando furono infornati che Angelo Rizzoli, fondatore di dinastia, prima generazione, qui di “nouveau riche” (e si vedeva) ambiva a diventare loro socio nella proprietà del “Corriere della Sera”.
Ogni sintomo di innovazione era sgradito, naturalmente. Non concepivano il capitalismo come una guerra di concorrenza, tanto meno come un continuo avvicendamento che permettesse ai più abili di sostituirsi, di volta in volta, ai vecchi, ai deboli, ai sorpassati. In più di un caso si occupavano delle loro aziende da una certa distanza, delegando il compito della conduzione ad appositi uomini di fiducia, che avevano la mentalità del ragioniere piuttosto che la figura del manager. Erano “gentlemen of leisure”, gentiluomini con molto tempo libero a disposizione. Quando lavoravo come inviato al “Corriere”, i tre fratelli Crespi, Mario, Aldo e Vittorio, venivano in via Solferino una volta la settimana, il giovedì mattina tra le dieci e le undici, chiacchieravano amabilmente col direttore politico e col direttore amministrativo, che vedevano separatamente, si infornavano sulle ultime novità romane, si congratulavamo perché in azienda tutto andava per il meglio, scuotevano la testa sulle bizzarrie del mondo, e poi se ne andavano, chi tornando ai suoi cavalli, chi alle sue collezioni di porcellane. L’amministratore, Giuseppe Colli, era soprattutto un guardiano dei costi. Dominava su tutti una costante preoccupazione: “quieta non movere”.
Sarebbe stato difficile immaginare un esempio più evidente di capitalismo statico, quasi pietrificato. Le grandi famiglie erano il simbolo della continuità, e meglio di ogni altro gruppo sociale dimostravamo che il fascismo non aveva rappresentato, nella storia d’Italia, una rottura, una interruzione violenta, ma piuttosto un normale stadio nella evoluzione nazionale, una tappa nella continuità, con molti legami con quello che era avvenuto prima e con quello che era avvenuto dopo; come un essere umano deve passare attraverso l’infanzia, l’adolescenza, la gioventù, e così avanti fino alla maturità e alla vecchiaia, allo stesso modo una nazione doveva avere a un certo momento della propria crescita il suo periodo autoritario, il suo Mussolini. Chiuso il periodo, impiccato il dittatore, tutto tornava a scorrere nello stesso alveo di normalità. Si poteva dire, parafrasando Stalin: “I Mussolini vengono e vanno, le grandi famiglie rimangono”.
Alberto Pirelli era ricevuto a Palazzo Venezia, e si riferiva a Mussolini come al “capo”; Giovanni Agnelli lo riceveva a Mirafiori (e qualche volta andava a Palazzo Venezia anche lui, naturalmente); i Crespi gli avevano dato una mano per allontanare Luigi Albertini. Però avevano sempre guardato il dittatore dall’alto in basso, come un tribuno di passaggio, di cui disapprovavano, sempre più spesso i discorsi e le decisioni; questa disapprovazione era sufficiente per assolverli, ai loro occhi, da una collaborazione che era comunque obbligata, essendo ogni imprenditore costretto ad andare d’accordo col suo governo; era sufficiente perché si sentissero spiritualmente estranei, non coinvolti, non contaminati. Dopo il 1945, le grandi famiglie non desideravamo il ritorno del fascismo, preferivano la democrazia; ma non sentivano, verso quel Mussolini col quale avevamo avuto rapporti tollerabili, un odio particolare. Tutt’al più, disprezzo, perché aveva fatto la brutta fine che avevano previsto da sempre, la fine tipica di un tribuno.
La conclusione di tutto ciò, anche sul piano psicologico e sociologico, è una sola: assenza di classe dirigente. La classe dirigente di una nazione è come il corpo degli ufficiali su una grande nave in navigazione: la sua ragion d’essere è quella di tenere la rotta e di vigilare sulla sicurezza dei beni che trasborda, uomini e cose. La stoffa di cui è fatta si vede nei momento difficili, non in quelli delle vacche grasse; non nelle fasi di espansione economica e di prosperità sociale, ma nelle fasi di recessione, nella sconfitta (ecco l’8 settembre), quando la rotta diviene incerta. È lei che deve tenere la barra del timone; è lei che porta la responsabilità della salvezza comune, giustificando, nell’ora del pericolo, i vantaggi di cui gode e i privilegi che assicura ai propri figli. Le matrone romane presentavano lo scudo ai loro figli che partivano per la guerra, dicendo loro: O con questo, o su questo. In altre parole: essere patrizi comporta dei privilegi, ma anche dei precisi e ineludibili doveri. Una classe dirigente degna di questo nome non può comportarsi come Badoglio: ricevere onori e ricchezze dal regime, e poi pugnalare Mussolini alla schiena nel momento della crisi, per salvare la propria pelle e i propri privilegi. Troppo facile, troppo comodo. Massimo profitto e nessun rischio, appunto: una filosofia da miserabili, anzi da sciacalli. Abbiamo detto della FIAT di Sergio Marchionne, ma si possono fare cento altri esempi. Perfino la classe dirigente statale, in particolare la magistratura, invece di servire gl’interessi dello Stato, cioè della collettività nazionale, si abbandona a incomprensibili forme di sistematica indulgenza verso le forze che mirano a indebolire, screditare e, alla lunga, distruggere l’autorità dello Stato. Una procura che mette sotto inchiesta un ministro della Repubblica per aver negato l’ingresso in un porto nazionale a una nave di una o.n.g. privata, che agisce, tecnicamente, come una nave pirata, cioè sfrutta una bandiera straniera per scaricare in Italia orde di clandestini? (Per chi non lo sapesse, una nave all’estero è un prolungamento dello Stato in cui è registrata e di cui issa la bandiera: quindi, se prende a bordo delle persone per ragioni umanitarie, queste devono essere accolte, ai termini dei trattati internazionali, a cominciare da quello di Dublino, in quello Stato e non nello Stato straniero più vicino, o giudicato, per ragioni politiche soggettive, più “conveniente”: capito quale doveva essere la destinazione della Sea Watch?) Ma qui siamo all’assurdo e al grottesco. Lo Stato contro se stesso; la classe dirigente contro la comunità nazionale. Ci vorrebbe una Norimberga per tutti questi traditori: dovrebbero essere trascinati a render conto di come si sono guadagnati i loro alti stipendi, pagati dal popolo italiano, e di come, a fronte dei privilegi di cui godono, e che consentono loro un tenore di vita che non risente delle crisi economiche, dei fallimenti aziendali, dei licenziamenti, anzi tende a registrare gratifiche e buone uscite sempre più sostanziose (e ciò vale anche per i manager delle aziende pubbliche, magari portate gloriosamente al tracollo), si sono sdebitati, cioè cosa hanno fatto e cosa fanno per difendere l’interesse dello Stato e del popolo italiano…

