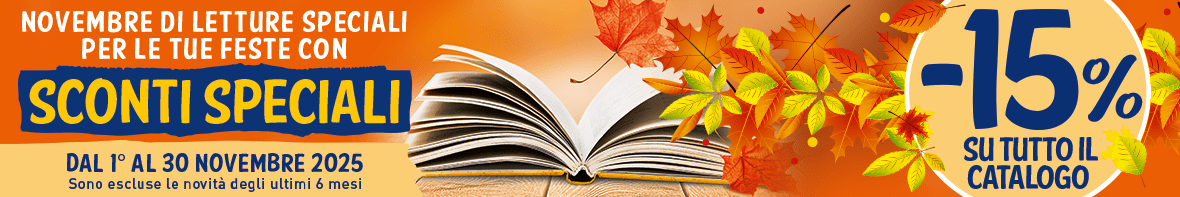Il matrimonio tra Stati Uniti e Arabia Saudita ha generato il jihadismo
di Daniel Lazare - 15/01/2018

Fonte: Aurora sito
Chiacchierando col primo ministro australiano Malcolm Turnbull al summit di cooperazione economica Asia-Pacifico nel novembre 2016, Barack Obama menzionava l’Indonesia, dove trascorse parte dell’infanzia negli anni ’60. Il Paese, notò, era cambiato. Laddove i musulmani un tempo adottarono elementi di induismo, buddismo e animismo, oggi una versione austera dell’Islam prevale da quando l’Arabia Saudita riversa denaro nelle madrase wahhabite dagli anni ’90. Dove le donne circolavano a capo scoperto, l’hijab comincia a diffondersi. Ma perché, voleva sapere Turnbull, succedeva questo? “I sauditi non sono vostri amici?” Al che Obama rispose, “È complicato“. Quella parola copre molto, non solo il wahhabismo, l’ideologia saudita ultra-fondamentalista il cui impatto si fa sentire in tutto il mondo, ma anche riguardo gli Stati Uniti principale protettore dei sauditi, e coadiuvante, dalla Seconda guerra mondiale. Come ogni potenza imperialista, gli Stati Uniti possono essere senza scrupoli nei partner che scelgono. Quindi ci si potrebbe aspettare che guardino dall’altra parte quando gli amici sauditi diffondono le loro dottrine militanti in Indonesia, Filippine, subcontinente indiano, Siria e numerosi altri posti. Ma Washington ha fatto di più che guardare altrove. Ha incoraggiato attivamente tali attività collaborando coi wahhabiti in qualsiasi occasione, come l’Afghanistan, dove statunitensi e sauditi armarono i jihadisti per cacciare i sovietici negli anni ’80. Come anche la Bosnia, dove i due Paesi collaborarono a metà degli anni ’90 per contrabbandare centinaia di milioni di dollari in armi nella repubblica islamica di Alija Izetbegovi?, oggi roccaforte del salafismo wahhabita. Altri esempi degni di nota: il Kosovo, dove gli Stati Uniti si sono uniti agli “arabi afghani” e altri jihadisti sostenuti dai sauditi per supportare il movimento separatista di Hashim Thaçi; in Cecenia, dove i principali neocon come Richard Perle, Elliott Abrams, Kenneth Adelman, Midge Decter, Frank Gaffney, Michael Ledeen e R. James Woolsey difesero gli islamisti sostenuti dall’Arabia Saudita; la Libia, dove Hillary Clinton reclutò personalmente il Qatar per aderire all’azione contro Muammar Gheddafi e poi non disse nulla mentre il regno wahhabita inviava 400 milioni di dollari ai gruppi islamisti che volevano rovesciare il Paese; e naturalmente la Siria, dove i terroristi sunniti appoggiati da sauditi e altre petromonarchie hanno ridotto il Paese in un ossario. Gli Stati Uniti si dichiarano scioccati, scioccati!, dai risultati, mentre intascano la vincita. Ciò è evidente da una famosa intervista del 1998 a Zbigniew Brzezinski che in qualità di consigliere per la sicurezza nazionale di Jimmy Carter, fece tutto il possibile per inventare il fenomeno della jihad moderna. Alla domanda se avesse qualche rimpianto, Brzezinski fu sfacciato: “Rimpiangere cosa? Quell’operazione segreta era un’idea eccellente. Ebbe l’effetto di trascinare i russi nella trappola afgana e volete che me ne penti? Il giorno in cui i sovietici varcarono ufficialmente il confine, scrissi al presidente Carter: Ora abbiamo l’opportunità di dare all’URSS la sua guerra del Vietnam… Cos’è più importante per la storia del mondo? I taliban o il crollo dell’impero sovietico? Alcuni musulmani agitati o la liberazione dell’Europa centrale e la fine della Guerra Fredda?” Oppure, come Graham Fuller, ex-vicedirettore del Consiglio nazionale sull’intelligence della CIA ed analista della RAND Corporation, un anno dopo: “La politica per guidare l’evoluzione dell’Islam e aiutarlo contro i nostri avversari ha funzionato meravigliosamente bene in Afghanistan contro l’Armata Rossa. Le stesse dottrine possono ancora essere utilizzate per destabilizzare ciò che rimane della potenza russa e soprattutto per contrastare l’influenza cinese in Asia centrale”.
Cosa potrebbe andare storto? Meno fenomeno specificamente saudita, la grande offensiva wahhabita degli ultimi 30-40 anni è meglio intesa come joint venture tra imperialismo e revivalismo islamico neo-medievale. Di per sé, tale austera dottrina non sarebbe mai uscita dai calanchi dell’Arabia centrale. Solo grazie alle potenze estere, prima la Gran Bretagna e poi gli Stati Uniti, è divenuta una forza che altera il mondo. Tuttavia, un po’ di preistoria potrebbe essere utile. Per sapere come è nato il wahhabismo, è necessario sapere dove è sorto. Nel Najd, un vasto pianoro nell’Arabia centrale delle dimensioni della Francia. Limitato su tre lati dal deserto e dal quarto dalla provincia dell’Hajaz, un po’ più fertile sul Mar Rosso, era uno dei luoghi più isolati e aridi della terra fino alla scoperta del petrolio negli anni ’30. Meno isolato ora, rimane estremamente sterile. L’esploratrice inglese Anne Blunt lo descrisse nel 1881 come composto da “vasti altipiani di ghiaia, quasi privi di vegetazione come alcun’altra zona del mondo“, costellata di insediamenti occasionali isolati tra essi quasi quanto dal mondo. Era uno dei pochi Paesi del terzo mondo ancora non colonizzato dal XIX secolo, non perché fosse insolitamente forte o ben organizzato, ma perché era troppo povero, selvaggio e inaccessibile per meritarsi uno sforzo. Era una terra che nessun altro voleva. Era anche sede di un’ideologia che nessun altro voleva. L’hanbalismo, la più severa e spietata delle quattro maggiori scuole di giurisprudenza islamica. Sorse a Baghdad nel IX secolo e nel giro di pochi decenni scatenò il caos mentre i seguaci depredavano le case per confiscare liquori, strumenti musicali e altri oggetti proibiti; razziare negozi e molestare uomini e donne che camminano insieme per strada. Espulsi dalla metropoli, gli hanbalisti furono relegati negli avamposti più primitivi e lontani, in particolare il Najd. Ma poi, a metà del 18° secolo, furono attaccati da un predicatore errante di nome Muhamad Ibn Abd al-Wahhab, per il quale l’hanbalismo non era abbastanza severo. Passando da un villaggio all’altro, “il Lutero del maomettanismo”, come lo descrisse Lady Blunt, denunciò pratiche popolari come adorare le tombe dei santi e pregare gli alberi sacri. Teologicamente, il grande contributo di Wahhab era prendere il concetto di shirq, o associazione, che tradizionalmente si riferiva all’adorazione di qualsiasi divinità in congiunzione con Allah, ed espanderlo includendo tutto ciò che distraeva dall’attenzione focalizzata sull’unico vero dio. Cercare l’intervento di un santo, un portafortuna, ciò che adornava persino le moschee, era tutto shirq. L’obiettivo era una religione nuda come il paesaggio, che non permetteva che nulla potesse accadere tra uomo e Dio. Presumibilmente, Wahhab non fu il primo mullah ad inveire contro la superstizione. Ma ciò che lo distinse è l’energia, il fanatismo, si fece un nome ordinando la lapidazione di una adultera, e alleandosi nel 1744 con un capo tribale di nome Muhammad bin Saud. In cambio del sostegno militare, al-Wahhab fornì a bin Saud il mandato legale di rapinare, uccidere o schiavizzare chiunque rifiutasse di inchinarsi alla nuova dottrina. Sostenuto dai fanatici beduini conosciuti come Iqwan, o Fratellanza, Saud e i suoi figli iniziarono a conquistare il deserto.
Era nata una nuova dinastia. L’alleanza saudita-wahhabita costituiva una sorta di “costituzione” in quanto stabiliva le regole base che il nuovo regno avrebbe dovuto seguire. Al-Saud ottenne un’autorità economica e politica senza limiti. Ma il clan acquisì anche l’obbligo religioso di sostenere e difendere la wahhabiya e lottare contro le pratiche che consideravano non islamiche. Nel momento in cui vacillasse, la legittimità svanirebbe. Ciò spiega forza e debolezza dello Stato saudita. A prima vista, il wahhabismo sembrerebbe essere la più indomabile delle ideologie poiché l’unica sottomissione che riconosce è a Dio. Ma dopo essere stati brevemente rovesciati dagli ottomani nel 1818, gli al-Saud poterono riprendere la via solo col sostegno esterno. La sopravvivenza del regime dipendeva quindi dall’equilibrare una feroce dirigenza religiosa con le forze internazionali che, come la dinastia sapeva troppo bene, erano infinitamente più potenti di qualsiasi orda di cavalieri del deserto.
L’ondata di petrolio che investì il regno negli anni ’70 aggravò il problema. Non solo la dinastia al-Saud doveva bilanciare la wahhabiyya cogli Stati Uniti, ma doveva anche bilanciare l’austerità religiosa con il consumismo moderno. Negli anni ’20, i mullah si erano infuriati contro viaggi e telefoni stranieri. Un membro dell’Iqwan una volta colpì persino un servo del re perché andava in bicicletta, che i wahhabiti denunciarono come “carrozza di Satana”. Ma ora i mullah devono fare i conti con Rolls Royce, Land Rover, centri commerciali, cinema, giornaliste e, naturalmente, la crescente ubiquità sessuale. Che fare? La risposta divenne chiara nel 1979, quando si verificarono tre eventi epocali. A gennaio, lo Scià dell’Iran fuggì in aereo verso l’Egitto, aprendo la strada al ritorno trionfante dell’Ayatollah Khomeini a Teheran due settimane dopo. A luglio, Jimmy Carter autorizzò la CIA ad armare i mujahidin afgani, spingendo l’Unione Sovietica ad intervenire alcuni mesi dopo a sostegno dell’assediato governo di sinistra a Kabul. E a novembre, militanti wahhabiti presero il controllo della Grande Moschea alla Mecca, occupandola per due settimane prima di essere scacciati da commando francesi. L’ultimo fu particolarmente sconvolgente perché fu subito evidente che i militanti godevano di un ampio sostegno clericale. Juhayman al-Utaybi, a capo dell’assalto, era membro di un’importante famiglia dell’Iqwan e aveva studiato col gran muftì Abd al-Aziz ibn Baz. Mentre i wahhabiti condannarono l’assalto, le loro lingue, secondo il giornalista Robert Lacey, “curiosamente si trattennero”. Il sostegno alla famiglia reale cominciò a vacillare. Chiaramente, la famiglia reale saudita aveva bisogno di ricucire le relazioni con la wahhabiya mentre bruciava le credenziali islamiche respingendo critiche in patria e all’estero. Dovette reinventarsi Stato islamico non meno militante di quello persiano nel Golfo Persico. Ma il nascente conflitto in Afghanistan suggerì una via d’uscita. Mentre gli Stati Uniti potevano inviare aiuti alle forze antisovietiche, ovviamente non potevano organizzare da soli una jihad adeguata. Perciò avevano bisogno dell’aiuto dei sauditi, che il regno si affrettò a fornire. Sparirono multiplex e presentatrici, e arrivò la polizia religiosa e gli sconti del 75% alla Saudi Arabian Airlines per i guerrieri santi che viaggiavano in Afghanistan via Peshawar, in Pakistan. Migliaia di giovani annoiati e irrequieti che avrebbero potuto causare guai nel regno furono spediti in una terra lontana per creare problemi a qualcun altro. I principi sauditi potevano ancora festeggiare come se non ci fosse un domani, ma ora dovevano farlo all’estero o a porte chiuse a casa. La patria doveva rimanere pura e incontaminata. Era una soluzione pulita, ma lasciava ancora sciolti alcuni nodi. Uno era il problema del ritorno al passato sotto forma di jihadisti induriti che ritornavano dall’Afghanistan più determinati che mai a combattere la corruzione in patria. “Ho più di 40000 mujahidin nella terra delle due sacre moschee“, disse Usama bin Ladin a un collega. Era un’affermazione che non poteva essere del tutto derisa quando le bombe di al-Qaida iniziarono ad esplodere nel regno fin dal 1995. Un altro problema riguardava chi i militanti avevano preso di mira all’estero, un problema che inizialmente non si presentò serio ma che alla fine si sarebbe rivelato assai significativo. Tuttavia, la nuova partnership funzionò brillantemente per un certo periodo. Aiutò il regime di al-Saud a mitigare gli ulama, come sono noti collettivamente i mullah, che videro l’umma, o comunità dei fedeli, assediata su più fronti. Come disse Muhamad Ali Haraqan, segretario generale della Lega mondiale musulmana sponsorizzata dall’Arabia Saudita, già nel 1980: “La Jihad è la chiave per il successo e la felicità dei musulmani, specialmente quando i loro santuari sono sotto l’occupazione sionista in Palestina, quando milioni di musulmani subiscono repressione, oppressione, ingiustizia, tortura e persino campagne di morte e sterminio in Birmania, Filippine, Patani (regione prevalentemente musulmana della Thailandia), Unione Sovietica, Cambogia, Vietnam, Cipro, Afghanistan, ecc. Questa responsabilità diventa ancora più vincolante e pressante quando consideriamo le campagne malvagie intraprese contro l’Islam e i musulmani dal sionismo, dal comunismo, dalla massoneria, dal qadianismo (cioè l’Islam Ahmadi), Bahai e missionari cristiani”. La Wahhabiya avrebbe trascurato i molti peccati dei principi se avessero usato le loro ricchezze per difendere la fede. L’accordo funzionò anche per gli Stati Uniti, che acquisirono un utile partner diplomatico e forza militare ausiliaria oltre che economico, efficace e degna di credibilità. Funzionò per i giornalisti entusiasti che si avventurarono per le terre selvagge dell’Afghanistan, assicurando la gente a casa che i “muj” non erano altro che “gente di montagna che non cede a una potenza straniera che ha conquistato le loro terre, ucciso la loro gente, e attaccato la loro fede“, per citare William McGurn, salito alla ribalta come autore dei discorsi di George W. Bush.
Funzionò per quasi tutti finché 19 dirottatori, 15 dei quali sauditi, lanciarono un paio di aerei di linea carichi di carburante sul World Trade Center e un terzo sul Pentagono, uccidendo quasi 3000 persone. Gli attacchi dell’11 settembre avrebbero dovuto essere il campanello d’allarme su ciò che era andato seriamente male. Ma invece di premere il pulsante pausa, gli Stati Uniti optarono per raddoppiare la stessa vecchia strategia. Dal loro punto di vista, non avevano scelta. Avevano bisogno del petrolio saudita; della sicurezza nel Golfo Persico, del più importante fulcro del commercio globale; e di un alleato affidabile nel mondo musulmano. Inoltre, la famiglia reale saudita era chiaramente nei guai. Al-Qaida aveva ampio sostegno pubblico. In effetti, secondo un’indagine dell’intelligence saudita, il 95 per cento dei sauditi istruiti tra i 25 e i 41 anni aveva “simpatie” per la causa di bin Ladin. Se l’amministrazione Bush si fosse offesa, la Casa dei Saud sarebbe diventata più vulnerabile ad al-Qaida piuttosto. Di conseguenza, Washington scelse il matrimonio piuttosto che il divorzio. Ciò comportò tre cose. In primo luogo, era necessario nascondere il ruolo considerevole di Riyadh nella distruzione delle Twin Towers, sopprimendo, tra le altre cose, un cruciale capitolo di 29 pagine nel rapporto del Congresso che trattava dei legami sauditi con i dirottatori. In secondo luogo, l’amministrazione Bush raddoppiò gli sforzi per incolpare Sadam Husayn, l’ultimo villain du jour di Washington. Servivano “migliori informazioni e in fretta“, ordinò il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld mentre le torri erano ancora in fiamme, secondo le note del collaboratore Stephen Cambone. “…Giudica se è abbastanza buono per colpire SH allo stesso tempo, non solo UBL (cioè Usama bin Ladin). Difficile trovare una buona causa. Serviva agire rapidamente: bisognava trovare un bersaglio a breve termine, e per spazzare massicciamente via tutto, serviva avere qualcosa di utile. Che le cose fossero collegate o no“. Washington aveva bisogno di un disgraziato per salvare i sauditi. Terzo, era necessario perseguire la cosiddetta “guerra al terrorismo”, che non riguardò mai il terrorismo di per sé, ma il terrorismo non autorizzato dagli Stati Uniti. L’obiettivo era organizzare i jihadisti solo per colpire obiettivi decisi congiuntamente da Washington e Riyad. Ciò significava, in primo luogo, l’Iran, la bestia nera dei sauditi, il cui potere, ironia della sorte, era cresciuto dopo l’invasione statunitense dell’Iraq, mutando il Paese precedentemente controllato dai sunniti in un pilastro pro-sciita. Ma significava anche la Siria, il cui presidente, Bashar al-Assad, è un alawita, forma di sciismo, e la Russia, la cui amicizia con entrambi i Paesi disturbava doppiamente Stati Uniti ed Arabia Saudita. Ideologicamente, significava prendere la rabbia wahhabita contro le potenze occidentali come USA, Gran Bretagna e Francia e scagliarla sullo sciismo. Le porte al settarismo furono così aperte.
Il “reindirizzamento”, come il giornalista investigativo Seymour Hersh lo definì nel 2007, funzionò brillantemente per un certo periodo. Hersh lo descrisse come idea di quattro uomini: il vicepresidente Dick Cheney; il neocon Elliott Abrams, all’epoca viceconsigliere per la sicurezza nazionale per la “strategia per la democrazia globale”; l’ambasciatore degli Stati Uniti in Iraq Zalmay Khalilzad; e il principe Bandar bin Sultan, per 22 anni ambasciatore saudita negli Stati Uniti e ora a capo della sicurezza nazionale del regno. In Libano, l’obiettivo era lavorare a stretto contatto col governo del primo ministro Fuad Siniora, appoggiato dall’Arabia Saudita, per limitare l’influenza della milizia sciita filo-iraniana Hezbollah, mentre in Iraq comportava un lavoro ancor più stretto con le forze sunnite e curde per frenare l’influenza sciita in Siria, significava lavorare coi sauditi a rafforzare i Fratelli musulmani, gruppo sunnita in lotta feroce contro il governo baathista di Damasco dagli anni ’60. Infatti un memorandum segreto del dipartimento di Stato del 2006, reso pubblico da Wikileaks, dettagliava i piani per incoraggiare i timori sunniti su una crescente influenza sciita, pur ammettendo che tali preoccupazioni erano “spesso esagerate”. Il programma di “reindirizzamento” presto esplose. Il problema iniziò in Libia, dove Hillary Clinton passò gran parte del marzo 2011 a persuadere il Qatar ad unirsi all’azione contro l’uomo forte Muammar Gheddafi. L’emiro Tamim bin Hamad al-Thani alla fine accettò e ne approfittò per inviare 400 milioni di dollari ai gruppi ribelli salafiti che procedettero a rovesciare il Paese. Il risultato fu l’anarchia, eppure l’amministrazione Obama rimase muta per anni. In Siria, la Defense Intelligence Agency decise nell’agosto 2012 che “gli eventi prendevano una chiara direzione settaria”; che i salafiti, i Fratelli musulmani e al-Qaida “sono le principali forze che guidano l’insurrezione“; e che, nonostante tale ondata fondamentalista, occidente, Turchia e Stati del Golfo sostenevano ancora la rivolta anti-Assad. “Se la situazione si risolve”, proseguì il rapporto, “c’è la possibilità di stabilire un principato salafita dichiarato o meno nella Siria orientale… e questo è esattamente ciò che vogliono le potenze che supportano l’opposizione, al fine d’isolare il regime siriano, considerato profondità strategica dell’espansione sciita...” La Siria orientale, ovviamente, divenne parte del Califfato dichiarato dallo SIIL, destinatario del supporto finanziario e logistico clandestino di Arabia Saudita e Qatar, secondo Hillary Clinton nel giugno 2014.
La guerra al terrore divenne la via più lunga possibile tra terrorismo sunnita e terrorismo sunnita. Ancora una volta, gli Stati Uniti avevano cercato di usare il wahhabismo a proprio vantaggio, ma con conseguenze che si rivelarono nientemeno che disastrose. Cosa andò storto? Il problema è duplice. Il wahhabismo è un’ideologia di fanatici beduini che possono essere esperti nel conquistare i compagni delle tribù ma incapaci di governare uno Stato moderno. Nulla di nuovo. È un problema discusso da Ibn Qaldun, il famoso scienziato nordafricano del 14° secolo, e da Friedrich Engels, collaboratore di Marx, alla fine del 19°, ma la linea di fondo è un ciclo infinitamente ripetitivo in cui i fanatici nomadi si sollevano, rovesciano un regime divenuto molle e corrotto, solo per divenire loro stessi molli e corrotti prima di soccombere a un’altra ondata di guerrieri del deserto. Il risultato è anarchia dopo anarchia. L’altro problema riguarda l’imperialismo USA che, in contrasto con le varietà francese e inglese, si astiene spesso dall’amministrazione diretta di possedimenti coloniali e cerca invece di sfruttare il potere degli Stati Uniti con innumerevoli alleanze con forze locali. Sfortunatamente, la leva funziona come la diplomazia e la finanza, cioè da moltiplicatore di guadagni e perdite. Da alleati dei sauditi, gli Stati Uniti incoraggiarono la crescita non solo della jihad, ma del wahhabismo in generale. Sembrava una buona idea quando i sauditi fondarono la Lega mondiale musulmana alla Mecca nel 1962 in contrappeso all’Egitto di Gamal Abdel Nasser. Quindi, come poteva obiettare Washington quando il regno ampliò enormemente il proselitismo nel 1979, spendendo da 75 a 100 miliardi di dollari per diffondere il verbo? Re Fahd, che regnò dal 1982 al 2005, si vantava delle strutture religiose ed educative che costruiva nelle terre non musulmane: 200 college islamici, 210 centri islamici, 1500 moschee, 2000 scuole per bambini musulmani, ecc. Poiché lo scopo era combattere l’influenza sovietica e promuovere la visione conservatrice dell’Islam, le fortune degli Stati Uniti ne ricevettero un’enorme spinta. Sembrava una buona idea 15 o 20 anni fa. Poi le bombe iniziarono a esplodere, gli attacchi dell’11 settembre scossero gli Stati Uniti che si precipitarono nell’inquieto Medio Oriente e il saudismo radicale si metastatizza oltre il terreno di coltura. Le fortune degli Stati Uniti non sono più state le stesse, da allora. Traduzione di Alessandro Lattanzio
Traduzione di Alessandro Lattanzio